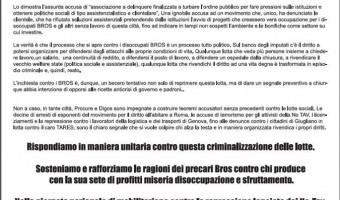I veri eroi sono le masse, mentre noi siamo spesso infantili e ridicoli; se non comprendiamo questo, è impossibile acquisire una conoscenza sia pure rudimentale.
Mao, Prefazione e poscritto a Inchiesta nelle Campagne
L’affermazione che l’Italia moderna è stata caratterizzata dal volontariato è giusta, ma occorre notare che il volontariato, pur nel suo pregio storico, che non può essere diminuito, è stato un surrogato dell’intervento popolare, e in questo senso è una soluzione di compromesso con la passività delle grandi masse. Volontariato-passività vanno insieme più di quanto si creda… [Ma] per costruire storia duratura non bastano i “migliori”.
Antonio Gramsci, Quaderni del carcere1
Summertime and the livin’ ain’t easy…
Sarà che l’estate è da sempre tempo di bilanci, sarà che la quotidianità si interrompe e si può provare a guardarsi da fuori, scoprendosi limiti e possibilità, per imparare da quello che è stato fatto e fare meglio l’anno prossimo…
Oppure sarà che questa estate è quella di un anno denso, di una mobilitazione studentesca sorprendente e radicale, di riot inglesi, di occupazioni, referendum e lotte per la difesa dei territori; un anno che ha visto resistere gli operai FIAT e quelli FINCANTIERI, e anche quelli che non son niente, dispersi nell’indotto di migliaia di fabbriche a nero; un anno di rivolte nei paesi arabi e di guerra imperialista in Libia; un anno che ne ha fatti dieci dal G8 di Genova, interrogandoci sulle forme dell’impegno politico in Italia, chiedendoci cos’era quella voglia di trasformare il mondo e dov’è che si è sbagliato, cosa c’era di buono, e cosa va lasciato alla polvere del tempo…
O, molto più probabilmente, sarà che l’anno non è mai finito: ha macerato la crisi greca ed ha conclamato la crisi dell’Italia, dove nel giro di due mesi è successo di tutto, e dove si prepara una svolta epocale che in pochi mesi cambierà – in peggio, molto peggio – la vita di milioni di persone…
Sarà per tutto questo che vogliamo condividere alcune cose che, dopo l’esplosione di questa crisi, di lotte, di botte, di nostri ed altrui errori – mentre il capitale attacca sempre più velocemente, scompone, riconfigura, opprime –, forse abbiamo capito. Banalità, certo, nessuna verità rivelata. Solo qualche intuizione che si è fatta strada a poco a poco, un modo di fare, una nuova-pure-vecchissima prospettiva. Tutte cose che abbiamo imparato a nostre spese, scontate ogni giorno nella pratica, e che ora – alla vigilia di un autunno che speriamo e vogliamo caldo, consci che i movimenti e le classi subalterne di questo paese giocheranno in queste settimane una partita decisiva per la loro stessa sopravvivenza – vorremmo provare a socializzare, per evitare ad altri qualche nostro vicolo cieco, per continuare le cose buone fatte insieme, per dare un senso a questi anni.
Ragione o sentimento? Ragione e sentimento!
Queste pagine muovono insomma dalla presa di coscienza di un limite e dalla scoperta di una ricchezza. Il limite è sotto gli occhi di chiunque non si accontenti di fare politica in modo esistenziale, come pura testimonianza o affermazione di un’identità, senza curarsi di quello che davvero riesce ad ottenere, senza nemmeno immaginare di poter vincere. Il limite è cioè quello che ogni studente mobilitato da anni, ogni lavoratore in lotta, ogni indignato di questo paese sa bene: da soli non andiamo da nessuna parte, non riusciamo a sconfiggere i nostri nemici, a coinvolgere i troppi indifferenti, a fare una società più giusta… Questioni semplici ma insistenti, che le formule sempre più immaginifiche dei movimenti possono occultare ma non risolvere.
Ma la ricchezza? Non è che il rovescio di quel limite: è la scoperta che nonostante tutto il lavoro del capitale e dei suoi apparati ideologici – lavoro certosino, scientificamente elaborato, fatto di repressioni, di diversioni, di falsi problemi e di false soluzioni – per impedirci di pensare e agire contro, noi siamo qui ed altri arrivano, eppur si muove, il sistema non riesce a sanare le sue contraddizioni, e quando ci prova mette capo a contraddizioni ancora più grandi. La ricchezza è quindi nel sapere che una chiave esiste, e non solo in un lontano avvenire, ma che già da ora si può mettere in campo un modo di fare le cose che può funzionare. Un modo che altri prima di noi – perché non siamo i primi che si trovano di fronte questi enigmi e, anche se li dovremo interpretare e affrontare a modo nostro, abbiamo dietro un patrimonio di rivoluzioni e rivoluzionari – hanno praticato con pazienza e disciplina. Un patrimonio che non è fatto di eterne sconfitte e della miseria presente, ma di vittorie a cui ci possiamo non solo simbolicamente ispirare, ma che dobbiamo studiare e capire, per incidere davvero nella realtà.
Non ci interessa infatti – ma a quale proletario è mai interessata? – una politica pura nelle intenzioni quanto incurante delle conseguenze, una politica per mettersi a posto la coscienza, fatta di ribellismo o prese di posizione volta per volta, una politica di rapidi entusiasmi ed altrettanto rapide delusioni, a cui spesso fa seguito il riflusso, o addirittura il salto dall’altra parte. La pancia è il sacrosanto inizio, ma per durare, per resistere un minuto più di chi ci comanda, ci vogliono ben altri strumenti.
Insomma è a partire da queste constatazioni, al limite da questi sentimenti, dal pessimismo della ragione e dall’ottimismo della volontà, che ci siamo iniziati a porre domande gigantesche: cosa vuol dire fare politica? E cos’è esattamente la politica, quale il suo spazio? Cosa vuol dire essere un militante qui ed ora? Perché in passato si è vinto ed oggi no? Cosa ci manca? E cosa dobbiamo fare?
Evidentemente, sarebbe presuntuoso ed anche impossibile sciogliere in poche pagine questi problemi. In ogni caso non lo possiamo fare noi, e noi da soli. Allora forse basta, per il momento, mettersi all’altezza di questi problemi, dargli lo spessore che meritano, conoscerne alcune risposte almeno per scartarle. Serve una scorciatoia, serve qualcuno che ci dica qualcosa, sulla nostra storia, sulle forme della militanza, sulle sfide che ci sono davanti. Ed è qui che ci viene incontro Antonio Gramsci.
Antonio uno di noi!
Ma perché proprio lui? Non perché vogliamo rifugiarci dietro la sua autorità, né perché sia stato un grande pensatore. Non ci interessa Gramsci, ci interessa Antonio: l’uomo che è riuscito a connettere la sua cultura e le sue riflessioni con la storia che aveva fatto e vissuto, con i rapporti che aveva intrecciato, con l’affiatamento che aveva cercato di suscitare fra i compagni, con i dilemmi che si era trovato di fronte, nei circoli giovanili socialisti o nei primi gruppi comunisti, davanti all’entusiasmo del biennio rosso o di fronte alla più grande reazione che l’Italia abbia mai conosciuto.
Dilemmi che solo ad uno sguardo superficiale sono incomparabili ai nostri: in realtà leggendo Gramsci vediamo tutti i nostri vizi – l’inconsistenza, la lentezza, le divisioni – e le nostre virtù – la generosità, la decisione di lottare fino al sacrificio, la capacità di sentire il dolore di ogni sfruttato… D’altronde il confronto con i “classici” non fa mai male, e non è necessariamente un processo al nostro agire: è piuttosto una spia dei nostri errori, che ci permette di accentuare la consapevolezza che quello che di buono è stato fatto si può rifare.
Non si tratta quindi di riproporre qualche citazione come una formula magica, perché il senso della politica è anche senso della Storia, del reale e del momento, e nemmeno le categorie sono valide in assoluto, figuriamoci gli slogan. Si tratta invece di riprendere alcune analisi di questo compagno ormai dimenticato dal Movimento e consegnato alle polverose biblioteche di qualche intellettuale o alla memoria istituzionale di qualche svogliato partitino, e leggerlo nel suo essere pensiero vivente, attuale, mettendolo in atto.
Non solo perché l’esperienza politica a cui era legato è stata fra le poche vincenti – cosa che comunque bisogna avere sempre ben presente –, e vincenti proprio contro il fascismo, che ancora oggi è una delle risorse delle “democrazie liberali”… Ma per riappropriarci di un metodo, di cui abbiamo innanzitutto bisogno nel nostro lavoro quotidiano. Ed il metodo è innanzitutto nel partire dal «mondo grande e terribile», dalla complessità del reale, non per cedervi (come vorrebbero molti postmoderni o postqualcosa), ma per individuarne alcuni assi fondanti e seguirli, nel trovare cioè tendenze di lungo periodo sulle quali riscontrare l’analisi dei fenomeni attuali. Con l’obbiettivo di agire in maniera più organizzata e quindi efficace.
Volontari, o quello che siamo
In particolare, per iniziare a rispondere alle domande che ci ponevamo prima, possiamo prendere in considerazione quelle pagine in cui Gramsci analizza il fenomeno del «volontarismo» come modalità tipicamente italiana dell’impegno storico. Detto in breve, il volontarismo indica quella pulsione sociale, ricorrente nella storia del Paese, per cui alcuni individui – i volontari, coloro che sono cioè guidati innanzitutto da una volontà, e quindi da motivazioni arbitrarie, di carattere spirituale, culturale o intellettuale piuttosto che da fattori materiali – aderiscono ad una causa, che cercano con loro impegno esistenziale di far trionfare. Di questa modalità di azione, che Gramsci tende a considerare negativamente, sono esemplari i democratici di Mazzini, i garibaldini, gli arditi della prima guerra mondiale e persino alcune tendenze estremiste della sinistra: tutte espressioni politiche cresciute all’interno di una sostanziale incapacità di mobilitare le masse, di fare blocco con loro, di costruire un solido legame basato su una comunità di destini.
Ora, la cosa curiosa è che nella descrizione gramsciana del volontarismo vediamo la forma di espressione politica all’interno della quale, anche inconsapevolmente, ci troviamo ancora oggi a muoverci. Senza saperlo, come singoli compagni, come collettivi, come centri sociali, ci troviamo ad agire come volontari : singoli votati ad un’ideale, ad una volontà, in sostanza slegati dai movimenti reali del Paese, dalle sue intime necessità, dai bisogni del proprio blocco sociale di riferimento. E quindi incapaci di parlare alle masse, di costruire un rapporto organico con loro, di far emergere da queste stesse masse i propri dirigenti…
È facile verificare queste affermazioni: basti pensare agli ultimi anni. Secondo Gramsci, una fase di crisi (che non è solo economica, ma anche, più in generale, istituzionale e politica) genera uno scollamento delle masse dagli apparati dello stato, e finisce per avere come conseguenza da un lato una passivizzazione delle masse e dall’altro lato un iperattivismo delle minoranze. Non è proprio quello che abbiamo visto dal 2008 in poi, in cui al peggioramento materiale delle condizioni di vita non ha fatto seguito una mobilitazione delle masse popolari, anzi, si sono accentuate le difficoltà di quei collettori come i partiti o i sindacati che pretendevano di guidarle perché, da parte loro, le masse tendono ad essere sempre più sfiduciate e concentrate sull’immediato? E, d’altro canto, nel disfacimento dell’ordine precedente, non abbiamo visto nascere tanti piccoli gruppi, non ne abbiamo visto estremizzarsi altri, non abbiamo praticato un attivismo continuo, quantomai generoso, ma con ben pochi risultati?
Anche senza evocare questi anni di crisi, però, è evidente come sia una costante degli apparati ideologici quella di dissuadere dalla partecipazione politica, di nascondere i nessi fra agire politico e possibilità di una trasformazione del mondo. Dopo la stagione degli anni ’70 e la caduta del Muro si è cercato di relegare sempre di più la partecipazione politica alla pura espressione ideologica, nel senso deteriore del termine, recidendo così ogni collegamento tra un agire (che poi è anche parlare, discutere, partecipare, decidere), e un cambiamento. Così da un lato si è mirato a rendere impossibile o inutile la presa di parola delle grandi masse, d’altra parte si è potuto lasciar strepitare i singoli, senza che ciò avesse conseguenza alcuna.
In Italia questo processo è stato più accentuato, perché si doveva cancellare un’eredità più forte, ed i colpi sono venuti sia da destra che dall’interno stesso della sinistra (anche nel Movimento). Dai partiti e spesso da parte degli stessi movimenti sociali la partecipazione popolare è stata cercata in senso strumentale: non cioè per sviluppare un blocco sociale coeso, autonomo, che potesse esprimere i propri capi in opposizione alla classe dominante, ma per autolegittimarsi, agitando qualche parola d’ordine populista e interclassista, nei propri scopi, che ormai coincidevano sempre di più con una negoziazione del proprio tornaconto personale o di “ceto politico”. Questo mentre altri volontari, meno fortunati o meno ignobili, ripiegavano su una politica puramente resistenziale, della conservazione, della replicazione di se stessi. Finendo spesso in una visione elitaria della politica e nel compiacimento di essere i soli depositari e testimoni di una qualche Verità.
No country for old men
Ma prima di arrivare ad affrettate conclusioni, vale la pena di seguire meglio il discorso di Gramsci. La sua analisi della struttura sociale italiana, della sua sostanziale immutabilità nelle linee di fondo, ci dice infatti che nella storia il volontarismo non è nato da un sentimento di potenza, ma piuttosto dall’impotenza, e che l’elitarismo è una malattia endemica di tutte le formazioni sociali e statali disarticolate ed “arretrate”. In questo senso la vicenda italiana è davvero emblematica, perché presenta tre elementi fondamentali che hanno stimolato la creazione dei volontari, e che a ben vedere – un po’ mutati nella forma – sono presenti ancora oggi:
1) l’apoliticismo e la passività tradizionali nelle grandi masse popolari, che hanno come reazione naturale una relativa facilità al “reclutamento di volontari” […] 2) la costituzione sociale italiana, uno dei cui elementi è la malsana quantità di borghesi rurali o di tipo rurale, medi e piccoli, da cui si formano molti intellettuali irrequieti e quindi facili “volontari” per ogni iniziativa anche la più bizzarra, che sia vagamente sovversiva (a destra o a sinistra) […] 3) la massa di salariati rurali e di Lumpenproletariat, che pittorescamente in Italia è chiamata la classe dei “morti di fame”2.
Questi tre elementi insistono tutti sulla peculiarità del nostro sviluppo storico, che non è riuscito a strutturare una solida società civile ed uno Stato in grado di “assorbire” e “coordinare” sotto una stabile guida le classi subalterne, ma ha determinato la presenza di ampi settori di popolazione poco interessati alla politica come gestione della cosa pubblica; settori di popolazione frammentati, come quelli contadini o proletari, passivi rispetto alla vita comune. A fianco di questa passività, si è sviluppata però nella piccola e media borghesia un iperattivismo che si propone di riscattarla, di rappresentare in modo diretto il popolo o le masse.
Il Risorgimento, il processo costituente dello Stato italiano, ha mostrato questa tendenza al volontarismo in maniera lampante. Mentre le classi borghesi più avanzate “superavano” il programma della Destra reazionaria, cattolica ed ancora feudale, e si raggruppavano intorno a Cavour per esercitare un’egemonia capillare sul resto della società, i democratici mazziniani si agitavano, scrivevano proclami, si muovevano da un capo all’altro della penisola per suscitare rivolte che il Popolo, loro astratto soggetto di riferimento, nemmeno capiva. La stessa cosa fecero i volontari garibaldini: membri di una piccola borghesia che aveva certo degli ideali, ma non un programma concreto di rivendicazioni, non sapendo (né volendo) analizzare le differenze di classe degli “italiani”, e quindi precludendosi un’azione efficace. Gramsci sottolinea come tutti questi eroici tentativi vengano riassorbiti ed anzi persino manovrati dalla borghesia nelle sue differenti sfumature.
Seguendo questi esempi, come non pensare al nostro presente, alla frammentazione in piccoli gruppi che scrivono proclami, che si consumano nella rivolta, senza però alcuna connessione con la parte sommersa del paese, che manco conoscono, e che forse proprio per questo non li segue?
Certo, gli elementi sottolineati da Gramsci (apoliticismo e passività delle grandi masse; composizione della borghesia che genera intellettuali irrequieti disposti ad ogni iniziativa; alta percentuale di sottoproletariato) sembrano eclissarsi dalla Resistenza all’inizio degli anni ’90, nel periodo in cui i bisogni della “modernizzazione” e le lotte dal basso hanno portato all’immissione delle masse nella vita pubblica del paese. Dal ’45 in poi i partiti e i sindacati sono infatti stati utilizzati come mediatori sociali, le loro dirigenze sono state progressivamente cooptate nel tentativo di smorzare le inevitabili tensioni di un capitalismo in sviluppo, e non a caso questa è stata la fase del “compromesso keynesiano” (keynesiano sempre all’italiana, visto che si basava su un sistema fitto di clientele, di corporazioni e di privilegi, su un abnorme sviluppo del settore pubblico e su un welfare applicato su base familiare). Il volontarismo tuttavia rimaneva come un tratto della vita politica italiana, nei suoi frazionismi e trasformismi: si pensi ad esempio alla virulenza degli anni Settanta ed alla successiva, rapida migrazione e integrazione degli “apocalittici” nella classe dominante.
In ogni caso, all’inizio degli anni ’90 – una fase che ha molto a che vedere con quanto sta succedendo in questi mesi –, con il tentativo di drastica transizione verso un capitalismo “puro”, con la rottura del “compromesso”, lo smantellamento del pubblico e la spinta verso processi di mercificazione e individualizzazione, ci si trova di fronte al riemergere di questo sfilacciamento della vita nazionale, di questa incapacità degli apparati dello stato italiano (soprttutto a paragone con gli altri paesi europei) di innervare l’esperienza di larghe masse. Non solo nelle forme del lavoro, ma in diversi ambiti sociali si ritorna ad una situazione ottocentesca, fatta di partiti di notabili, di media controllati, di larghe masse escluse ed indifferenti alla vita collettiva, di singoli intellettuali o di volontari democratico-radicali che aggruppano volta per volta formazioni mobili che muoiono nel volgere di una stagione…
È qui che l’analisi di Gramsci riprende tutta la sua attualità rispetto al periodo precedente che sembrava in qualche modo smentirlo, e oggi sembra acquistare un senso nuovo questo passaggio:
Nell’analisi dei partiti politici italiani si può vedere che essi sono sempre stati di «volontari», in un certo senso di spostati, e mai o quasi mai di blocchi sociali omogenei [… ] Tutti i partiti italiani di «massa» […] non furono tali in realtà (cioè non ordinarono gruppi omogenei sociali) ma furono attendamenti zingareschi e nomadi della politica3.
Questa tendenza che Gramsci leggeva nella storia risorgimentale e post-unitaria, si ripresenta oggi in forme altrettanto acute. In Italia hanno fatto quasi sempre politica gli «spostati», ovvero quei membri della piccola e media borghesia che hanno scelto la via dell’impegno senza essere espressione organica di una classe, ma essendo alla lettera “decentrati”, distanti dal gruppo sociale che intendono rappresentare, e dunque inefficaci rispetto all’obbiettivo che dicono di prefiggersi. Il volontario è infatti «staccato dalla massa per spinta individuale arbitraria e in contrasto spesso con la massa o indifferente per essa», e il volontarismo può essere «un surrogato dell’intervento popolare», una «soluzione di compromesso», ma non può bastare, perché la storia non si fa con i migliori (ammesso peraltro che siano tali)…
Sarà amaro, ma non è difficile per la maggior parte di noi riconoscersi in questa definizione, non vedere che – oltre tutte le buone intenzioni – la nostra aggregazione è quasi sempre ideologica e si basa più su un immaginario ed una rabbia viscerale che su soluzioni concrete e risposte effettive, non vedere come il nostro impegno sia spesso volontario, e che resti appunto estraneo alle dinamiche sociali effettive e lontano dal patrimonio di esperienze quotidiane della classe. Attenzione: non perché noi non viviamo sulla nostra pelle condizioni di lavoro e di vita proletarie, ma perché, anche vivendole, di quella classe non riusciamo ad essere rappresentanti, interpreti, trascinatori.
Arditismo e antifascismo
Ora, proviamo a verificare questo ragionamento applicandolo ad una questione che spesso ci siamo trovati ad affrontare nella pratica, quella della lotta antifascista. Metteremo da parte considerazioni che abbiamo fatto altrove (sulle forme che ha preso oggi il fascismo, su dove e come si esprima)4, e faremo parlare Gramsci.
Secondo lui la maggiore espressione del volontarismo nella vita politica italiana è stato proprio l’arditismo. Con il termine si indica innanzitutto una tattica militare: la costituzione, avvenuta praticamente ovunque durante la Prima Guerra Mondiale, di divisioni speciali che andavano all’assalto delle prime linee nemiche, rischiando la vita. L’arditismo è però una modalità di combattimento che in Italia assume un’immediata valenza politica. Questo perché, lungi dal rappresentare «un segno della combattività generale della massa militare», per Gramsci è da interpretare «come un segno della sua passività e della sua relativa demoralizzazione»5. Così come l’esercito italiano, meno organizzato e preparato di quello francese o tedesco, non era stato in grado di reggere lo scontro ed aveva avuto bisogno di demandare agli arditi la “soluzione” del problema militare, così lo Stato italiano del dopoguerra, incapace di gestire il conflitto sociale, affida agli arditi di tendenze nazionaliste, organizzati come gruppo paramilitare, il compito di schiacciare le manifestazioni operaie e contadine. Di fronte alle squadracce fasciste si sviluppò anche l’arditismo popolare, che Gramsci, diversamente da Bordiga, sostenne, in quanto vi vedeva un primo embrione di milizia proletaria, utile soprattutto per difendere lo spazio fisico della sinistra di classe.
Quello che qui ci interessa non è valutare storicamente il fenomeno, né entrare nel merito dell’arditismo e dei suoi, a volte davvero eroici, esponenti, ma solo riportare ciò che Gramsci scrisse dieci anni dopo, ormai in carcere. Una breve riflessione che collega criticamente l’arditismo al volontarismo, e che in questo senso ci può dare spunti per le lotte di oggi, non solo di quelle antifasciste.
Nella lotta politica non bisogna scimmiottare i metodi di lotta delle classi dominanti, senza cadere in facili imboscate. Nelle lotte attuali questo fenomeno si verifica spesso: una organizzazione statale indebolita è come un esercito infiacchito: entrano in campo gli arditi, cioè le organizzazioni armate private, che hanno due compiti: usare l’illegalità, mentre lo Stato sembra rimanere nella legalità, come mezzo di riorganizzare lo Stato stesso. Credere che alla attività privata illegale si possa contrapporre un’altra attività simile, cioè combattere l’arditismo con l’arditismo è una cosa sciocca; vuol dire credere che lo Stato rimanga eternamente inerte, ciò che non avviene mai, a parte le altre condizioni diverse. Il carattere di classe porta a una differenza fondamentale: una classe che deve lavorare ogni giorno a orario fisso non può avere organizzazioni d’assalto permanenti e specializzate, come una classe che ha ampie disponibilità finanziarie e non è legata, in tutti i suoi membri, a un lavoro fisso. In qualsiasi ora del giorno e della notte, queste organizzazioni, divenute professionali, possono vibrare colpi decisivi e cogliere alla sprovvista. La tattica degli arditi non può avere dunque per certe classi la stessa importanza che per altre; a certe classi è necessaria, perché propria, la guerra di movimento e di manovra, che nel caso della lotta politica, può combinare un utile e forse indispensabile uso della tattica da arditi. Ma fissarsi nel modello militare è da sciocchi: la politica deve, anche qui, essere superiore alla parte militare e solo la politica crea la possibilità della manovra e del movimento [corsivo nostro]6.
Questa riflessione si connette perfettamente a quello che Gramsci ha criticato nel volontarismo risorgimentale. Qui come lì gli attori politici agiscono come una banda, come un gruppo di sodali che non si curano del loro collegamento con l’esterno; qui come lì, la mobilitazione che si prova a suscitare è destinata ad un fallimento, perché:
– la politica non è mai riducibile alla sola parte militare; questa ne è un aspetto, che comunque dipende dalla fisionomia del proprio progetto e dagli scopi che ci si propone. La strategia dei proletari non può essere quella di inseguire i borghesi sul loro terreno, ma quella di costruire spazi di manovra, ovvero un consenso largo ed un’agibilità politica che il fascismo prova a negargli. Non esistono perciò forme di lotta “astrattamente” valide, ma ogni classe ha i metodi di lotta a essa adeguati.
– lo Stato non è mai neutrale: e dunque una guerra fra arditi “di destra” e “di sinistra” non è mai solo una questione privata, ma una guerra sproporzionata, fra un gruppo funzionale allo Stato e persino addentellato dei suoi apparati ed un gruppo di compagni costituito come banda. Senza la politica che crea la possibilità del movimento, si finisce infatti nell’imbuto della repressione.
– la presenza dei gruppi fascisti, con la spinta conseguente ad inseguirli sul piano dello scontro fisico, rappresenta di per sé un’imboscata, un attacco repressivo: i fascisti sono lo strumento che lo Stato (nella sua essenza, come «comitato d’affari della borghesia») utilizza per scompaginare e distogliere i gruppi politici che gli sono contrapposti. Attenzione: non è detto che i gruppi fascisti eseguano ordini espliciti (per quanto siano stati provati storicamente infiniti legami fra il “fascismo di strada” e quello “di governo”), ma la sovradeterminazione si può esplicare in varie forme.
– i fascisti arrivano insomma dove lo Stato non può formalmente arrivare, e servono soprattutto a far perdere tempo, e a far commettere errori, nel mentre che lo Stato si possa riorganizzare, possa individuare e colpire, possa distogliere l’attenzione dai problemi reali ed impedire l’emergere del conflitto di classe.
Insomma, nell’analisi di Gramsci la strumentalità di questi gruppi al mantenimento dell’ordine sociale è evidente, e se si pensa al fascismo del Ventennio o a quello degli anni Settanta (ed anche oggi, più ancora che nelle formazioni dichiaratamente fasciste, al leghismo), è difficile non dargli ragione. D’altronde per Gramsci «il fascismo, come movimento di reazione armata che si propone lo scopo di disgregare e di disorganizzare la classe lavoratrice per immobilizzarla, rientra nel quadro della politica tradizionale delle classi dirigenti italiane»7.
Per questo vale la pena notare come negli anni Settanta davanti alle bombe fasciste i compagni si affannarono non tanto nell’inseguire lo scontro fisico, ma nel mostrare il collegamento diretto fra neofascisti e servizi segreti o pezzi dello Stato niente affatto deviati, e piuttosto che riprendere il mito dell’arditismo popolare o di proporsi come élite della lotta contro un nemico mostruoso, si proponevano di accelerare le connessioni con la classe dandole elementi di politicizzazione reale e trasformando l’attacco fascista in forza collettiva.
Quale volontarismo, quale politica
Tutto questo discorso non mira però a dire che il volontarismo sia inutile, da sminuire o da disprezzare. Al contrario: bisogna riuscire a farne buon uso, bisogna in qualche modo “superarlo” conservandone la tensione, generalizzandola, facendola diventare di massa. Infatti, se il volontarismo è spesso una risorsa e una risposta all’incapacità di essere punto di riferimento – se tende a rivendicare a sé la dimensione pratica, dei “fatti”, mentre in realtà non capisce che la prassi non è una semplice azione, ma un’azione che produce effetti, che misura il piano della sconfitta e della vittoria non sulla taglia del proprio gruppetto, ma nella prospettiva generale – può anche esistere una forma “sana” di volontarismo. Gramsci l’aveva conosciuta, era quella del suo Ordine Nuovo: un gruppo di giovani, per lo più studenti, capaci però di inserirsi nel punto più alto della contraddizione capitale/lavoro e di produrre in breve tempo effetti politici insperati. Questa è la differenza che passa fra l’essere semplici volontari ed essere avanguardia:
Altro è il volontarismo o garibaldinismo che teorizza se stesso come forma organica di attività storico-politica e si esalta con frasi che non sono altro che una trasposizione del linguaggio del superuomo individuo a un insieme di “superuomini” (esaltazione delle minoranze attive come tali, ecc.), altro è il volontarismo o garibaldinismo concepito come momento iniziale di un periodo organico da preparare e sviluppare, in cui la partecipazione della collettività organica, come blocco sociale, avvenga in modo completo.
In realtà, si lotta contro queste degenerazioni di falsi eroismi e di pseudo-aristocrazie, stimolando la formazione di blocchi sociali omogenei e compatti, che esprimono un gruppo di intellettuali, di arditi, un’avanguardia loro propria8. [corsivo nostro]
Non si tratta insomma, di fronte allo scoramento che deriva dalla passività generale, di intendersi come un manipolo di eroi e puntare tutto su un piano dello scontro (che poi nella pratica vuol dire scontrarsi con chi si ha a portata di mano, che quasi mai coincide con chi davvero bisogna affrontare). Oppure – siccome negli anni si è rinunciato allo scontro fisico, troppo “pericoloso” e comunque compromettente per chi si voleva ricavare una qualche poltrona – spostare lo scontro su un piano estetico o simbolico, che galvanizzi i propri “fedeli”, anche se questo piano non tocca minimamente i fatti reali, anzi deprime chi da fuori guarda a questa protesta come un gioco delle parti o una semplice rappresentazione del conflitto senza ricadute concrete9…
Il punto ovviamente non è di rinunciare al piano dello scontro o al piano dell’elaborazione simbolica e della diffusione mediatica, scartarli o accettarli tout court, ma andare a vedere ogni volta se l’uso di questi strumenti interpreta un sentimento di massa, permette di creare un pubblico che ascolti le rivendicazioni comuni, dica qualcosa a qualcuno, suscitando sì emozioni ma inculcando anche elementi politici, in particolare mostrando chi sono gli amici e chi i nemici e da quale parte della barricata bisogna stare per difendere i propri interessi materiali. Lo scontro, di piazza o mediatico, è sempre da assumere quando è comprensibile ai più, quando è cassa di risonanza per i propri contenuti, ed è da scartare quando mette in scena solo la nostra impotenza o la nostra pochezza.
In questo senso secondo Gramsci si tratta di intendersi, viversi e quindi agire come se si fosse un momento iniziale (quindi non residuale, e nemmeno imprigionato nell’estasi dell’istante dell’azione, ma un momento in una fila di anni, decenni, un lavoro lungo, dettagliato e laborioso) di una fase in cui la partecipazione del proprio blocco sociale avverrà in modo completo. Per questo non esistono scorciatoie: per fare storia duratura non bastano gli eletti o autoeletti: la soluzione, che poi non è niente di più dell’indicazione di un problema, è che bisogna cercare un collegamento organico con le masse, che bisogna cercare di farle partecipare, sin da subito, in prima persona.
Come lo si può fare? «Stimolando la formazione di blocchi sociali omogenei e compatti»… Ma che vuol dire? Che la classe, il proletariato, il nostro soggetto di riferimento, non è lì come una miniera da cui si possa sempre estrarre oro: è una realtà sociale in perenne mutamento, sfiancata dal potere economico e politico, che la modifica, la disgrega, ne attacca la coscienza ed il senso di appartenenza. La classe esiste, eppure va fatta, resa omogenea contro le classi dominanti che provano sempre a sussumerla, a farle credere che esista in qualche modo una comunanza di interessi fra noi e loro. Ma questo non lo si fa solo con i volantini, con le prediche dall’esterno, ma con una presenza all’interno delle lotte, chiarendo ogni esperienza quotidiana e facendola distillare nell’ostilità a chi ci comanda, creando ambiti in cui a discutere siano gli stessi lavoratori e proletari. Un lavoro difficilissimo, quello di diffondere coscienza di classe, quello di ritracciare una linea politica fra amici e nemici (oscurata dopo tanti anni di opportunismi e di fantasiose teorie), che siamo ben lontani dall’aver cominciato.
In conclusione…
Se ora, riprendendo le domande iniziali alla luce dei suggerimenti di Gramsci, ci chiediamo cosa vuol dire fare politica, come essere militanti in Italia nel 2011, sappiamo forse meglio come rispondere: che la nostra politica è lo sforzo di cambiare i rapporti di forza a favore della classi subalterne, che per farlo deve conoscere a fondo chi è il proprio soggetto di riferimento e lo deve contrapporre senza tregua alle classi dominanti, dimostrandone l’incompatibilità, che questa politica può riuscire solo se costruisce un consenso largo intorno alle proprie opzioni e rifugge dalle vocazioni minoritarie, e che questo consenso lo deve costruire non stemperando i propri contenuti, ma attraverso la propria autonomia e le proprie vittorie, incutendo finalmente paura alla controparte.
Però, prima di tutto questo, Gramsci ci ha ricordato anche un’altra cosa, che il G8 di Genova ancora testimonia, e che questa celebre frase di Walter Benjamin sintetizza benissimo: «la tradizione degli oppressi ci insegna che lo “stato d’eccezione” in cui viviamo è la regola. Dobbiamo giungere a un concetto di storia che corrisponda a questo. Allora ci starà davanti, come nostro compito, di suscitare il vero stato d’eccezione, migliorando così la nostra lotta contro il fascismo»10. Che vuol dire? Che, anche se non la vediamo, perché l’ideologia dominante la scherma, le nostre società sono travagliate da una violenza invisibile quanto unidirezionale, delle classi dominanti contro i subalterni; gli oppressi, in qualsiasi quartiere o banlieue, in qualsiasi fabbrica o call center, sanno che per loro non c’è stato di diritto o normalità, ma solo emergenza, straordinario, strappo alla regola, coercizione. «Dobbiamo giungere ad un concetto di storia che corrisponda a questo», dice Benjamin: dobbiamo cioè assumere nella nostra vita questo conflitto, ma non per dire: “non c’è tempo da perdere”, e buttarci così in ogni cosa che succede, in un attivismo esasperato, disperdendoci senza arrivare a niente. Ma proprio per recuperare tutta l’importanza della dimensione storica e, come nelle guerre, pianificare le offensive, capire dove colpire, incrementare i propri armamenti e le proprie riserve di uomini. Solo a questo punto – prima sono chiacchiere da bar – troveremo il compito di «suscitare il vero stato di eccezione», cioè di poterci di nuovo pulire la bocca con la parola “rivoluzione”…
Nel frattempo, capire che intorno abbiamo uno stato d’eccezione – e quest’estate, ancora una volta, l’ha dimostrato – non ci condanna necessariamente ad essere assediati, al contrario, ci potrebbe migliorare: farci essere più leali, più aperti al confronto, più attenti alle cose importanti e meno gelosi e formali. È facendosi carico di tutta questa serietà – ma chi l’ha mai detto che sarebbe stato facile? – che non saremo più volontari, ma una vera e propria forza politica, capace di scrivere un altro futuro.
NOTE
1 Volontari e intervento popolare, Q XIX (nell’edizione Editori Riuniti di Platone-Togliatti che citeremo il brano si trova nel volume Il Risorgimento a p. 205).
2 Volontarismo e masse sociali, Q XIII, Il Risorgimento, p. 246.
3 Ibidem.
4 A questo proposito rimandiamo a Vuoti di memoria – fascismo e (non) nuovi fascismi, pubblicato su “la Contraddizione”, n°130; Perché un Dossier su Casa Pound Napoli? Intervista al Cau della rivista “Senza Censura”; Dossier Casa Pound Napoli: chi sono, che fanno, che legami hanno, a cosa servono i “fascisti del terzo millennio”; Borghezio: lezioni di fascismo. Tutti i testi sono disponibili sul sito caunapoli.org sezione ANTIFASCISMO.
5 Arte militare e arte politica, Q I, Note sul Machiavelli, sulla politica, sullo stato moderno, p. 78. «Ancora degli arditi. I rapporti che esistettero nel ’17-18 tra le formazioni di arditi e l’esercito nel suo complesso possono portare ed hanno portato già i dirigenti politici ad erronee impostazioni di piani di lotta. Si dimentica: 1°) che gli arditi sono semplici formazioni tattiche […] 2°) che non bisogna considerare l’arditismo come un segno della combattività generale della massa militare, ma viceversa, come un segno della sua passività e della sua relativa demoralizzazione».
6 Ibidem.
7 Il fascismo e la sua politica. Dalle Tesi approvate dal congresso del Partito Comunista d’Italia a Lione (gennaio 1926) (cfr. Sul Fascismo, a cura di Enzo Santarelli, Editori riuniti, Roma 1973).
8 Machiavelli. Volontarismo e garibaldinismo, Q XIV, Il Risorgimento, p. 247.
9 Qui si vede come tutta la “critica” gramsciana possa e debba investire anche l’esperienza del movimento no global, in particolare di quello italiano, che è stato per molti aspetti movimento di “volontari”. Per un bilancio di quell’esperienza vedi anche E. Quadrelli, Cogliere l’occasione! Genova 2001- Genova 2011. Note per una lettura globale della fase imperialista, quaderno a cura dell’Associazione Marxista Politica e Classe.
10 W. Benjamin, Sul concetto di storia, Torino, Einaudi 1997, p. 33 (tesi ottava).
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa