La letteratura internazionale sulla crisi, sulle sue cause e sulle soluzioni possibili alla stessa, da anni è cresciuta poderosamente. In Italia, come al solito, siamo molto indietro (sebbene non proprio al palo). Soprattutto, manca una diffusa letteratura eterodossa, radicale, marxista che tematizzi ed analizzi le attuali dinamiche di crisi (tra i più recenti v. L. Vasapollo, R. Martufi, J. Arriola, “Il risveglio dei maiali”, Jaca Book, 2011).
Vladimiro Giacché è sicuramente uno dei più lucidi analisti economici e critici dell’economia politica. Con evidenti doti anche sul piano della scrittura e della divulgazione. Il libro è uno dei rari esempi di come si possa produrre letteratura scientifica di divulgazione orientata politicamente in termini eterodossi, critici. Un testo leggibile da chiunque, anche dai non addetti ai lavori, anche da chi è a digiuno (quasi) completo del linguaggio e delle conoscenze della ‘scienza triste’. Con puntualità e buona cadenza anche narrativa, l’A. ricostruisce le varie fasi della attuale crisi mondiale, individuandone le cause strutturali e quelle congiunturali, per poi addentrarsi nel vivo della crisi europea, con specifico riguardo ai lidi caldi della Grecia ed ai problemi italici. Il processo di finanziarizzazione spinta degli ultimi decenni è ben descritto, con il suo corollario di transizione ad una economia fondata sul debito, dati gli scarsi livelli di crescita e di saggio di profitto. Proprio quest’ultimo tema, il declinare del saggio di profitto soprattutto nelle economie occidentali, sebbene sia richiamato più volte, tuttavia, non viene studiato ed analizzato più nello specifico (al di là dei rimandi a testi specifici come quelli di Andrew Kliman ed al lavoro collettaneo di Li, Xiao e Zhu).
Il libro può essere considerato un’ottima introduzione allo studio della crisi, un conciso ma denso ‘manualetto’ per orientarsi sui temi della crisi, del debito sovrano, della finanza, del capitale fittizio ecc. In questo, la capacità di saper lavorare sia sulla/con la letteratura mainstream che con quelle eterodossa è sicuramente da apprezzare e sottolineare.
Ciò che lascia perplessi, tuttavia, è la parte finale, quella dedicata alle prospettive politiche, rectius, di politica economica. La ‘ricetta’ illustrata dall’autore. non solo risulta essere abbastanza fumosa (il che, data la natura del libro può anche starci), ma sembra non andare oltre una mera riproposizione delle politiche keynesiane della migliore tradizione. Una proposta politico-economica, sia ben chiaro, più che legittima, che suscita il interesse, ma che sembra entrare in stridente contraddizione con una impostazione di fondo che nei lavori di Giacché (in verità molto meno in questo libro) emerge: le contraddizioni del modo di produzione capitalistico sono insanabili e la crisi attuale è strutturale nella misura in cui è frutto della tendenziale caduta del saggio di profitto. Ora, se le contraddizioni di fondo dell’economia capitalistica sono insanabili, se le politiche keynesiane (quando funzionano) ottengono risultati positivi nel breve-medio periodo, quali sono le prospettive per il lungo periodo? Un’esplosione delle contraddizioni su scala ancora più vasta ed a livelli di intensità superiori? Oppure la proiezione in una dinamica di ‘riforme strutturali’ può bilanciare ed attenuare queste contraddizioni, in una dimensione di ‘economia mista’ (reclamata dall’autore.) che sappia bilanciare le esigenze della pianificazione con quelle del mercato? Il futuro dell’umanità, in definitiva, è ‘nel’ capitalismo, oppure in una ‘fuoriuscita’ dal capitalismo? L’autore. si focalizza evidentemente sulla dinamica di breve-medio periodo, non assumendo alcuna presa di posizione su prospettive di transizione postcapitalistiche. Ma, ovviamente, sul tema il dibattito è tutto da venire…
V. Giacché, Titanic-Europa. La crisi che non ci hanno raccontato, Aliberti, 2012 € 14,00
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa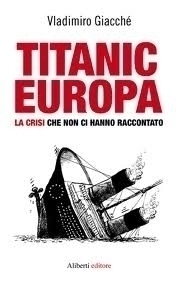





Biagio Borretti
Grazie per la precisazione (posso garantirti che non avevo sottovalutato il passaggio che hai gentilmente riportato). Resta però il problema strategico della dimensione politica sul “lungo periodo”.
Ciò che mi lascia tuttavia maggiormente perplesso è proprio il riferimento all’esperimento cinese ed alla sua “economia mista”. Ora, è fuor di dubbio che la Cina negli ultimi decenni abbia raggiunto traguardi di crescita incredibili, anche inimmaginabili, aprendosi al mercato e pur mantenendo un certo intervento nell’economia. Il problema è comprendere quali sono state le leve principali che hanno consentito alla Cina di crescere a quei ritmi. Dal ’78 in poi, dalle prime ZES fino alle “aree regionali” aperte ai capitali stranieri (dapprima asiatici e poi occidentali), è la “costa” che ha trainato la Cina verso la crescita che tutti conosciamo. Ma come? Lì l’intervento dello Stato, degli enti territoriali e delle agenzie locali di governance (ché le amministrazioni delle ZES tali possono essere intese) hanno da un lato spinto sul fronte della deregolamentazione spinta del mercato del lavoro (dopo aver creato un mercato del lavoro), dell’offerta delle “tax holidays” e di tanti altri benefici al capitale, e dall’altro investito sulle infrastrutture (per agevolare la costruzione di quei “laboratori del capitalismo” che poi si sono estesi geograficamente). In quelle aree è stata (lo è tuttora) la legge della concorrenza capitalistica più spietata (sia sul fronte del capitale che soprattutto del lavoro) ad essere stata sperimentata, coccolata, stimolata. Le politiche dello Stato si riducono (quando tutto va bene) a quel tipo di “programmazione” debole (diversa dalla pianificazione) di tipo indicativo che già in occidente è stata sperimentata qualche decennio fa. D’altronde, proprio il successo della crescita cinese, prima ancora che sulla politica delle “porte aperte”, si fonda sulla de-collettivizzazione delle campagne e sull’aggressione violenta al patto della “ciotola di ferro” che aveva garantito alla classe operaia “statale” di beneficiare di un certo welfare state (a discapito dei contadini e dei braccianti). Insomma, il successo della Cina coincide con l’aggressione alla dimensione dell’intervento pubblico e statale nell’economia. Siamo sicuri che il modello cinese possa essere un punto di riferimento col quale confrontarsi? (La stessa tesi di Arrighi nel suo “Adam Smith a Pechino” la ritengo assolutamente debole proprio perché non considera il corso che ha intrapreso lo sviluppo e la crescita della Cina negli ultimi decenni).
Le “strutture sociali di accumulazione” in Cina mi sembrano molto più guidate dalle leggi del mercato selvaggio piuttosto che da una incisiva presenza dello Stato nell’economia.
Detto questo, il lavoro di confronto con quanto “è stato” ed “è” sarà sicuramente utile ed ancora molto lungo così come sull’utilità e la praticabilità o meno della pianificazione. Come giustamente dici tu, c’è molto lavoro per tutti.
Vlad
Caro Biagio, secondo me sulla Cina le cose stanno in maniera molto diversa da come ritieni. La Cina, molto semplicemente, ha dovuto accettare le regole vigenti nel mercato mondiale. Ma il peso del settore pubblico è aumentato e non diminuito nell’economia cinese, come prova tra l’altro il fatto che l’80% delle imprese quotate a Shangai sono di proprietà pubblica. Tanto da impensierire l’economist, che ha dedicato allo “state capitalism” un interessante inserto tre settimane fa. La Cina non può essere un modello (come non avrebbe dovuto esserlo l’Urss). Se non da un unico, ma importante punto di vista: il PCC ha dato prova di saper imparare dagli errori del passato (rivoluzione culturale inclusa). E’ questa capacità di autocorreggersi che forse farebbe bene anche ai comunisti in occidente. Per il resto, non è importante la soluzione (e infatti loro stessi parlando di socialismo con caratteristiche cinesi proprio per questo), ma il problema. Che, ripeto, per me è quello di trovare il rapporto giusto tra Stato (=potere collettivo dei mezzi di produzione) e mercato. E’ ovvio però che se si traccia la doppia equazione economia mista = capitalismo in stile IRI e intervento dello Stato nell’economia = keynesismo si perde tutto il significato di questa sperimentazione/studio/lotta per un diverso modello sociale tutto da costruire che per me è necessaria. Forse è più semplice. Ma è un modo di semplificarsi le cose che non trovo particolarmente produttivo né sul piano teorico né su quello politico.