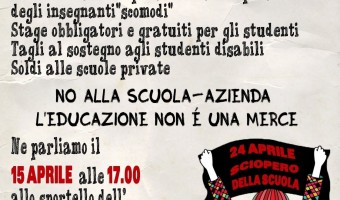Questa analisi, datata al 7 gennaio 2011, mostra come si possa raggionare “strutturalmente” su ciò che accade e fare ragionevoli previsioni, senza farsi sorprendere dagli eventi. Certo, fare sindacato e imbastire una resistenza significativa, richiede prassi e capacità organizzative. Ma si parte dalla comprensione della direzione che vanno prendendo i processi in atto, individuando i “segno caratteristici” dei fenomeni del presente che cambiano la natura delle relazioni sociali.
Il testo era apparso in gennaio sulla lista “Marxiana”.
*****
Il golpe di Natale
Francesco Piccioni
Il Natale 2010 verrà ricordato nella storia italiana come la data spartiacque tra un mondo del lavoro dotato di alcuni diritti regolamentati e un altro totalmente privo. Tra un mondo palesemente imperfetto e pieno di ingiustizie intollerabili, contraddizioni evidenti, squilibri gravissimi; e un «nuovo mondo» ideato a tavolino nell’intento di azzerare la possibilità stessa che insorga persino il normale conflitto di interessi tra aziende e dipendenti. Un mondo in cui c’è una sola voce, quella dell’impresa.
Il cosiddetto «accordo» per Mirafiori perfeziona il «modello Pomigliano» rinunciando a ogni parvenza di «eccezionalità». Ne viene anzi rivendicato il carattere fondativo di un altro ordine. Al di là dei dettagli (orari, turni, pause, ecc; gli unici su cui, non a caso, si soffermano i media principali) è un «accordo» soltanto politico. Il suo obiettivo dichiarato è infatti l’eliminazione di ogni difesa individuale e collettiva da parte dei lavoratori, di ogni loro ruolo indipendente nel processo produttivo. Perché ciò sia possibile va sradicata la presenza di qualsiasi sindacato che non si riconosca pienamente nella logica dell’azienda, nei suoi obiettivi e priorità. Fino all’impedimento fisico-giuridico dell’agibilità sindacale e della candidatura per delegati «non normalizzati».
Va perciò intanto sottolineato come in questo nuovo mondo forgiato dalla «libertà di competere» un solo soggetto sociale sia privato della «libera scelta»: la forza lavoro. Detto altrimenti, un solo ambito viene sottratto normativamente alla «logica di mercato»: quello della rappresentanza sindacale (e politica).
Quell’»accordo» è un mostro giuridico ideato giocando su vuoti legislativi del diritto societario e nella perdurante assenza di una legge sulla rappresentanza sindacale (comprensiva delle modalità di validazione di accordi e contratti collettivi).
Di fatto si tratta di un accordo «di stabilimento» che segue la logica delle scatole cinesi finanziarie più che la prassi industriale. La Fiat, infatti, realizza una newco ad hoc per ogni sua esigenza locale, frammentando la propria configurazione societaria come in un gioco di specchi, ma senza mettere mai in discussione l’unità della proprietà. Anzi, proprio questa frammentazione solo formale è pensata come condizione per realizzare l’identico modello di relazioni industriali, qualsiasi sia il paese dove lo stabilimento sorge. Per imporre una radicale discontinuità nei rapporti regolamentati con la forza lavoro la Fiat passa dunque attraverso la rottura formale della continuità aziendale, mantenuta – come detto – dalla pura identità proprietaria.
Sul piano giuridico si tratta di un trucco da legulei che pobabilmente in altri paesi non verrebbe tollerato neppure dai governi più conservatori e che fa dell’Italia – ancora una volta – il laboratorio degli orrori in cui sperimentare i buchi neri della storia della civiltà (è già avvenuto con il fascismo, va ricordato). Un escamotage ideato per restare fuori dalla legislazione nazionale e violarne in modo dichiarato la Costituzione. Il diritto di sciopero individuale lì garantito, infatti, significa che lo sciopero è «non sanzionabile» oltre l’ovvia trattenuta sullo stipendio. Il Lingotto ha fatto invece della licenzialibilità a seguito dello sciopero l’architrave del testo sottoposto a firma obbligatoria. Di più: pretende che gli stessi lavoratori dichiarino con «referendum» di rinunciare i propri diritti legali e costituzionali. Il «fascismo Fiat» ha insomma ritrovato vigore, riscoprendo sotto la retorica della «modernità» una mai sopita voglia di revanche reazionaria tipicamente sabauda condita in salsa statunitense.
E’ anche un mostro contrattuale. Trasforma infatti ogni relazione tra soggetti industriali in un rapporto individuale, senza riferimento al «mondo fuori» il perimetro dello stabilimento. Il che rende questa frazione di impresa una «monarchia» a sè stante, quasi indifferente al regime politico circostante. Che anzi mira a sovradeterminare, trasformandolo. A rimetterci non sono soltanto i lavoratori e le loro organizzazioni. Anche per gli imprenditori in genere svanisce quasi totalmente la necessità – e la possibilità – di dotarsi di una struttura associativa. Confindustria esce tendenzialmente destrutturata da questa decisione, dal momento che divarica tendenzialmente all’infinito le differenze interne al mondo imprenditoriale: da un lato chi può permettersi di minacciare «o come dico io oppure me ne vado», dall’altro chi per motivi magari diversi non può farlo (non solo piccole imprese; per esempio il settore turistico, l’alimentare di qualità o l’industria estrattiva).
Si può quindi dire che ci troviamo davanti all’applicazione di una particolare strategia di uscita dalla crisi: quello dell’azienda globale senza vincoli nazionali o territoriali, senza alcuna «responsabilità sociale», che punta a trovare i luoghi di insediamento di maggior vantaggio, giocando su processi produttivi standardizzati al massimo e condizioni locali differenziate (livelli salariali, flessibilità, aiuti di stato come negli Usa o in Serbia, libertà sindacali, ecc). Ma è una strategia individuale, non applicabile dal complesso delle imprese. Non c’è dubbio, comunque, che apra una slavina «competitiva»: tutte le imprese italiane vorranno altrettanta libertà d’arbitrio sui propri dipendenti, anche se – e forse soprattutto se – non in grado di delocalizzare.
Infine, costituisce un precedente storico per l’Europa e il suo «modello sociale» in piedi da 65 anni. E ne prescrive la distruzione. Più nessun «patto tra produttori», nessuna mediazione sociale, nessuna democrazia neppure formale sui luoghi di lavoro. Se mettiamo in relazione questo passaggio con il contemporaneo smantellamento del versante pubblico del «patto tra produttori» (ovvero il welfare state) abbiamo una visione approssimativamente esatta – per quanto agghiacciante – del prossimo futuro implicito in questo salto di continuità.
Marchionne sfrutta al meglio sia la crisi economica che la distruzione del potere del lavoro messa in pratica per 30 anni. La prima crea debolezza contrattuale negli occupati (esercito salariale di riserva in espansione), costretti a mettere in alternativa mantenimento del posto e condizioni di lavoro. Ma arriva alla fine di una lunga opera di smantellamento delle difese legislative del lavoratore. Si può tranquillamente risalire all’abolizione del punto di scala mobile, nel 1984, e tracciare una strada che passa per il «pacchetto Treu» (che legalizza per la prima volta forme contrattuali precarie non legate alla «stagionalità»), la «legge 30» (che le estende anche oltre le possibilità di utilizzo da parte delle imprese), fino al «collegato lavoro» (che impone – tra le altre cose – fin dal momento dell’assunzione la rinuncia al ricorso alla magistratura in caso di controversie con l’azienda) e al promesso «statuto dei lavori» (la cui bozza prevede di sostituire pressoché del tutto «la legge» con la «contrattazione tra le parti», fisiologicamente impari).
Sul piano sindacale, il «piano Marchionne» ha affondato nel burro di strutture spappolate da almeno due decenni di «consociativismo», nel corso dei quali è stata selezionata una burocrazia adatta alla trattativa purchessia e ormai avversa a qualsiasi pratica conflittuale. Il ventennio berlusconiano ha accentuato le caratteristiche «politiche» delle strutture confederali classiche, differenziandole alla fin fine solo per il grado di vicinanza o meno ai governi in carica, non più per la rappresentanza reale – per quanto «mediata» e depotenziata – dei lavoratori. Il Lingotto impone perciò la sua discontinuità a una galassia frantumata, composta da sindacati «complici» in senso stretto e una Cgil quantomeno immobile, in piena crisi di prospettive e interlocutori.
Lo scenario futuro sul piano sindacale
Siamo davvero nel «dopo Cristo». Da qui in poi, entro il modello di relazioni industriali che si andrà espandendo, si danno solo due modelli di sindacato. L’unica incertezza o variabile è costituita dal livello di resistenza sociale che questo «modello» incontrerà nei prossimi mesi. Ma anche il grado più elevato di resistenza, che è quanto ci auguriamo, contribuirà a definire (certo in meglio) i due unici sindacati possibili.
Da un lato quello «di regime», controllore e garante del «consenso dei lavoratori». A questo viene garantita la presenza dentro l’azienda, il compito di nominare i «delegati» (non più eletti e riconosciuti dai lavoratori, ma funzionari-kapò incaricati di «fluidificare» ogni inevitabile frizione con la forza lavoro). Di fatto, diventa un’articolazione dell’»ufficio del personale». Ma dovrà anch’esso pagare un prezzo salato alla nuove condizioni: se la funzione del «sindacato di regime» è quella di dire sì a ogni scelta aziendale, infatti, non occorre davvero che ce ne siano quattro o più. Ne basta uno, e anche «snello». Prevedibile quindi il «dimagrimento forzato» degli apparati burocratici e la loro fusione in un unico organismo.
L’altro sindacato possibile è solo quello organizzatore diretto e rappresentante dei lavoratori, conflittuale per condizioni oggettive anche al di là di convinzioni, abitudini, storia. E’ un antagonista oggettivo, fuori dai tavoli di trattativa, strangolato economicamente e costretto a raccogliere una per una le quote tra i lavoratori, che dovrà con tutta probabilità ricominciare a valutare caso per caso se render noti o no i propri iscritti per non esporli alla rappresaglia aziendale. E’ un sindacato, va sottolineato, ancora tutto da costruire sul piano teorico, strategico e organizzativo. Anche se ne esistono diversi nuclei costitutivi, identificabili facilmente a partire dai momenti di resistenza sociale nelle fabbriche, negli uffici, nello stesso spazio del crescente disagio sociale caratterizzato dalla precarietà.
In questo modello di relazioni industriali non c’è più spazio logico e politico per la Cgil attuale, non per caso paralizzata e alla disperata ricerca di una «sponda»; in Confidustria, addirittura. E’ dunque abbastanza prevedibile una divaricazione crescente e irreversibile tra chi non sa immaginare altra esistenza se non «dentro» il cerchio di una concertazione ormai archiviata e chi si pone, con più o meno coerenza o lungimiranza, il compito pratico di organizzare e difendere i lavoratori.
Oltre le colonne d’Ercole del «consociativismo» si è sviluppata fin qui la non piccola galassia del sindacalismo di base. Frammentata e disomogenea per esperienze, linee politiche, settori di intervento (prevalentemente «pubblico impiego») e decisamente carente di visione strategica e perfino di «spirito unitario», nonostante un ancora iniziale processo di convergenza. Anche e soprattutto qui (per l’esperienza maturata stando «fuori» dalla logica concertativa) la discontinuità avviata dalla Fiat pone immediatamente problemi che chiedono soluzioni adeguate, rapide, aggreganti, mai neppure immaginate. Qualsiasi tentazione di «stare ad aspettare» l’inevitabile dissoluzione del sindacato confederale nell’illusione di ricavarne un (modesto) incremento di presenza sarebbe fatale. Stiamo tornando alle condizioni degli albori del movimento operaio, «senza patto né legge», quando l’unico metro di misura erano i rapporti di forza: ovvero il numero di lavoratori che si organizzano direttamente. Non c’è insomma più, in prospettiva anche abbastanza ravvicinata, lo spazio logico e politico per rappresentanze sindacali «di nicchia». Per il buon motivo che, dentro l’eliminazione della mediazione sociale figlia del «modello europeo», non saranno più tollerate (e tantomeno riconosciute) nicchie alternative. La traiettoria della Fiom è in questo senso paradigmatica del «nuovo ordine» padronale.
Quali forme di lotta nel nuovo scenario? Qui, rimandando necessariamente allo sviluppo delle pratiche concrete nel nuovo scenario, ci limitiamo a evidenziare un nodo teorico con immediate ricadute nella prassi: la crisi aveva già depotenziato molto l’arma dello sciopero. Se la produzione è in calo per mancanza di domanda, bloccarla non danneggia più di tanto il padrone.
Il «modello Pomigliano» addirittura criminalizza lo sciopero, facendone motivo di licenziamento. Di fatto, dunque, diventa in prospettiva possibile solo se l’adesione sfiora la totalità degli addetti. Solo se è, insomma, una risposta politica di classe, più che uno strumento contrattuale.
Non è uno scenario inedito, ma guai a cercare risposte solo nella storia.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa