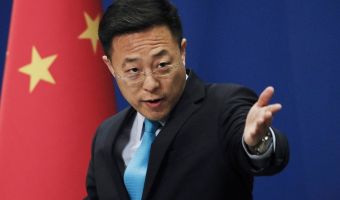Michelangelo Cocco
INVIATO NEL GUANGDONG (CINA)
Settima strada dell’innovazione, seconda via della scienza, viale della tecnologia… Hanno nomi che rimandano a un orizzonte di progresso i percorsi del Parco industriale dell’alta tecnologia di Shenzhen, l’ex villaggio di pescatori che nel 1980 Deng Xiaoping trasformò nella prima zona economica speciale della Repubblica popolare, oggi scossa da una profonda trasformazione e dagli scioperi che attraversano l’intera regione del Guangdong. È nel distretto dove si progettano software, circuiti elettronici e biotecnologie che, alla fine della prima giornata in fabbrica dopo una protesta che li ha portati a incrociare le braccia contro i padroni della Hitachi dal 4 al 25 dicembre, incontriamo uno dei 23 «delegati» protagonisti di questa nuova stagione di lotte operaie in Cina.
Il rappresentante dei lavoratori – che ci chiede di rimanere anonimo – mostra il documento sul quale l’azienda si è infine dichiarata disponibile a trattare: aumenti salariali fino al 30%, prestiti agevolati per l’acquisto della casa, reintroduzione dei bonus cancellati dopo la crisi finanziaria del 2008. L’uomo, che come tutti i suoi compagni non è iscritto al Partito comunista (Pcc), racconta come è stata portata avanti la vertenza: «Una trentina di noi, i più anziani, hanno fatto volantinaggio, poi ci siamo riuniti in assemblea e alla fine ci siamo tirati dietro 3.500 dei 4.600 dipendenti» della Hailiang, che nel marzo prossimo passerà dal marchio hi-tech giapponese agli americani della Western digital. Le autorità – l’Assemblea dei lavoratori (l’organo del Pcc in fabbrica) e i funzionari provinciali – hanno svolto un ruolo di mediazione tra proprietà e maestranze.
Questa metropoli giovane (oltre 10 milioni di abitanti, età media 28 anni) e competitiva (i sondaggi le attribuiscono il primato di città più stressata della Cina) sul delta del Fiume delle Perle e a due passi da Hong Kong, per centinaia di aziende sembra aver perso il fascino delle origini. «Trent’anni fa il Paese aveva un’economia totalmente pianificata – spiega Yuan Yiming, vice direttore del Centro studi sulla zona economica speciale – e Shenzhen rappresentava un esperimento: manodopera e terre a basso costo più capitali stranieri contribuirono al decollo della fine degli anni ’80». «Ora però – continua il docente dell’Università di Shenzhen – quel modello di produzione a basso valore aggiunto e alta intensità di lavoro è entrato in crisi, a causa degli aumenti salariali e dei costi ambientali insostenibili».
L’incremento medio (nelle diverse province) delle retribuzioni rientra nei piani del governo, ed è stato fissato al 13%. Troppo per molte corporation, che si stanno già trasferendo in Bangladesh, Cambogia, Vietnam. Dall’altro lato decine di migliaia di migranti rimasti disoccupati vengono spinti a tornare a casa: il Sichuan – la provincia da cui proviene parte della forza lavoro del Guangdong – ha appena annunciato per il 2012 aumenti in busta paga del 23,4%.
Un processo inaugurato per «mantenere la stabilità» dopo la catena di suicidi di dipendenti della Foxconn di Shenzhen nel 2010, e accelerato dalla necessità di «riequilibrare» un sistema che delega al Guangdong un quarto del commercio dell’intera Cina. Di un «cambiamento strutturale e non congiunturale» parla Yu Bin, direttore generale del Dipartimento di ricerche macroeconomiche del Centro studi sullo sviluppo del Consiglio di Stato. Il decennio 2001-2010, col suo prodotto interno lordo (Pil) al +10,5%, è definitivamente archiviato. Ma è sull’industria che si continua a puntare, «perché – sostiene l’esponente del governo – solo il 49,95% della popolazione è urbanizzata, quindi ci sono ancora grandi possibilità di sviluppo nel centro e nell’ovest del Paese». Gli stipendi in ascesa, i progetti di edilizia popolare e il ventilato miglioramento dei servizi sanitari e pensionistici dovrebbero favorire i consumi interni e puntellare una struttura finora tutta basata sull’export.
A Dongguan – a metà strada tra Shenzhen e il capoluogo provinciale Guangzhou – il mese scorso è entrata in sciopero la taiwanese Pou Chen che produce, tra gli altri marchi, per Nike e Adidas. Circa duemila operai hanno manifestato contro l’intenzione dell’azienda di spostare l’impianto nella provincia del Jiangxi e la riduzione delle ore di straordinario. La protesta è stata stroncata dai manganelli della polizia e alcuni lavoratori sono stati fermati. «Che convenienza ha un operaio a venire qui, se nel Sichuan, nello Hunan, nello Hubei o nel Guizhou può guadagnare quasi altrettanto?» lamenta un imprenditore taiwanese che ci chiede di non rivelare il suo nome. Anche lui sta pensando di portare la sua azienda tessile via dalla Cina. Nella sua fabbrica le retribuzioni dei 150 dipendenti – salite costantemente dal 2006 – variano tra i 2.500 e i 4.700 yuan (300-500 euro circa). Eppure è a corto di manodopera non specializzata.
A Dongguan a colpire è un micidiale uno-due: alla decisione politica di eliminare gradualmente le produzioni «vecchie» si somma il crollo (-9% in ottobre per il Guangdong) della domanda – soprattutto nel settore tessili e calzaturiero – dall’Europa in crisi. Lungo Fu Hua Dong Lu donne e uomini lavorano nelle micro aziende familiari a cui le fabbriche subappaltano cucitura e stiratura dei loro capi d’abbigliamento. Ma la maggior parte delle saracinesche, ancora incorniciate dai tradizionali festoni rossi con gli ideogrammi dorati di buon augurio, sono abbassate: hanno chiuso in decine di migliaia. E una fila di migranti aspetta l’autobus che li porterà alla stazione, per il viaggio di ritorno verso aree di antica povertà ora scelte per il «nuovo sviluppo».
Zeng Feiyang dirige il Guangdong Panyu migrant workers service, una ong di supporto ai lavoratori migranti attiva dal 1998: «La prima in Cina» rimarca con orgoglio. «Oltre l’80% degli operai del Guangdong sono migranti, attivi nell’industria tessile, dei giocattoli, dell’elettronica, tutti profondamente colpiti dalla crisi». «Oltre alle rivendicazioni salariali chiedono di potersi dare una rappresentanza autonoma da quella del Pcc, la contrattazione collettiva – spiega Zeng nel suo ufficio di Guangzhou -. Sempre più spesso, per ora senza collegamenti tra una fabbrica e l’altra, si stanno unendo su singoli obiettivi: associazioni informali che si sciolgono una volta finita la lotta. Ma con la crisi queste manifestazioni e queste rivendicazioni si stanno facendo più pressanti».
Il 27 dicembre è toccato a Guangzhou, dove i 1.500 operai della Alei Siti Auto Parts Corporation (pezzi di ricambio per Honda, Toyota, Dongfeng-Nissan e Suzuki) hanno bloccato la produzione: chiedono che gli venga corrisposta per intero la tredicesima che l’azienda vuole ridurre.
Se, da un lato, l’ondata di proteste s’inquadra nel piano dello Stato di redistribuire la produzione nel Paese, dall’altro allarma perfino le autorità provinciali, tra le più progressiste della Cina. «La coscienza dell’opinione pubblica della democrazia, dell’eguaglianza e dei diritti si sta rafforzando costantemente e stanno crescendo le sue rivendicazioni in questa direzione» ha ammesso recentemente Zhu Mingguo, il vice segretario provinciale del Pcc, secondo quanto riportato dal Guangzhou daily. «I mezzi utilizzati per difendere i diritti ed esprimere le proteste stanno cambiando – ha sottolineato Zhu -: siamo di fronte a una tendenza all’intensificazione dei conflitti».
«Riconversione? Certo, ma il modello che possa funzionare per noi non l’abbiamo ancora trovato – sospira il professor Yuan -. Le bocche da sfamare sono troppe: dovremmo inventarci un’industria elettronica d’avanguardia, ma ad alta intensità di lavoro».
Una via difficile da percorrere perfino per il Pcc, che da trent’anni anni si sforza di tenere insieme il diavolo e l’acqua santa.
(Ha collaborato Alessandra Cappelletti)
*****
Difficoltà di accesso alle fabbriche. Intreccio di rivendicazioni salariali, difesa del posto e lotte per ottenere rappresentanze sindacali indipendenti. Scioperi operai e politica governativa che fino a un certo punto sembrano andare nella stessa direzione ma poi, inevitabilmente, vengono in conflitto. Per provare a capire più a fondo le dinamiche messe in moto dagli scioperi nel Guangdong abbiamo sentito Li Qiang, direttore di China labour watch (http://www.chinalaborwatch.org), l’organizzazione che dal 2000 si occupa di monitorare le condizioni di lavoro nelle aziende cinesi dove le multinazionali hanno delocalizzato alcuni segmenti della produzione.
La provincia del Guangdong è il centro dell’industria manifatturiera, dove hanno sede molti stabilimenti di aziende multinazionali. Molte di queste compagnie, a causa dell’aumento dei costi di produzione dovuto principalmente ai rincari delle materie prime, per mantenere i propri margini di profitto hanno deciso di trasferirsi in aree con standard di vita più bassi. Tutto ciò rende i lavoratori disoccupati e, ovviamente, arrabbiati. Un altro elemento, comune a tutti gli scioperi a cui abbiamo assistito ultimamente, è la crescente consapevolezza dei propri diritti da parte degli operai. Anche per questo si mobilitano e si organizzano: per combattere, per ottenere questi diritti.
La risposta delle autorità non è stata quasi mai dura. In molti casi il governo sembra aver mediato tra lavoratori e dirigenti aziendali. Come lo spiega?
Sì, effettivamente sembra proprio che stia andando così. E nei casi in cui il governo locale si è impegnato per risolvere queste controversie, la leadership ha capito quanto è importante difendere i diritti dei lavoratori e ha provato a non porsi dal lato sbagliato, come ha fatto tante volte in passato.
I salari stanno crescendo, nel Guangdong come in tutta la Cina. Ma qual è l’evoluzione delle condizioni di lavoro nelle fabbriche?
Anzitutto va detto che anche se i salari nominali stanno crescendo, al netto dell’inflazione sono rimasti più o meno stabili. E comunque il problema più pressante è quello della posizione debole in cui sono relegati gli operai. Nonostante la legislazione cinese sul lavoro garantisca ai lavoratori molte protezioni, noi riteniamo che, nella pratica, il sistema sia sbilanciato in favore delle aziende. Ad esempio: per un lavoratore sono necessarie una gran quantità di tempo e denaro per intentare causa a un’azienda. Per questo, nella stragrande maggioranza dei casi, rinuncia. Inoltre i lavoratori non possono costituire sindacati indipendenti. Secondo le nostre indagini, «rappresentanze dei lavoratori» esistono nella maggior parte delle fabbriche, ma gli operai ci raccontano che, quasi sempre, esse difendono non i loro interessi ma quelli della proprietà delle aziende.

La sua organizzazione denuncia pratiche autoritarie da parte delle aziende in Cina. Può spiegarci meglio a cosa fate riferimento?
Prima di tutto vorrei sottolineare che quest’ondata di scioperi sta dimostrando che lo stile di management autoritario sta perdendo presa nei confronti di una forza lavoro più istruita e consapevole dei propri diritti. Le nostre denunce sono relative al fatto che i lavoratori non hanno voce in capitolo sulla gestione degli impianti né sul trattamento o sui bonus che gli sono riservati. I lavoratori vengono tenuti sistematicamente separati dai datori di lavoro. L’approccio di gestione delle fabbriche «dall’alto verso il basso», nel momento in cui ristruttura, si tagliano i bonus, e si annunciano improvvisamente trasferimenti di stabilimenti, diventa il principale fattore di scontento, ancora più degli stessi cambiamenti che promuove. Quando esplodono le proteste, le aziende negoziano soltanto con i dipartimenti del governo locale e con i sindacati governativi, che quasi sempre appoggiano il management. Attraverso queste procedure viene completamente ignorata la volontà dei lavoratori. Questa volta pare che i lavoratori abbiano deciso che se i dirigenti delle aziende non rispettano i loro diritti sanciti dalla legge cinese, allora devono essere loro a difenderli: è questo il significato degli scioperi e delle manifestazioni degli ultimi tempi.
In alcuni casi i lavoratori iniziano a spingere per una reale rappresentanza. Quanto è ancora lunga la strada perché in Cina nascano sindacati indipendenti?
È molto difficile prevederlo, auguriamoci che avvenga il prima possibile.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa