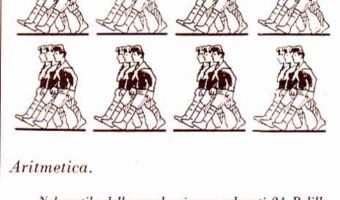“Il merito è di sinistra, il talento è di sinistra. Io sono per l’uguaglianza, ma non per l’egualitarismo“. Questo è quanto affermato (purtroppo acclamato da un pubblico alquanto vasto) il premier Matteo Renzi alla Festa nazionale de l’Unità a Bologna.
Stava parlando delle linee guida dell’ennesima – e destrutturante – controriforma dell’istruzione che il governo si avvia a realizzare. Stava quindi descrivendo una scala di valori sui quali si intende conformare un’intera società. Si tratta di un assioma ideologico – prima ancora che di un punto di programmma – che va decostruito e smantellato; non solo per i danni che ha già provocato e che provocherà, ma perchè anche su questo fronte “ideologico” si contrappongono due (o più?) idee di società antagoniste tra loro. Ed anche diversi equivoci malsani che hanno caratterizzato il “senso comune di sinistra” degli ultimi 30 anni.
La facilità con cui l’ideologia liberista sta travolgendo ogni argine non sarebbe stata del resto possibile se fosse esistita – a livello di massa, ovvero condivisa da quote rilevanti della popolazione – una visione del mondo alternativa e “forte”, basata su evidenze empiriche e pratiche sociali positive. Ma andiamo con ordine.
Dirsi a favore dell’uguaglianza riducendola ad astratto “egualitarismo” è già una contraddizione in sé. La prima è una condizione sociale, frutto di consuetudini sociali e di norme (scritte e non); la seconda un principio (morale, filosofico, etico, ideologico) che indica un obiettivo da realizzare in concreto.
Storicamente, nella cultura liberale, “uguaglianza” viene intesa come la semplice possibilità legale che ognuno persegua i propri obiettivi, senza essere impedito o frenato da norme discriminatorie. Naturalmente, nella cultura liberale, non si tiene in alcun conto la concreta base di partenza individuale – il nascere povero, ricco, benestante, ceto medio, ecc – che normalmente determina la possibilità o meno di stare (o arrivare) davvero “alla pari” con i più fortunati. Se nasco in una casa senza libri, con genitori a bassa scolarizzazione, farò molta più fatica negli studi di quanta non ne faccia un rampollo di buona famiglia, magari con “precettore” incaricato delle ripetizioni. Essere uguali come “talento individuale”, insomma, non significa affatto identiche possibilità di successo (o fallimento).
La variabile del talento può rompere questo schema costrittivo soltanto nel caso sia anche straripante, solare, evidente anche a un cieco. E utilizzabile in senso economico. Un “piccolo genio” viene riconosciuto subito, anche nella più scassata delle scuole pubbliche di periferia; e di lì segnalato, di anno in anno, perché gli sia concessa quella chance che i “normodotati poveri” non possono avere. Mentre un normodotato benestante avrà decine di incentivi, e occasioni, per migliorare le proprie doti nel corso della formazione. Più ricca sarà la famiglia, più numerosi saranno gli input.
Parlando di talento e di competizione si usa spesso la metafora sportiva, doppiamente falsificante. In primo luogo perché il successo di un campione non implica affatto la “soppressione” di chi è meno dotato; al massimo guadagnerà di più, in fama e soldi, per il breve arco di vita in cui potrà esibirsi sulla scena. Ma si può vivere benissimo una vita degna e soddisfacente anche senza essere particolarmente portati per il movimento fisico o altre arti similari. In secondo luogo, perché la competizione nello sport è uno spettacolo, una parentesi (mercificata) nella vita reale, non l’ideale della “normalità” nelle relazioni umane.
Eguaglianza, nel pensiero politico del movimento operaio, significa soltanto diritto a un’esistenza dignitosa per tutti gli esseri umani, forti o deboli che siano, “talentuosi” e non. Se vogliamo dunque restare nel campo dell’istruzione, significa pari possibilità di studiare, quanto a materiale didattico, libri, qualità media degli insegnanti, tempo disponibile. Ma niente affatto lo stesso voto per tutti, né la promozione assicurata indipendentemente dal rendimento. Perché l’eventuale fallimento scolastico – gli esseri umani sono tutti diversi quanto a intelligenza, forza, interessi, curiosità, ecc – non dovrebbe implicare la morte sociale, l’indigenza, l’emarginazione.
Nello schema competitivo renzian-liberista, invece, solo “uno su mille ce la fa”; gli altri si tolgano dai piedi e si accontentino dei “mini job”.
L’adolescente che nasce, cresce e studia a Corso Traiano (Napoli) e quello che nasce, cresce e studia nella “Milano da bere”, non solo non hanno le stesse condizioni di partenza, ma vedranno riconosciuti – o disconosciuti – i loro talenti in condizioni radicalmente diverse. Allo stesso modo l’insegnante che opera a Tor Bella Monaca (Roma) e quello che insegna alla Crocetta (il quartiere bene di Torino) non agiscono nello stesso contesto sociale e culturale; e questo indubbiamente farà la differenza, anche nei risultati che otterrà come docente, indipendentemente dalle sue capacità e professionalità. Un metro di misura del merito in termini di standard (vedi la follia delle prove Invalsi) non renderà mai giustizia al merito effettivo.
Valorizzare insomma il merito senza assicurare una base di partenza effettivamente uguale per tutti significa in definitiva teorizzare e incentivare, riproducendola generazione dopo generazione, la disuguaglianza di status (delle condizioni di partenza). Proprio quello che è avvenuto negli ultimi venti anni di egemonia della cultura liberal-liberista e che si vuole ora “eternizzare” distruggendo il valore formativo della scuola pubblica (ridotta magari a interfaccia di aziende di non eccelso livello).
Questo non ha palesemente nulla a che vedere con le “competenze” necessarie in qualsiasi professione o mestiere. E certo Renzi – usando le parole che usa – ha di mira quella vulgata triste e imbecille, solo presuntamente “di sinistra”, per cui non occorre prepararsi adeguatamente a ricoprire un qualsiasi ruolo sociale; o per cui si può “dire la propria” su un qualsiasi argomento, anche senza averne mai sentito parlare prima o – peggio ancora – rifiutandosi di studiare la materia. Diciamo “presuntamente di sinistra” perché, di fatto, è niente altro che il chiacchiericcio da bar, quel modo di straparlare tipico di un milieu per cui chiunque – in quel delirio – può fare l’allenatore della nazionale di calcio o il leader politico. Ci sono ahinoi anche settori di “movimento” intrisi, più o meno consapevolmente, di questo atteggiamento. Come se a qualcuno potesse piacere l’idea di essere curato da un medico incompetente, abitare in un palazzo disegnato da un architetto senza conoscenze di statica o di resistenza dei materiali, o persino affidare la propria vecchia auto a un meccanico improvvisato…
Il movimento comunista è invece cresciuto – fin quando è cresciuto – grazie agli “operai che studiavano di notte”, alla consapevolezza condivisa che “l’operaio conosce 300 parole e il padrone 3.000, per questo lui è il padrone”; insomma, grazie alla ferrea volontà di superare l’ignoranza cui i lavoratori, le loro famiglie, i loro eredi, sono “normalmente” condannati.
Questa condizione di minorità intellettuale perenne – anche senza entrare nel più ampio discorso della “secretazione delle informazioni rilevanti”, che caratterizza il potere contemporaneo – è un punto irrinunciabile per programma di governo del capitale multinazionale, scottato per sempre dalla rivolta sociale innervata dalla “scolarità di massa” degli anni ’70 in tutto l’Occidente. Un incubo, quel “sapere critico” che sa smontare qualsiasi luogo comune o comando del potere, che ancora turba i sonni di gentucola come i Sacconi, i Brunetta e compagnia cantando.
Ma c’è un altro aspetto, ancora più insidioso, in questo voler costruire un modello di società “sul merito e sul talento” astratti. È la sollecitazione dell’individualismo a scapito della cooperazione, che fa leva su uno “spirito animale” che spinge a ritenere se stessi “migliori” di chi lavora o studia al tuo fianco. Nell’ideologia liberale, di stampo calvinista e anglosassone, è l’individuo in quanto tale che deve farsi largo, addirittura perchè un qualche dio lo ha scelto tra tutti gli altri. Il “successo”, nella cultura capitalista e protestante, “è un segno del favore divino”. Ed è su questa concezione individualista senza mediazione sociale che è stata costruita l’ideologia liberale della “competizione virtuosa” nell’economia e nella società, del perseguimento dell’interesse individuale come portatore del benessere generale, grazie alla “mano invisibile del mercato”.
Viene insomma incentivata la rottura completa della relazione sociale tra l’individuo e ciò e chi lo circonda. I rapporti di cooperazione tra chi vive nelle stesse condizioni e negli stessi luoghi, la dimensione collettiva della soluzione dei problemi, vengono combattuti con ferocia assoluta e liquidati, appunto, come “egualitarismo che mortifica il merito e il talento individuale”. Perché “il talento”, in questa dimensione selvatica, è l’equivalente della forza, il vantaggio competitivo rispetto ai simili, la dote che permette di superare e sopraffare gli altri, di vendersi al miglior prezzo, di ingraziarsi un padrone o di entrare nelle fila degli sfruttatori.
Gli effetti devastanti di questa logica sono ben visibili tra coloro che vivono “in basso”. La divisione, la frammentazione, la guerra tra poveri, impediscono a chi “sta sotto” di mettere in discussione chi “sta in alto” e perpetuano i rapporti di dominio sociale esistenti. Studiare con serietà, approfondire, lavorare cercando di conoscere tutto il processo e non accettando la voluta parcellizzazione della conoscenza, è un fattore di emancipazione e non una perdita di tempo. Ma diventa tale solo se quella individuale entra in rapporto con quella collettiva; cioè insieme a chi studia, lavora, vive e lotta intorno a noi.
In ultima istanza, dunque, anche la visione del “talento” va sottoposta a seria verifica. Il talento è un dono. C’è chi ce l’ha e chi non ne ha. È genetico. Può riversarsi nello sport, nella musica, nella cultura o nella capacità di dare soluzione ai problemi che si presentano, nell’economia come nella vita quotidiana. Ma l’uso sociale che si fa del talento individuale è decisivo nelle sue ricadute.
Il bravo medico, dotato di talento, è una benedizione per tutti se opera in ospedale pubblico e può prendersi cura in egual modo di tutti i suoi pazienti, indipendentemente dalla capacità del loro libretto degli assegni; ma se lavora solo a pagamento, per chi se lo può permettere, ovviamente in una clinica privata, diventa un selezionatore eugenetico su base censitaria. Un criminale “perbene” che sottrae la propria conoscenza alla disponibilità generale, impoverendo l’umanità mentre si arricchisce e/o fa guadagnare uno speculatore della sanità privata.
Il talento è insomma certamente individuale. Ma se lo si usa solo per l’arricchimento individuale e il beneficio di pochi diventa un talento sprecato. Come se Totti o Cristiano Ronaldo si rifiutassero di giocare in una squadra. E la squadra siamo tutti noi.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa