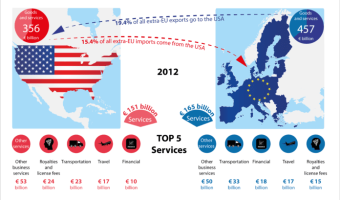Difficile dire per quale ragioni il Partito Democratico si avvii stancamente alla scissione. Difficile, vogliamo dire, invidividuare ragioni “programmatiche e ideali”, come si sente dire in questi giorni, che distinguano effettivamente il campo renziano (molto scosso anche al proprio interno) dai vecchi tromboni ulivisti. Ovvero da Bersani – che rivendica ancora oggi di esser stato “l’unico ad aver fatto liberalizzazioni” – D’Alema (che ha regalato Telecom alla cordata guidata da Colaninno), il governatore toscano Rossi (che privatizza l’acqua regionale violando il risultato e quindi il vincolo referendario) e via elencando.
Sul piano pratico, sulle cose fatte – che sono poi le uniche che si possano giudicare in politica – l’assemblea nazionale del Pd è composta da una folla indistinguibile di neoliberisti senza se e senza ma. Gente che ha votato la riforma Fornero sulle pensioni, il jobs act, la “buona scuola”, e ancor prima quel “pacchetto Treu” (1997!) che ha aperto le dighe alla precarietà di massa, legalizzata e perenne, in questo paese. E non basta davvero canticchiare qualche strofa di “bandiera rossa” (peraltro epurata della parola “comunismo”), o sbrodolare qualche frase contrita sulle “disuguaglianze intollerabili”, la “precarietà diffusa”, “i giovani”, “i lavoratori”.
Eppure stanno scindendosi. Matteo Renzi, come previsto, ha azzerato il finto lavoro dei finti “pontieri” che nelle ultime ore facevan mostra di preoccuparsi di “mantenere l’unità”, al puro scopo di conservare voti e iscritti in una comunità disossata che reagisce automaticamente e si affida ancora fideisticamente ai “comandi del partito” (non è un caso che le uniche regioni in cui è prevalso il “sì” al referendum siano proprio Toscana e Emilia Romagna).
L’ex premier si è dimesso anche da segretario solo per poter aprire immediatamente la fase congressuale, nel disperato tentativo di concluderla in tempi rapidissimi e provocare quindi – subito dopo – la caduta del governo per potersi ripresentare come candidato premier. Stringe i tempi per ritagliarsi un partito indistinguibile dalla sua persona, nonostante gli sconquassi delle tre ultime tornate elettorali (regionali, amministrative e referendum).
Stupisce, in questa macchina da guerra apparentemente inarrestabile, l’assoluta indifferenza al fatto che la legge elettorale – dopo l’intervento della Corte Costituzionale – non sia affatto improntata al bipartitismo obbligato col sistema maggioritario (l’ossessione irrisolta di 25 anni di “seconda repubblica”), ma un proporzionale con sbarramento che non garantisce l’elezione di nessun premier la sera stessa del voto; rinviando dunque la formazione di un governo alle trattative tra coalizioni, come ai tempi della prima repubblica.
Evidente come il sole a mezzogiorno, le mosse renziane hanno senso solo in un caso: puntare esplicitamente a un governo Pd-Berlusconi (con l’apporto di qualche cortigiano comprato con qualche poltrona), dopo una campagna elettorale fatta di finte contrapposizioni tra “centrodestra” e “centrosinistra”.
Calcolo peraltro rischioso, nell’attuale panorama sociale dominato dal massiccio rifiuto popolare dell’establishment politico (anche i Cinque Stelle potrebbero pagare caro il mesto spettacolo della giunta capitolina), che potrebbe creare un futuro Parlamento di fatto senza una vera maggioranza (stante anche le grosse differenze tra i modi di eleggere le due Camere).
Eppure vanno alla scissione. Pur consapevoli che un Pd solo renziano varrà tra qualche mese assai meno del 25-27% oggi attribuito dai sondaggi (a maggior ragione se dovesse imbarcare esplicitamente gente come Alfano e Verdini). Pur scontando, la cosiddetta “vecchia guardia”, una ripartenza da zero che non è assolutamente nelle proprie corde e abitudini (è appena il caso di ricordare che tutti loro hanno scalato le posizioni in un partito costruito da altri, ma non ne hanno mai costruito uno). Le precedenti esperienze di “scissione a sinistra” (da Rifondazione in poi) lasciano sperare al massimo in percentuali intorno al 10%, che a noi sembrano decisamente ottimistiche.
In ogni caso, questa scissione – fatta con le movenze di un “lungo addio”, che concretizzerà le prime mosse con la formazione di gruppi parlamentari autonomi, nei prossimi giorni – pone le basi per la disgregazione dell’ultimo “partito” sopravvissuto alla grande moria del dopo-Tangentopoli. Da allora in poi, infatti, sono avute solo formazioni fortemente localizzate (la Lega, i post-democristiani di Mastella, Casini, Alfano, ecc), oppure comitati elettorali più o meno larghi e fortunati (Forza Italia) se riuniti intorno a una figura per qualche ragione “carismatica”.
Il panorama prossimo venturo sarà popolato di nanerottoli politici incapaci – ognuno per contro proprio – si ergersi sopra gli altri e fare da punti di aggregazione convincente. Specie se la partecipazione popolare al voto dovesse accentuare la sua tendeza a diminuire.
Uno spappolamento del sistema politico destinato al massimo a fornire i mattoni per un qualsiasi governo di obbedienza assoluta alla Troika. Zero idee, zero ideali, zero programmi, pura comunicazione. Come si vede già ora nel Pd.
Non ci sfugge che questa scissione produrrà i suoi effetti più vistosi – nel suo piccolo, ovvio – sull’arcipelago di disperati che usa autodefinirsi “sinistra”. In questa area i “programmi” sono stati dimenticati da un pezzo (se ne parla a ridosso delle elezioni, ma solo per darsi un tono), la dinamica dei “contenitori” assemblati alla meno peggio ha sostituito da quasi 30 anni qualsiasi altra prospettiva razionale. Si può scommettere che il giorno in cui verrà formalizzata la “nuova formazione di sinistra” si metterà in moto una fibrillazione irrefrenabile per ”creare un contenitore più largo”, dai contorni ancora più vaghi, assolutamente indigeribile per il nostro “blocco sociale”, già da tempo sordo a ogni richiamo di questo tipo.
Non è il caso di farsi distrarre. Questa roba è morta prima di iniziare a vivere.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa