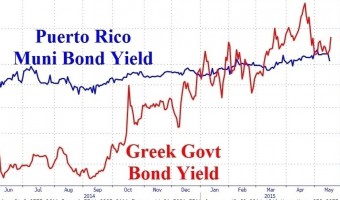L’Europa è malata. Quanto gravemente è questione non sempre facile da giudicare. Ma tra i sintomi ce ne sono tre di cospicui, e interrelati. Il primo, e più familiare, è la svolta degenerativa della democrazia in tutto il continente, di cui la struttura della UE è a un tempo la causa e la conseguenza. Lo stampo oligarchico delle sue scelte costituzionali, a suo tempo concepite come impalcatura di una sovranità popolare a venire di scala sovranazionale, nel tempo si è costantemente rafforzato.
I referendum sono regolarmente sovvertiti se intralciano la volontà dei governanti. Gli elettori le cui idee sono disdegnate dalle élite rigettano i governi che nominalmente li rappresentano, l’affluenza alle urne cala di elezione in elezione. Burocrati che non sono mai stati eletti controllano i bilanci dei parlamenti nazionali espropriati del potere di spesa. Ma l’Unione non è un’escrescenza di stati membri che, senza di essa, sarebbero in buona salute. Riflette, tanto quanto aggrava, tendenze di lungo corso al loro interno. A livello nazionale, virtualmente ovunque, dirigenti addomesticano o manipolano le legislature con crescente facilità; partiti perdono iscritti; elettori perdono la fiducia di contare considerato che le scelte politiche si assottigliano e le promesse di differenze durante le campagne elettorali si riducono o svaniscono una volta in carica.
All’involuzione generalizzata si è accompagnata una corruzione pervasiva della classe politica, argomento su cui le scienze politiche, parecchio loquaci a proposito di quello che nel linguaggio dei contabili è definito “il deficit democratico dell’Unione”, solitamente tacciono.
Le forme di tale corruzione devono ancora trovare una tassonomia sistematica. C’è la corruzione pre-elettorale: il finanziamento di persone e partiti da fonti illegali – o legali – contro la promessa, esplicita o tacita, di futuri favori. C’è la corruzione post-elettorale: l’uso delle cariche per ottenere fondi mediante malversazioni sulle entrate o mazzette sui contratti. C’è l’acquisto di voci o voti nei parlamenti. C’è il furto puro e semplice dalle casse pubbliche. C’è la falsificazione di credenziali per vantaggi politici. C’è l’arricchimento dalla carica pubblica dopo l’evento, così come durante o prima di esso. Il panorama di questa malavita [in italiano nel testo] è impressionante.
Un affresco di esso potrebbe cominciare con Helmut Kohl, governante della Germania per sedici anni, che accumulò due milioni di marchi di fondi neri da donatori illegali i cui nomi, quando fu denunciato, rifiutò di rivelare per timore che venissero alla luce i favori che aveva fatto loro. Oltre il Reno, Jacques Chirac, presidente della Repubblica Francese per dodici anni, fu condannato per appropriazione di fondi pubblici, abuso di ufficio e conflitti d’interesse, una volta caduta l’immunità. Nessuno dei due ha subito pene. Questi erano due dei più potenti politici dell’epoca in Europa. Uno sguardo allo scenario dopo di allora è sufficiente a cancellare qualsiasi illusione che essi fossero dei casi rari.
In Germania il governo di Gerhard Schroeder garantì un prestito da un miliardo di euro alla Gazprom per la costruzione di un gasdotto sul Baltico poche settimane prima che egli si dimettesse da cancelliere e andasse a libro paga della Gazprom con uno stipendio maggiore di quello che aveva ricevuto governando il paese. Dopo la sua partenza, Angela Merkel ha visto due presidenti della repubblica, uno dietro l’altro, costretti a dimettersi da screditati: Horst Koehler, ex capo del FMI, per aver spiegato che il contingente della Bundeswehr in Afghanistan stava proteggendo interessi commerciali tedeschi; e Christian Wulff, ex capo cristiano-democratico della Bassa Sassonia, per un prestito discutibile ricevuto da un affarista amico per la sua casa. Due ministri eminenti, uno della difesa e l’altro dell’istruzione, hanno dovuto andarsene quando sono stati privati dei loro dottorati – una credenziale importante per una carriera politica nella Repubblica Federale – per violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Quando il secondo, Annette Schavan, un’intima amica della Merkel (che aveva manifestato piena fiducia in lei) era ancora in carica, il Bild Zeitung ha osservato che avere un ministro dell’istruzione che aveva falsificato le sue ricerche era come avere un ministro delle finanze con un conto segreto in Svizzera.
Detto fatto: in Francia il ministro socialista del bilancio, il chirurgo plastico Jérôme Cahuzac, la cui direttiva era di difendere la probità e l’equità fiscale, è stato scoperto detenere qualcosa tra i 600.000 e i 15 milioni di euro in depositi segreti in Svizzera e a Singapore. Nicolas Sarkozy, nel frattempo, è accusato da testimoni concordi di aver ricevuto circa 20 milioni di dollari da Gheddafi per la campagna elettorale che lo portò alla presidenza. Christine Lagarde, il suo ministro delle finanze, che oggi dirige il FMI, è sotto inchiesta per il suo ruolo nella concessione di 420 milioni di dollari di ‘risarcimento’ a Bernard Tapie, un ben noto truffatore con un passato in carcere, negli ultimi tempi amico di Sarkozy.
La contiguità disinvolta con la criminalità è bipartisan. François Hollande, attuale pres<idente della repubblica, usava come pied-à-terre per gli incontri con la sua amante un appartamento della donna di un gangster corso ucciso l’anno scorso in una sparatoria sull’isola.
In Gran Bretagna, circa nello stesso periodo, l’ex premier Blair consigliava a Rebekah Brooks, che rischiava il carcere per cinque accuse di cospirazione criminale (“Sii forte e prendi pastiglie per dormire. Passerà. Dura!”) e la sollecitava a “pubblicare un rapporto in stile Hutton”, come aveva fatto lui per sterilizzare qualsiasi parte il suo governo potesse aver avuto nella morte di una fonte interna che aveva fatto rivelazioni sulla sua guerra in Iraq: un’invasione dalla quale ha poi proseguito a raccogliere – naturalmente per la sua Fondazione Faith – mance e contratti assortiti in giro per il mondo. Considerevoli, tra questi, fondi in contanti da una compagnia petrolifera della Corea del Sud gestita da un delinquente condannato con interessi in Iraq e presso la dinastia feudale del Kuwait. Quali ricompense possa essersi guadagnato più a est resta da vedere (“I progressi del Kazakistan sono splendidi. Comunque, signor Presidente, lei ha toccato nuovi vertici nel suo messaggio alla nazione”. Alla lettera.) In patria, in uno scambio di favori a proposito dei quali ha mentito compuntamente al parlamento, le sue mani sono state unte da un milione di sterline versate alle casse del partito dal magnate delle corse automobilistiche Bernie Ecclestone, attualmente sotto giudizio in Baviera per tangenti al ritmo di 33 milioni di euro.
Nella cultura del New Labour, figure di spicco della cerchia di Blair, ministri di gabinetto un tempo – Byers, Hoon, Hewitt – non sono stati in grado di offrirsi in vendita al successore. Negli stessi anni, indipendentemente dal partito, la Camera dei Comuni è stata denunciata come un pozzo nero di meschine malversazioni di denaro dei contribuenti.
In Irlanda, contemporaneamente, il leader del Fianna Fàil, Bertie Ahern, avendo canalizzato più di 400.000 euro di pagamenti non spiegati prima di diventare taioseach, si è votato lo stipendio più elevato di qualsiasi premier in Europa – 310.000 euro, più persino del presidente degli Stati Uniti – un anno prima di doversene andare con disonore per assoluta disonestà.
In Spagna l’attuale primo ministro, Mariano Rajoy, alla guida di un governo di destra, è stato colto con le mani nel sacco mentre riceveva mazzette per contratti di costruzione e di altro genere per un totale di un quarto di milione di euro nel giro di un decennio, passategli da Luis Bàrcenas. Tesoriere del suo partito per vent’anni, Bàrcenas è oggi sotto arresto per aver accumulato un tesoro di 48 milioni di euro in conti svizzeri non dichiarati. I libri mastri, compilati a mano, contenenti i dettagli dei suoi versamenti a Rajoy e ad altri notabili del Partito del Popolo – tra cui Rodrigo Rato, altro ex capo del FMI – sono apparsi in facsimile in abbondanza sulla stampa spagnola. Una volta scoppiato lo scandalo Rajoy ha inviato a Bàrcenas un messaggio con parole virtualmente identiche a quelle di Blair alla Brooks: “Luis, io capisco. Resta forte. Ti chiamerò domani. Un abbraccio.”
Pur con uno scandalo in cui l’85% del pubblico spagnolo ritiene che egli menta, resta incollato alla poltrona nel Palazzo della Moncloa.
In Grecia, Akis Thochatzopoulos, del Pasok, ministro, in successione, dell’interno, della difesa e dello sviluppo, in un’occasione arrivato a un soffio dalla guida della socialdemocrazia greca, è stato meno fortunato: condannato l’autunno scorso a vent’anni di carcere per una formidabile carriera di estorsioni e di riciclaggi di denaro sporco.
Oltre il mare Tayyip Erdogan, a lungo celebrato dai media e dall’establishment intellettuale dell’Europa come il più grande statista democratico della Turchia, la cui condotta ha virtualmente dato al paese il titolo di membro onorario della UE ante diem, ha dimostrato di essere meritevole di essere incluso nei ranghi della dirigenza europea in un altro modo: in una conversazione registrata in cui dava al figlio istruzioni su dove nascondere decine di milioni in contanti, in un’altra in cui alzava il prezzo di una robusta tangente su un contratto di costruzioni. Tre ministri del governo sono caduti dopo scoperte analoghe, prima che Erdogan purgasse le forze della polizia e della magistratura per assicurarsi che non si spingessero oltre. Mentre egli faceva questo la Commissione Europea ha pubblicato il suo primo rapporto ufficiale sulla corruzione nell’Unione, la cui dimensione il commissario autore del rapporto l’ha descritta come “mozzafiato”: secondo una stima prudente, costa alla UE quanto l’intero bilancio dell’Unione, circa 120 miliardi l’anno, ma la cifra reale è “probabilmente molto più alta”.
Prudentemente il rapporto si è occupato solo degli stati membri. La stessa UE, la cui intera Commissione fu costretta in tempi non lontani a dimettersi screditata, è stata esclusa. [La Commissione Santer fu costretta a dimettersi nel 1999 per accuse di corruzione contro alcuni suoi membri – n.d.t.].
Diffuso in un’Unione che si presenta da tutore morale del mondo, l’inquinamento del potere ad opera del denaro e della frode deriva dallo svuotamento di sostanza o dalla caduta del coinvolgimento nella democrazia. Le élite, liberate sia da una reale divisione in alto, sia da un significativo dovere di rispondere in basso, possono permettersi di arricchirsi alla follia e restare impunite.
La denuncia cessa di contare molto, poiché l’impunità diviene la regola. Come i banchieri, i politici di spicco non finiscono in carcere. Della fauna in alto solo un greco anziano ha sofferto quell’umiliazione. Ma la corruzione non è solo una funzione del declino dell’ordine politico. E’ anche, ovviamente, un sintomo del regime economico che si è impossessato dell’Europa a partire dagli anni ’80. In un universo neoliberista dove i mercati sono il metro del valore il denaro diventa, più platealmente che mai, la misura di tutte le cose. Se ospedali, scuole e carceri possono essere privatizzati a fini di profitto delle imprese, perché non anche le cariche politiche?
Oltre alla ricaduta culturale del neoliberismo, tuttavia, vi è l’impatto del sistema socio-economico, che è la terza e, nell’esperienza del popolo, di gran lunga più acuta delle malarie che affliggono l’Europa. Che la crisi economica scatenata in occidente nel 2008 sia stata il risultato di decenni di liberalizzazioni nel settore finanziario e di espansione del credito lo ammettono, più o meno, i loro stessi architetti; si veda Alan Greenspan. Collegate oltre Atlantico, le banche e le attività immobiliari europee erano già coinvolte nel disastro tanto quanto le loro omologhe statunitensi. Nella UE, tuttavia, questa crisi generale è stata aggravata da un altro fattore peculiare dell’Unione, le distorsioni create dalla moneta unica imposta a economie nazionali molto diverse tra loro, spingendo le più vulnerabili di esse sull’orlo della bancarotta quando sono state colpite dalla crisi generale. La cura per esse? Su insistenza di Berlino e di Bruxelles, non solo un classico regime di stabilizzazione del genere Churchill-Bruening tra le due guerre, tagliando la spesa pubblica, ma un patto fiscale [fiscal compact] che ha fissato un limite uniforme del tre per cento a ogni deficit, come norma costituzionale, radicando efficacemente una fissazione economica strabica come principio fondamentale del Rechtsstaat [stato di diritto] alla stessa stregua della libertà di espressione, dell’uguaglianza davanti alla legge, dell’habeas corpus, della divisione dei poteri e del resto.
Se non fosse per la sua quota di consegne alla tortura ieri, sarebbe difficile trovare un esempio più tagliente della considerazione in cui sono oggi tenuti i principi da parte delle oligarchie della UE.
Economicamente i guadagni prodotti dall’integrazione sono stati esagerati fin dall’inizio. Nella primavera del 2008 la stima più attenta, di Andrea Boltho e Barry Eichengreen, due distinti economisti dall’ottica impeccabilmente filo-europea, concludevano che il Mercato Comune poteva aver aumentato la crescita del 3 o 4 per cento del PIL della CEE nell’intero periodo dalla metà degli anni ’50 alla metà degli anni ’70 e l’Atto Unico Europeo di un altro un per cento, mentre l’impatto positivo dell’unione monetaria era, alla data, risultato trascurabile, arrivando così a un totale di forse un 5 per cento di aumento del PIL in mezzo secolo.
Ciò accadeva prima che si scatenasse la crisi. Qual è il bilancio da allora? Alla fine del 2013, dopo cinque anni di crisi, il PIL dell’eurozona non ha ancora recuperato il livello del 2007. Quasi un quarto della sua gioventù è disoccupato. In Spagna e in Grecia i dati sono catastrofici: 57 e 58 per cento, rispettivamente. Persino in Germania, che ha accumulato surplus anno dopo anno è che sbandierata diffusamente come una storia di successo del periodo, gli investimenti sono stati tra i più bassi delle economie del G7 e la percentuale di lavoratori a basso salario (quelli che guadagno meno di due terzi del reddito medio) è la più alta di ogni altro stato dell’Europa occidentale.
Tali sono le più recenti letture dell’unione monetaria. I medicastri dell’austerità hanno salassato il paziente, non l’hanno riportato alla salute.
***
In questo scenario, un paese è considerato diffusamente come il caso più acuto di malfunzionamento europeo. Dall’introduzione della moneta unica l’Italia ha segnato il dato economico peggiore di ogni altro stato dell’Unione: vent’anni di stagnazione virtualmente ininterrotta a un tasso di crescita ben inferiore a quello di Grecia o Spagna. Il suo debito pubblico è superiore a 130 per cento del PIL. Tuttavia questo non è un paese di dimensione piccola o media della periferia recentemente acquisita dell’Unione. È uno dei sei membri fondatori, con una popolazione paragonabile a quella della Gran Bretagna e un’economia superiore a quella della Spagna. Dopo la Germania la sua base manifatturiera è la seconda maggiore d’Europa, dove è anche seconda in classifica nell’esportazione di beni capitali. Le emissioni del suo tesoro costituiscono il terzo maggiore mercato di titoli sovrani del mondo. Quasi metà del suo debito pubblico è detenuto all’estero: il dato paragonabile del Giappone è inferiore al 10 per cento. Nella sua combinazione di peso e di fragilità l’Italia è il vero anello debole della UE, dove questa potrebbe teoricamente spezzarsi.
Oggi è anche, non per caso, il solo paese in cui la delusione per lo svuotamento delle forme democratiche, non semplicemente un’indifferenza intorpidita ma una rivolta attiva, ha scosso la dirigenza alle fondamenta, trasformando il panorama politico. Movimenti di protesta di un genere o dell’altro sono emersi in altri stati dell’Unione, ma finora nessuno approssima la novità o successo dell’ondata del Movimento Cinque Stelle in Italia come ribellione alle urne. E anche, a sua volta, l’Italia offre lo spettacolo più familiare di tutti i teatri di corruzione del continente e quello della sua più celebrata incarnazione nel miliardario che ha retto il paese per quasi metà della vita della Seconda Repubblica, a proposito del quale si sono spese più parole che riguardo a tutti i suoi avversari messi insieme.
Le riflessioni sul passaggio raggiunto dall’Italia partono inevitabilmente da Silvio Berlusconi. Che egli emerga tra i suoi pari per l’intreccio di potere e denaro è fuori discussione. Ma il modo in cui c’è riuscito può essere oscurato dal clamore della stampa estera al suo inseguimento, prime fra tutte le tonanti denunce dell’Economist e del Financial Times.
Due cose hanno reso straordinario Berlusconi. La prima che è egli ha invertito il percorso tipico dalla carica al profitto, ammassando una fortuna prima di arrivare al potere politico, che poi ha usato non tanto per accrescere la propria ricchezza, quanto per proteggerla, e proteggere se stesso, da molteplici incriminazioni penali per il modo in cui l’aveva acquisita. La seconda è che la principale, anche se lungi dall’essere unica, fonte della sua ricchezza è un impero televisivo e pubblicitario che gli ha fornito un apparato di potere indipendente dalla carica e che, una volta entrato nell’arena elettorale, ha potuto essere convertito in una macchina di propaganda e in uno strumento di governo.
Collegamenti politici – legami con il Partito Socialista a Milano e con il suo capo Craxi – sono stati cruciali per la sua ascesa economica, e in particolare per la costruzione della sua rete nazionale di canali televisivi. Ma anche se ha sviluppato considerevoli abilità, essenzialmente di comunicazione e manovra, da politico, in prospettiva è rimasto innanzitutto un uomo d’affari, per il quale il potere ha significato sicurezza e fascino, piuttosto che azione o progettualità. Anche se ha manifestato la sua ammirazione per la Thatcher e si è vantato di essere campione del mercato e della libertà economica, l’immobilismo delle sue coalizioni di centrodestra non si è mai differenziato molto da quello delle coalizioni di centrosinistra dello stesso periodo.
Che questo sia il vero addebito mosso contro di lui dall’opinione neoliberista della sfera anglofona si può vedere dal trattamento che quest’ultima riserva a due emblemi simmetrici della corruzione a capo di stati a est e a ovest dell’Italia. Per anni Erdogan – un amico stretto di Berlusconi – è stato destinatario di interviste, profili e articoli smaccati sul Financial Times e altrove, che lo hanno presentato come l’architetto illuminato di una nuova democrazia turca e un ponte vitale tra l’Europa e l’Asia, da accogliere con tutta la dovuta rapidità nell’Unione. Diversamente da Berlusconi, tuttavia, il cui ruolo è stato anodino in materia di libertà civili, Erdogan è stato ed è una minaccia a esse. Tuttavia quando è decollato un boom turco con picchi di privatizzazioni, sono contate poco le incarcerazioni di giornalisti, gli assassinii di dimostranti, gli aggiustamenti di processi, le intimidazioni brutali contro l’opposizione – per non parlare dei peculati all’ingrosso – da parte del suo regime.
Persino quando la dimensione di questa violenza e corruzione non ha potuto più essere ignorata, i dettagli degli scandali che travolgevano il paese sono stati in generale mantenuti al minimo e il biasimo è stato rapidamente dirottato sulla UE per non aver esteso un abbraccio redentore con sufficiente solerzia. Una volta pubblicati i nastri di Erdogan la Frankfurter Allgemeine ha commentato che in qualsiasi democrazia funzionante normalmente quelle erano prove dieci volte sufficienti per costringere l’intero governo ad andarsene. Nemmeno un sussurro paragonabile sul Financial Times.
Commenti in larga parte simili potevano essere formulati su Rajoy e i suoi complici in Spagna, dove la pistola fumante è in realtà più evidente che nel labirinto di malefatte di Berlusconi. Ma Rajoy, diversamente da Berlusconi, è un intendente affidabile del regime neoliberista: nessuna richiesta di supplementi speciali sull’Economist per dettagliare i suoi misfatti, a proposito dei quali il giornale ha cura di dire il minimo possibile, in compagnia di Bruxelles e Berlino. “I leader e i dirigenti della UE hanno tenuto la bocca insolitamente chiusa sullo scandalo, se si considera l’importanza della Spagna per l’eurozona”, commenta Gavin Hewitt, il redattore della BBC per l’Europa. “La cancelliera tedesca Angela Merkel e altri hanno riposto molta fiducia nel signor Rajoy, che è considerato come un braccio sicuro per riforme dolorose mirate a resuscitare l’economia della Spagna”.
Berlusconi avrebbe pagato per tale assenza di fiducia.
Nell’ora del trionfo di Berlusconi nella primavera del 2008, quando ha conquistato la sua terza e più decisiva vittoria elettorale, le opinioni negative all’estero sul suo conto gli importavano poco. Il fronte di centrodestra che aveva organizzato e riorganizzato dal 1994 – a quel punto composto dal Popolo della Libertà, una fusione del suo precedente partito con quello del suo alleato di lungo corso, l’ex fascista Gianfranco Fini, più la Lega Nord di Umberto Bossi che manteneva la sua base e identità separata – deteneva una maggioranza egemone in entrambe le camere del parlamento. Nel suo primo mese in carica è stato compiuto un passo parallelo alla linea Thatcher/Blair, la fase iniziale di una serie di cambiamenti a partire dalle scuole elementari e per finire con le università che tagliava la spesa per l’istruzione di circa 8 miliardi di euro nell’interesse dell’economia e della competizione, riducendo il numero degli insegnanti, imponendo contratti a termine, introducendo le imprese nei consigli, quantificando la valutazione della ricerca.
Ma la misura dello zelo “riformatore” del governo è stata tutta qui. Al primo posto nella sua agenda politica erano le leggi ad personam per proteggere Berlusconi dalle incriminazioni penali ancora pendenti sul suo capo; molte erano state svuotate tirando in lungo per arrivare alla prescrizione, altre mediante la depenalizzazione. Nel 2003 il suo governo aveva approvato una legge che assicurava l’immunità dai processi alle cinque più alte cariche dello stato, cassata dalla Corte Costituzionale sei mesi dopo. Nell’estate del 2008 è tornato all’attacco con una legge presentata dal suo braccio destro al ministero della giustizia, l’avvocato siciliano Angelino Alfano, che sospendeva i processi per le quattro più alte cariche dello stato.
Pochi mesi dopo la tempesta finanziaria oltre Atlantico ha colpito l’Europa, prima in Irlanda e poi in Grecia. In Italia la Seconda Repubblica era stata sin dall’inizio un flop economico, nonostante i migliori sforzi dei premier del centrosinistra per correggere la situazione (Giuliano Amato aveva tagliato e privatizzato, Romano Prodi aveva messo il paese nella camicia di forza del Patto di Stabilità). I tassi della crescita italiana sono precipitati nel corso degli anni ’90. Dopo il 2000 sono ristagnati in una media dello 0,25 del PIL l’anno. Nel giro di un anno dalla rielezione di Berlusconi nel 2008 gli spread avevano già cominciato ad allargarsi tra i rendimenti dei titoli tedeschi e italiani. Arrivati al 2009 la recessione era più grave che in qualsiasi altro paese dell’eurozona, con il PIL sceso di più di cinque punti percentuali. Per tenere a bada i mercati finanziari, pacchetti finanziari d’emergenza hanno ridotto il deficit di bilancio dell’Italia, ma con i tassi d’interesse in ascesa sul terzo debito pubblico maggiore del mondo, arrivate alla fine del 2010 il governo era arrivato economicamente alla canna del gas.
Politicamente se la passava poco meglio. Da marzo a ottobre del 2009 i titoli dei giornali erano dominati da sensazionali rivelazioni sulle stravaganze sessuali di Berlusconi, dando un colore vistoso alla profetica descrizione di Giovanni del suo governo – mutuando un termine da Weber – come un sultanato. Sempre dedito a vantare le sue prodezze in camera da letto, con l’arroganza che a quel punto lo incitava a sconfiggere anche l’età, ha abbandonato l’elementare prudenza, riempiendo le liste del partito di soubrettes e flirtando con minorenni, al punto di provocare una rottura pubblica con sua moglie, Veronica Lario. Presto ha cominciato a ricevere prostitute nella sua residenza romana. Amareggiata per non aver ottenuto un permesso di costruzione a Bari che le era stato promesso, una di loro ha raccontato le sue visite. Nella sua sfarzosa villa di Arcore, fuori Milano, erano messe in scena orge nello stile di fantasie aggiornate da diciottesimo secolo, donne vestite da suore – anche da infermiere e poliziotte – a danzare e a spogliarsi per il possesso collettivo. Quando una delle partecipanti, una giovane marocchina, è stata successivamente arrestata per furto a Milano, Berlusconi ha telefonato per assicurare il suo rilascio perché nipote di Mubarak. Poiché aveva meno di diciotto anni, ne è seguita una procedura legale a carico di Berlusconi. Anche se la vicenda non è stata tanto dannosa quanto il disastro in cui sarebbe presto incorso Dominique Strauss-Kahn, presidente del FMI e favorito nella corsa alla presidenza francese, Berlusconi è stato indebolito dallo svilimento della sua immagine. Ma per il momento è sopravvissuto.
Una minaccia più grave alla sua posizione è venuta da un’altra direzione. Per presunzione, alimentata dal successo elettorale, ha perso il senso del limite in politica, aveva umiliato Fini, che aveva pensato di essere suo successore ed era presidente della Camera. Nell’estate del 2010, rendendosi conto che non poteva più aspettarsi di essere l’erede naturale del centrodestra e cedendo alle lusinghe dell’opposizione che avrebbe potuto persino dimostrarsi il leader migliore di un centrosinistra responsabile, Fina ha disertato. Portando con sé un numero di deputati sufficiente a privare il governo di una maggioranza stabile, ha mancato di poco di provocarne la caduta in autunno. Nella primavera del 2011 anche gli elettori hanno abbandonato il governo con Berlusconi che ha perso il controllo anche di una roccaforte quale Milano.
Nel corso di quell’estate, con l’intensificarsi della crisi dell’eurozona, con la Grecia prossima all’insolvenza, è aumentata la pressione dei mercati obbligazionari sull’Italia. La Germania, affiancata dalla Francia e dalla Banca Centrale Europea, a quel punto non faceva un segreto della sua determinazione a spezzare ogni resistenza a misure draconiane d’austerità e a eliminare i leader che avessero esitato ad attuarle, ad Atene o a Roma. In agosto Trichet e Draghi – presidenti uscente ed entrante della BCE – hanno trasmesso a Berlusconi un virtuale ultimatum. Due mesi dopo Papandreou è stato costretto in un vertice della UE ad accettare altri tagli feroci alla spesa pubblica e a impegnarsi a privatizzazioni generalizzate. Nel panico per la marea di rabbia popolare contro di esse – il presidente della Grecia era stato costretto ad abbandonare il palco a Salonicco nel corso della Festa Nazionale – ha annunciato un referendum al riguardo ed è stato convocato a Cannes seduta stante dalla Merkel e da Sarkozy e gli è stato detto di cancellare una simile iniziativa. Una settimana dopo si è dimesso. Nel giro di tre giorni Berlusconi lo ha seguito.
Le dinamiche della caduta di Berlusconi, tuttavia non sono state le stesse. In Grecia Papandreou presiedeva a un diffuso immiserimento su ordini di Berlino, Parigi e Francoforte che aveva scatenato massicce proteste sociali. Fino alla sua improvvisa idea di un referendum era stato uno strumento perfettamente accettabile della volontà dell’Unione, un atteggiamento confermato dalla velocità con cui aveva obbedito alla Merkel e a Sarkozy e aveva prontamente ritirato la sua proposta. Si è dimesso perché la sua posizione era diventata insostenibile all’interno.
In Italia non era in corso né un impoverimento né una mobilitazione popolare. La maggioranza di Berlusconi alla Camera era a quel punto limitatissima e alcuni dei suoi deputati si stavano impaurendo per l’aumento degli spread. Me egli resta in pieno controllo del Senato e doveva ancora essere messo al tappeto in tribunale. La sua posizione interna era sostanzialmente più forte di quella di Papandreou. Nella UE in generale, tuttavia, l’ostilità nei suoi confronti era molto maggiore poiché rappresentava un imbarazzo di lungo corso per la sua classe politica; e la decisione di Berlino e Francoforte di liberarsene, in quanto ostacolo alla necessaria purga dell’economia italiana e all’ordine sociale, più inesorabile.
***
Per la sua cacciata, tuttavia, era necessario un meccanismo per collegare l’erosione della sua posizione in patria, non ancora completa, con l’assoluta avversione nei suoi confronti all’estero. Per sua sfortuna esso era già pronto e adatto. Meno notata di altri mutamenti prodotti dalla Seconda Repubblica, c’era stata una forte crescita del ruolo della presidenza negli affari politici dell’Italia. Durante il regno della Democrazia Cristiana nella Prima Repubblica, quando un solo partito dominava sempre la legislatura, questa carica in larga misura cerimoniale raramente aveva avuto qualche importanza. Ma quando coalizioni politiche rivali hanno cominciato a confrontarsi per il potere nella Seconda Repubblica, si è aperto un nuovo spazio di manovra per la presidenza. Scalfaro – in carica al Quirinale tra il 1992 e il 1999 – è stato il primo a utilizzarlo, rifiutandosi di sciogliere il parlamento quando Berlusconi aveva perso la sua prima maggioranza nel 1994, agevolando invece al potere un mosaico di centrosinistra, per dargli tempo di mettere insieme le proprie forze per una vittoria alle urne con Prodi l’anno successivo.
Ora il presidente era, come Scalfaro, un ex ministro dell’interno, Giorgio Napolitano. Berlusconi aveva sostenuto l’elezione di Napolitano nel 2006 e aveva motivo di ritenere di aver fatto una scelta sensata nell’aiutare a salire al Quirinale questo veterano della classe politica tradizionale. Un ‘Vicario di Bray’ italiano, nella sua lunga carriera aveva esibito un principio fisso, l’adesione a qualsiasi tendenza politica mondiale apparisse vincente al momento. L’inizio di una lunga sequenza c’era stato nei suoi anni da studente, quando aveva aderito al Gruppo Universitario Fascista, in un periodo in cui l’Italia inviava truppe a unirsi ai nazisti nell’attacco contro la Russia. Una volta caduto il fascismo Napolitano ha optato per la forza in arrivo del comunismo. Iscrivendosi al PCI alla fine del 1945 ne ha poi rapidamente scalato i ranghi, arrivando al Comitato Centrale in poco più di un decennio. Quando le truppe e i carri armati sovietici hanno represso la Rivolta Ungherese nel 1956, egli ha applaudito. ‘L’intervento sovietico è stato il contributo decisivo non solo per impedire che l’Ungheria finisse nel caso e nella controrivoluzione, e difendendo gli interessi militari e strategici dell’URSS, ma anche salvando la pace nel mondo’, ha dichiarato al Congresso del Partito in quel novembre. Salutando l’espulsione di Solzhenitsyn dalla Russia nel 1964 ha dichiarato: “Solo commentatori sciocchi e faziosi possono evocare lo spettro dello stalinismo, trascurando il modo in cui Solzhenitsyn ha portato le cose a un punto di rottura’. A quel punto era il braccio destro di Giorgio Amendola, dopo la morte di Togliatti, la figura più formidabile del PCI. Come il suo patrono, era un inflessibile disciplinatore del dissenso nel partito, votando senza esitazioni la cacciata dal partito del gruppo del Manifesto per aver parlato fuori luogo contro l’invasione della Cecoslovacchia. Con gettoni sia nella segreteria sia nell’ufficio politico, era diffusamente visto come il successivo leader del PCI.
Nell’occasione il posto è andato a Enrico Berlinguer, come figura meno divisiva. Ma Napolitano è rimasto come ornamento di spicco del partito mentre passava all’eurocomunismo. Nei tardi anni ’70 è stato scelto come primo inviato del PCI per rassicurare gli Stati Uniti sulla sua affidabilità atlantica, diventando a tempo debito il ‘comunista preferito di Kissinger’, per usare le parole soddisfatte del New York Times. Arrivati agli anni ’80 il trasferimento dell’alleanza a un nuovo feudatario era completo. Il Terzo Reich un brutto ricordo, l’URSS in declino, gli USA erano a quel punto la potenza da coltivare. Responsabile dei rapporti con l’estero del PCI si sarebbe preso cura di ammorbidire le relazioni con Washington molto dopo che il partito era scomparso. Una volta presidente ha fatto di tutto per ingraziarsi sia Bush sia Obama.
In patria il fallimento della scommessa del PCI di raggiungere un ‘compromesso storico’ con la Democrazia Cristiana che gli avrebbe consentito l’ingresso nel governo e l’ascesa, invece – in mezzo una corruzione sempre più sfacciata – del Partito Socialista di Craxi come alleato chiave della DC ha indotto Berlinguer a fare una svolta a sinistra. Denunciando la degenerazione venale del sistema politico, ha diffuso un sonoro appello a far pulizia nella vita politica. Napolitano ha reagito rabbiosamente, accusandolo di isolazionismo settario e di ‘vuote invettive’. I rapporti erano sempre stati freddi tra i due uomini. Ma era in gioco qualcosa di più che una mera rivalità personale. Napolitano guidava la corrente più a destra nel PCI dell’epoca, i miglioristi che avvertivano una certa affinità con Craxi e non volevano ostilità con lui. La loro base principale era a Milano, dove la macchina di Craxi dominava la città. Lì, a metà degli anni ’80, pubblicavano un giornale, Il Moderno, non solo finanziato da Berlusconi ma che plaudiva ai suoi rivoluzionari successi nel modernizzare i media e nel fare di Milano la capitale televisiva d’Italia. Si era nel 1986, quando Craxi era primo ministro. Un tribunale avrebbe poi giudicato la holding Fininvest di Berlusconi colpevoli di finanziare illegalmente i miglioristi. In febbraio, durante i preparativi per un referendum contro il nucleare in Italia, il giornale del PCI ha rifiutato un articolo a favore del nucleare di Giovanni Battista Zorzoli, uno dei seguaci di Napolitano. Furioso, Napolitano ha preteso la testa del direttore. Nel 1993 Zorzoli è finito in manette, condannato a quattro anni e mezzo di carcere per corruzione quando era alto dirigente della compagnia statale italiana dell’elettricità.
Non molto tempo dopo, Napolitano è diventato ministro dell’interno nel governo di centrosinistra del 1996. Era la prima volta che qualcuno di sinistra fosse mai stato alla guida di tale ministero. Il coinvolgimento della polizia e degli apparati dei servizi segreti italiani nella cosiddetta ‘strategia della tensione’ [in italiano nel testo – n.d.t.] – una serie di attentati dal massacro di Piazza Fontana a Milano nel 1969 a quello alla stazione ferroviaria di Bologna nel 1980 – era ormai confermato da molto tempo, ma non era mai stato indagato. Ogni nervosismo riguardo al fatto che l’arrivo al ministero del comunista di un tempo è stato presto acquietato. Napolitano ha assicurato i suoi subordinati che non avrebbe ‘cercato scheletri negli armadi’. Nessuna rivelazione deplorevole ha macchiato il suo periodo in carica. E’ stato nominato senatore a vita nel 2005. Diventato presidente della repubblica un anno dopo ha lamentato pubblicamente che Craxi – che era morto in esilio in Tunisia dopo essere stato condannato in contumacia a 27 anni di carcere per una corruzione colossale – era stato trattato scorrettamente, prendendosi il disturbo di elogiare il suo ruolo costruttivo di statista.
Non ha avuto lo stesso riguardo per Berlusconi, considerandolo con condiscendenza benevola – anche con una certa giustizia – come in realtà per nulla un politico, nel senso in cui lo erano stati gli uomini eminenti della Prima Repubblica. I due uomini comunque non potevano essere più opposti quanto a stile. La correttezza cerimoniale di Napolitano era in studiato contrasto con la spudorata spacconeria di Berlusconi. Ma condividevano un passato comune nello snodo di legami e simpatie che circondava Craxi a Milano, e un comune interesse a stabilizzare quelli che entrambi consideravano i potenziali vantaggi della Seconda Repubblica: un sistema politico bipolare in stile anglosassone, confinato a un centrodestra e un centrosinistra, liberato dall’ostilità nei confronti del mercato del suo guardiano transatlantico. Per ragioni proprie ciascuno, inoltre, temeva la perseveranza dei pubblici ministeri nello scovare accuse contro il leader più popolare del paese e il risentimento di minoranze irresponsabili nell’insistere su di esse.
Per Berlusconi si trattava, naturalmente, di minacce esistenziali. Per Napolitano erano semplicemente divisive, proprio come lo era stato il moralismo di Berlinguer, compromettendo sconsideratamente l’equilibrio del consenso moderato di cui il paese aveva bisogno. E’ stato più che disposto ad aiutare Berlusconi a proteggersi da questi problemi, firmando senza esitazione la legge del Lodo Alfano del 2008 che garantiva a Berlusconi, come primo ministro, e a sé stesso, da presidente, l’immunità dai processi; e quando la legge è stata dichiarata incostituzionale, apponendo il suo timbro con uguale velocità sulla legge sostitutiva approvata nel 2010, sul ‘legittimo impedimento’ [in italiano nel testo – n.d.t.] che consentiva ai ministri di evitare i processi invocando i loro pressanti doveri di pubblico servizio, legge a sua volta dichiarata incostituzionale nel 2011. Napolitano è stato criticato pubblicamente per la sua inopportuna approvazione della prima da parte di Ciampi, il suo predecessore alla presidenza, e non era tenuto neppure a lasciar passare la seconda; piuttosto era vero il contrario come doveva dimostrare il seguito legale di entrambe. Le azioni di Napolitano, tuttavia, si sono accordate con le aspettative di Berlusconi di un modus vivendi tra loro, sulle cui basi quest’ultimo lo aveva appoggiato per la presidenza. Un’altra espressione pregnante di tale accordo si è avuta quando la diserzione di Fini ha privato il governo Berlusconi della maggioranza alla Camera e l’opposizione ha discusso un voto di sfiducia, con i voti in mano per far cadere il governo. Nel 2008 Prodi era stato in una situazione simile dopo che Berlusconi aveva comprato voti al Senato sufficienti a farlo cadere, un episodio per cui è attualmente incriminato per aver pagato a un solo senatore tre milioni di euro per cambiare cappotto, una mazzetta che il beneficiario ha confessato. Allora Napolitano aveva perso poco tempo – meno di due settimane – per usare la sua prerogativa presidenziale di sciogliere il parlamento e convocare nuove elezioni, che avevano prodotto una valanga a favore di Berlusconi. Questa volta, comunque, Napolitano ha persuaso Fini a fermarsi per più di un mese mentre veniva approvata una legge di bilancio, garantendo a Berlusconi il tempo necessario per comprare il pugno di deputati necessario per ripristinare la sua maggioranza.
***
Questo è stato, comunque, l’ultimo favore che Napolitano ha potuto accordare. Si stava preparando a prendere le cose nelle proprie mani. Nella primavera del 2011 il governo ha annunciato che si stava unendo all’attacco alla Libia guidato dagli statunitensi, al quale la Lega Nord si opponeva assolutamente, minacciando di farlo cadere se lo avesse fatto. Napolitano la sapeva più lunga: le aspettative di Washington erano più importanti delle sottigliezze della costituzione. Senza alcun voto in parlamento, e nemmeno un dibattito al suo interno, ha mandato l’Italia in guerra strappando il sostegno degli ex comunisti all’invio dell’aviazione del paese a bombardare un vicino con il quale aveva firmato un Trattato di Amicizia, Cooperazione e Alleanza Militare, ratificato da una schiacciante maggioranza alla Camera – ex comunisti compresi – solo due anni prima.
Arrivati all’estate, incoraggiato dalla crescente adulazione sui media nei suoi confronti come rocca della repubblica, e con l’incoraggiamento di Berlino, Bruxelles e Francoforte, aveva deciso di disfarsi di Berlusconi. La chiave per rimuoverlo agevolmente consisteva nel trovare un sostituto che soddisfacesse questi partner decisivi e la dirigenza del mondo degli affari in Italia. Fortunatamente la figura ideale era a portata di mano: Mario Monti, ex commissario UE, membro del Gruppo Bilderberg e della Commissione Trilaterale, consigliere anziano della Goldman Sachs e allora presidente dell’Università Bocconi. Monti aveva per qualche tempo atteso proprio la situazione che a quel punto si presentava. ‘I governi italiani sono in grado di prendere decisioni dure’, aveva confidato all’Economist nel 2005, ‘solo se sono soddisfatte due condizioni: devono esserci sia un’emergenza visibile sia una forte pressione dall’esterno’. All’epoca, lamentava, ‘tale momento della verità non c’è’. Ora era arrivato.
Già da giugno o luglio, in completa segretezza, Napolitano aveva preparato Monti ad assumere il governo. Nello stesso periodo aveva commissionato al capo del maggior gruppo bancario italiano, Corrado Passera, l’elaborazione di un piano economico confidenziale per il paese. Passera era un ex assistente dell’arcinemico politico di Berlusconi e rivale in affari Carlo De Benedetti, proprietario di La Repubblica e di L’Espresso, che era al corrente delle mosse di Napolitano. In urgente corsivo il documento di 196 pagine di Passera proponeva una terapia shock: cento miliardi di euro di privatizzazioni, tassa sulla casa, imposte sui capitali, un’impennata dell’IVA. Napolitano, al telefono con la Merkel e indubbiamente con Draghi, aveva a quel punto pronti il piano e l’uomo per cacciare Berlusconi. Monti non si era mai candidato alle elezioni e anche se un seggio in parlamento non è indispensabile per l’investitura a primo ministro, sarebbe stato d’aiuto averne uno.
Non c’era tempo da perdere: il 9 novembre, prelevandolo dalla Bocconi, Napolitano ha nominato Monti senatore a vita, con l’applauso della stampa finanziaria mondiale. Sotto minaccia della distruzione da parte dei mercati obbligazionari nel caso si fosse opposto, Berlusconi ha capitolato e nel giro di una settimana Monti ha giurato da nuovo governante del paese, alla guida di un governo non eletto di banchieri, uomini d’affari e tecnocrati. L’operazione che lo ha installato è un’illustrazione espressiva di che cosa possono significare oggi in Europa le procedure democratiche e il primato della legge. E’ stato tutto assolutamente incostituzionale. Il presidente dell’Italia dovrebbe essere il guardiano imparziale di un ordine parlamentare, che non interferisce con le decisioni di quest’ultimo salvo quando violano la costituzione, come questo presidente ha segnatamente mancato di fare. Non ha il potere di cospirare, alle spalle di un premier eletto, con persone di sua scelta, nemmeno in parlamento, per formare un governo di suo piacimento. La corruzione del mondo degli affari, della burocrazia e della politica è stata a quel punto aggravata dalla corruzione della costituzione.
All’epoca ciò che era accaduto quell’estate dietro gli arazzi presidenziali era rimasto celato. Sarebbe venuto alla luce solo quest’anno per bocca dello stesso Monti, un ingenuo in queste faccende, provocando balbettanti smentite di Napolitano. Contemporaneamente la reazione del sistema al nuovo governo spaziava dal sollievo all’esultanza. Finalmente – nella visione diffusa dei commentatori dentro e fuori dal paese – c’era per l’Italia una seconda occasione per voltar pagina, occasione mancata dopo il crollo della Prima Repubblica. Finalmente era al timone un governo onesto e competente, impegnato non solo a serie riforme del tanto che era sbagliato in Italia – mercati del lavoro rigidi, pensioni insostenibili, università nepotiste, restrizioni corporative ai servizi, assenza di competizione industriale, privatizzazioni insufficienti, ingorgo della giustizia, evasione fiscale – ma anche in grado di dominare le tempeste finanziarie che aggredivano il paese. Una nuova Seconda Repubblica, quella vera, poteva ora sorgere dopo vent’anni di messinscene. Tagli profondi alla spesa pubblica, dure misure fiscali e l’inizio di cambiamenti alla disastrosa legge sul lavoro degli anni ’70 sono stati i primi, apprezzati passi per ripristinare la fiducia nel paese.
Viste da un’altra angolazione c’erano in effetti somiglianze tra la congiuntura dei primi anni ’90 quando Ciampi, allora governatore della Banca d’Italia, era stato chiamato a difendere il forte da premier nel pieno della crisi di Tangentopoli. Ma non erano per nulla rassicuranti. Il governo Monti somigliava al governo Ciampi nella composizione e nelle intenzioni. Ma molto era cambiato nel frattempo, non ultimo l’ambiente da cui provenivano le figure di spicco del nuovo ordine: Monti e il suo garante a Francoforte, Draghi. Nel 1994 Berlusconi si era presentato da innovatore da un passato imprenditoriale e la cui vittoria avrebbe sepolto la corruzione e il disordine della classe politica della Prima Repubblica, mentre egli in realtà doveva la sua fortuna prevalentemente a essi. Nel 2011 la crisi che strozzava l’Italia e l’Eurozona era stata scatenata da una massiccia ondata di speculazioni finanziarie e di manipolazioni di derivati su entrambe le sponde dell’Atlantico. Nessun operatore era più famigerato per la sua parte in ciò che la stessa società sul cui libro paga avevano figurato Monti e Draghi. La Goldman Sachs, che si era guadagnata negli Stati Uniti il nomignolo di ‘piovra vampiro’, aveva assecondato la falsificazione dei conti pubblici greci e poi era stata accusata di frode dalla Commissione Titoli e Scambi (SEC) versando mezzo miliardo di dollari per transare la causa extragiudizialmente. Attendersi un taglio netto con il passato da simili funzionari era poco più realistico che credere che il patrocinio di Craxi non avrebbe lasciato nessun segno su Berlusconi.
Altri ricordi del passato erano non meno impressionanti. Nell’estate del 2012 è emerso che Napolitano era intervenuto per bloccare il potenziale interrogatorio di Nicola Mancino, ministro democristiano dell’interno nel 1992 quando il magistrato di Palermo Paolo Borsellino era stato assassinato dalla mafia. Mancino era uno dei quattro ministri dell’interno – Scalfaro era stato un altro – che ricevevano mensilmente fondi neri dal servizio segreto SISDE. La negazione di Mancino di aver incontrato Borsellino poco prima della sua morte, nonostante prove del contrario, non era mai stata chiarita ed era in corso una nuova indagine ufficiale sui collegamenti tra stato e mafia, che minacciava di metterlo a confronto con due altri ministri del periodo che lo avevano smentito. In grande agitazione ha telefonato al Quirinale e ha implorato protezione dal braccio destro di Napolitano per gli affari legali, Loris D’Ambrosio. Lungi dall’essere respinto gli è stato che il presidente era molto preoccupato per lui. A tempo debito lo stesso Napolitano ha telefonato a Mancino, inconsapevole che il telefono di quest’ultimo erano intercettato come parte dell’indagine.
Quando le trascrizioni degli scambi tra Mancino di D’Ambrosio sono state pubblicate sulla stampa, assieme alla notizia che i nastri delle conversazioni dello stesso presidente con Mancino erano in possesso del magistrato inquirente, Napolitano ha invocato l’assoluta immunità per la sua carica e, in stile Nixon, ha preteso che i nastri fossero distrutti. Il fratello di Borsellino, Salvatore, ha chiesto la sua messa in stato d’accusa; poiché era implicata chiaramente un’ostruzione alla giustizia, negli Stati Uniti ci sarebbero state basi per essa. In Italia un esito simile era impensabile. La classe politica e i media hanno immediatamente serrato i ranghi a difesa del presidente, come era stato fatto quando Scalfaro aveva usato il suo maggiordomo per soffocare lo scandalo del SISDE. L’assistente di Napolitano, l’Ehrlichman dell’affare, è morto di attacco cardiaco nel bel mezzo del putiferio. Come accade spesso Marco Travaglio, probabilmente il più grande giornalista d’Europa, è stato l’unico a chiamare i fatti con il loro nome; nel suo libro ‘Viva il Re!’, pubblicato l’anno scorso, ha tracciato un’esauriente atto d’accusa circa i precedenti di Napolitano in carica, in seicento pagine di documentazione incriminatrice. Altrove, di fronte al pericolo per la sua posizione, il coro dei sicofanti attorno al presidente – il cui volume andava crescendo da un certo tempo – ha raggiunto un crescendo isterico.
Nel frattempo Monti – salutato all’inizio con entusiasmo, con il Financial Times sdolcinato a proposito di ‘Super Mario’ – si dimostrava una delusione. Insediato con l’assenso riluttante sia del centrodestra sia del centrosinistra, il suo spazio di manovra era limitato, poiché nessuno dei due blocchi gli era devoto e la base di ciascuno era insofferente per la soluzione. Ma presto è divenuto chiaro che i suoi rimedi non portavano alcuna ripresa. Sotto quello che un critico italiano aveva definito il suo regime ‘d’austerità’, la combinazione di Monti di tasse più elevate e di spesa ridotta è stata in grado di ridurre il deficit e di abbassare gli spread, ma ha intensificato la recessione. I consumi sono caduti, la disoccupazione giovanile è esplosa. Le riforme strutturali, come le interpretano la Commissione Europea e la BCE, sono fallite. Nel 2012 il PIL si è ridotto del 2,4 per cento. Politicamente c’era poco da guadagnare continuando a sostenere quello che era diventato un governo del tutto impopolare. Alla fine dell’anno il centrodestra si è ritirato e Napolitano è stato costretto a sciogliere con riluttanza il parlamento, conservando Monti in carica ad interim fino a quando non si fossero tenute le elezioni.
I sondaggi avevano indicato per un certo periodo che il centrodestra deteneva un costante primo posto nelle intenzioni di voto ed era certo di vendicare l’umiliazione del 2008. Monti si era dimostrato un flop. Berlusconi era sempre più screditato e la coalizione di centrodestra si era divisa in tre. Non solo Fini aveva rotto con Berlusconi, ma anche Bossi lo aveva abbandonato, rifiutandosi di offrire sostegno al governo mondo prima di trovarsi anch’egli travolto da uno scandalo di corruzione e messo da parte in una Lega molto indebolita. Arrivati all’autunno, le tre parti separate dell’ex coalizione attiravano a malapena un quarto dell’elettorato.
Il centrosinistra, pur se esso stesso lungi dal prosperare, era in forma migliore. Il rinominato Partito Democratico, nato da una fusione tra i resti di quello che un tempo era stato il Comunismo Italiano e un’ala della Democrazia Cristiana, aveva conseguito risultati disastrosi nel 2008, sotto l’insignificante leader Walter Veltroni, agli occhi amorevoli di Napolitano l’”Obama ante litteram”. Dopo le dimissioni di Veltroni il PD ha acquisito un nuovo leader, Pierluigi Bersani, dai ranghi degli amministratori dell’Emilia dell’ex PCI e un cambio d’immagine in meglio, dallo scialbo all’impassibile. Senza essere un ispiratore, la leadership di Bersani ha almeno evitato un’ulteriore caduta del sostegno al partito, lasciandolo a un livello abbastanza stabile nei sondaggi d’opinione, ben davanti al centrodestra. Nell’autunno del 2012, sfidato dal giovane sindaco di Firenze, Matteo Renzi, che si era fatto un nome sollecitando la rottamazione dell’intera vecchia generazione dei politici, Bersani lo ha sconfitto comodamente alle primarie del partito, sulla base di una considerevole affluenza che ha fatto salire la credibilità del PD, migliorando il suo primo posto nei sondaggi.
Restava un’incognita. Tre anni prima il comico Beppe Grillo aveva lanciato un movimento contro il sistema politico che aveva ottenuto alcuni successi in elezioni locali. Non era chiaro quanto seriamente andasse preso. Ma poiché nulla di simile esisteva in Europa e non c’erano precedenti per giudicarlo, non poteva essere ignorato. Grillo aveva cominciato da cabarettista negli anni ’70, passando a programmi televisivi popolari la cui lama politica si era gradualmente affilata. Nel 1986, dopo aver fatto una battuta sul fatto che a un banchetto per Craxi a Pechino uno dei suoi luogotenenti gli aveva chiesto sconcertato ‘se qui tutti sono socialisti, a chi rubano?’, Grillo era stato cancellato dai canali pubblici. Non era la sua sola previsione su quello che stava per succedere. Negli anni ’90 si è sempre più esibito in teatri e piazze in monologhi con un forte calco ambientalista, denunciando gli innumerevoli scandali del periodo con un misto di crude volgarità e umorismo feroce.
Il suo pubblico è cresciuto e poi ha fatto un balzo quando ha cominciato a usare Internet come mezzo alternativo per demolizioni stroncanti dell’ordine dominante e del suo personale, di centrodestra e centrosinistra, tanto della televisione quanto della stampa. Il suo blog è diventato un successo istantaneo. ‘Schiavi moderni’, un libro ricavato dalle risposte dei lettori al blog, ha allargato i suoi bersagli al destino del lavoro precario in Italia. A quel punto stava collaborando strettamente con un specialista software, Gianroberto Casaleggio, e nel 2009 i due hanno lanciato il Movimento 5 Stelle come rivolta contro il sistema politico. Le stelle stavano per i temi chiave che intendevano promuovere: acqua (sotto minaccia di privatizzazione), ambiente, trasporti, connettività e sviluppo. I candidati del M5S che correvano per le elezioni dovevano impegnarsi – cosa unica nel mondo – a non apparire in televisione e, se fossero stati eletti, a ridurre i loro stipendi parlamentari al salario medio, destinando il resto a fini pubblici. Lo stesso Grillo era inibito dal candidarsi al Parlamento a causa di una condanna per omicidio colposo quando aveva trent’anni, quando il suo fuoristrada era caduto in un burrone scivolando sul ghiaccio e uccidendo tre dei passeggeri. Ma non era inibito dal condurre la campagna elettorale. Girando per tutto il paese in uno Tsunami Tour che ha toccato circa ottanta città, la sua brizzolata capigliatura battagliera ormai familiare a tutti, ha attaccato non solo le ‘due caste’ – politici e giornalisti – dell’Italia, ma anche la dirigenza burocratica e bancaria europea in generale, il suo ordine di austerità neoliberista e la moneta unica. Grandi folle di impegnati o curiosi hanno affollato i suoi incontri.
Quando sono arrivati i risultati, il PD ha subito un doppio shock. Anche se la coalizione residua di Berlusconi era crollata di sette milioni di voti, la sua resistenza come propagandista aveva portato il centrodestra, che all’inizio sembrava una causa persa, a un soffio dalla vittoria: solo lo 0,35 per cento dietro il centrosinistra, anch’esso sceso di più di tre milioni di voti e con nessuno dei due blocchi che aveva raggiunto almeno il 30 per cento del voto totale. Il M5S, d’altro canto, era passato da zero al 25 per cento diventando – escludendo il voto all’estero – il maggiore partito singolo del paese, attirando elettori da entrambi i campi tradizionali. Il motto di Grillo in tre passi per sollevare una rivolta popolare – risate, informazione, azione politica – si era dimostrato sorprendentemente efficace. I grillini avevano ottenuto più voti, sia del centrodestra sia del centrosinistra, dai lavoratori manuali, dai piccoli imprenditori, dagli autonomi, dagli studenti e dai disoccupati; il centrodestra aveva prevalso solo tra le donne di casa, il centrosinistra tra i pensionati e gli impiegati.
Tale era l’aritmetica elettorale. I numeri in parlamento erano un’altra faccenda. Centrale per la Seconda Repubblica era stato, al suo inizio nel 1993, un cambiamento del sistema elettorale: l’abolizione della rappresentanza proporzionale a favore di un sistema maggioritario largamente in stile anglosassone . Nessun altro cambiamento era stato sollecitato più appassionatamente, come chiave per un governo responsabile ed efficiente, dal pensiero unico dell’epoca. Non ne era seguito nulla del genere. Un decennio dopo, nel 2005, la coalizione di centrodestra in carica, temendo la sconfitta sotto tale sistema – di cui in precedenza aveva beneficiato – lo aveva modificato in un sistema formalmente proporzionale, ma integrato da un premio che dava a qualsiasi coalizione ottenesse i maggiori voti, indipendentemente dalla percentuale dei voti ricevuti, un premio automatico del 54 per cento dei seggi alla Camera. Descritto sprezzantemente come una porcata persino dal ministro responsabile di averlo ideato, il paladino della Lega Nord Roberto Calderoli, il Porcellum, come era divenuto noto, era il discendente di due altre famigerate distorsioni della volontà popolare in Italia: la Legge Acerbo del 1923, fatta approvare da Mussolini per consolidare il suo governo, che assegnava due terzi dei seggi al parlamento a qualsiasi partito avesse la maggioranza dei voti sopra una soglia del 25 per cento, e la Legge Truffa di Scelba del 1953, che assegnava il 65 per cento dei seggi a qualsiasi coalizione ottenesse più del 50 per cento dei voti e che fu così impopolare che dovette essere abrogata una volta che la coalizione democrazia al governo non ottenne il richiesto 50 più uno dei voti nelle sole elezioni tenutesi regolate da essa. Il Porcellum era meno generoso dei suoi predecessori fascista e democristiano nella misura del premio – il 54 contro il 65/66 dei deputati – ma anche meno esigente nei presupposti per ottenerlo, non essendo necessario nemmeno un quarto dei voti per avere più di metà dei seggi alla Camera.
Nel 2013 ciò si è tradotto nel fatto che il centrosinistra – che anche ai suoi stessi occhi aveva ottenuto risultati disastrosi ai seggi – nonostante ciò, in virtù del suo minuscolo margine di vantaggio, ha ottenuto una schiacciante maggioranza di deputati: 345 rispetto ai 125 del centrodestra e ai 109 del M5S, su 630. Ma la cosa non ha aperto la via al governo. Poiché in base alla costituzione il Senato – i cui poteri sono di uguale livello – richiede una base elettorale regionale. Il premio assegnato dal Porcellum su base nazionale non poteva perciò applicarsi a esso, come ha segnalato Ciampi, che era presidente quando il Porcellum è stato introdotto. Doveva invece andare alla coalizione con il numero maggiore dei voti in ciascuna regione. Il risultato era molto meno favorevole al PD che aveva ottenuto non più di 123 seggi su 315. Formare un governo necessitava di un voto di fiducia in entrambe le Camere.
Per crearne uno Bersani doveva concludere un accordo – di coalizione o di tolleranza – con Berlusconi o Grillo. Il primo era un anatema per la base del PD, così ha tentato con il secondo. Ma Grillo non era interessato. Per il M5S il risultato ideale dello stallo post-elettorale era un governo congiunto Berlusconi-Bersani, a dimostrazione della sua affermazione che centrodestra e centrosinistra erano due facce della stessa medaglia (essendo PDL l’acronimo del partito di Berlusconi, Grillo si riferiva a quello di Bersani come ‘PD meno L’) nei confronti della quale il M5S era l’unica opposizione autentica. Ciò lasciava la scelta di un governo di minoranza di centrosinistra basato su una tolleranza ad hoc sulle sue misure. Napolitano, il cui invito era necessario per presentare un governo all’investitura in parlamento, ha rifiutato ciò. Insoddisfatto che il governo che Monti aveva messo insieme, appoggiato sia dal centrosinistra sia dal centrodestra, fosse arrivato a una fine prematura, ne ha voluto una riedizione. Coerente con una carriera di adesione a quali che fossero i poteri forti del momento, per lui ora si trattava della UE le cui direttive erano la pietra di paragone della responsabilità. Dunque l’imperativo era un governo bipartisan che proteggesse dal malcontento populista la stabilità e l’austerità richieste da Francoforte e Bruxelles. Di fronte a questa prospettiva Bersani si è impuntato. Non era in vista alcuna soluzione allo stallo quando – dopo sei settimane di trattative post-elettorali – è venuto a scadenza il mandato di Napolitano. La stampa si è riempita di editoriali che lo supplicavano di accettare un secondo mandato come unico argine contro il caos. Ma era una regola non scritta che nessun presidente italiano avesse più di un mandato e Napolitano ha rifiutato ripetutamente e categoricamente tale idea. Aveva compiuto il suo dovere e stava facendo le valigie.
Nel farlo ha reso un ultimo servizio. Il 5 aprile ha graziato il colonnello statunitense Joseph Romano, condannato in contumacia a sette anni per la sua parte nel rapimento a Milano di un religioso egiziano che era stato poi spedito al Cairo su un aereo militare statunitense per esservi torturato per mesi dalla polizia di Mubarak. Costituzionalmente la grazia presidenziale può essere concessa solo per motivi ‘umanitari’ e non per motivi ‘politici’. Romano non aveva passato in prigione neppure un giorno, essendo fuggito dal paese. Ma Obama aveva personalmente richiesto che si chiudesse un occhio sulla sua bagatella e Napolitano non ha esitato, come tanto spesso in precedenza, a violare la costituzione, spiegando di aver graziato Romano ‘per ovviare a una situazione di evidente delicatezza con un paese amico’. Il feudatario era cambiato e anche i reati. L’atteggiamento nei confronti del potere più elevato no.
Il presidente italiano è eletto da una sessione congiunta delle due Camere del Parlamento, più rappresentanti delle regioni, a scrutinio segreto. Per l’elezione è necessaria una maggioranza di due terzi nelle prime tre votazioni e successivamente una maggioranza semplice. Poiché il voto è segreto la disciplina di partito è debole e possono essere necessarie molte votazioni per produrre un candidato vincente. Nel 2006 Napolitano era passato al quarto voto. Nel 2013 gli elettori erano 1.007, richiedendo 672 voti nel primo gruppo di votazioni e 504 poi. Il centrosinistra ne aveva 493, una posizione di partenza di una forza senza precedenti. Ma poiché il presidente deve essere super partes, la consuetudine vuole che un candidato vincente debba godere di un certo livello di consenso trasversale. Il PD ha così cercato un accordo con il centrodestra su una figura che entrambi potessero appoggiare. E’ stato scelto Franco Marini, un veterano della Democrazia Cristiana ed ex presidente del Senato. Immediatamente attaccato come fossile screditato da Renzi, la cui fazione nel PD ha disertato, ha ottenuto 521 voti, molto meno di due terzi ma sufficienti nel caso di maggioranza semplice.
Innervosito da questo intoppo, anziché tener duro fino alla quarta votazione il PD ha abbandonato Marini e ha votato disordinatamente scheda bianca nei due turni successivi, in cui il giurista Stefano Rodotà, proposto dal M5S, è arrivato primo con 230 e 250 voti. Grillo, abbandonando il suo rifiuto di avere qualsiasi cosa a che fare con il PD, si è appellato a esso perché unisse le forze con il M5S per eleggere Rodotà alla votazione successiva, lasciando intendere che se ciò fosse stato fatto, sarebbe stata possibile una collaborazione tra i due in vista di un accordo su un governo. Rodotà non era una scelta settaria; largamente rispettato era egli stesso un ex presidente della precedente incarnazione del PD. Ma da puntiglioso quanto alla legalità costituzionale non era accettabile per il partito che era diventato, che temeva che potesse impedire le modifiche istituzionale che aveva in mente, per non parlare della distruzione di qualsiasi intesa con Berlusconi per il quale egli costituiva un anatema.
Schierando le sue truppe, Bersani ha proposto invece Romano Prodi, il cui nome ha ricevuto una standing ovation dal suo partito. A quel punto basta una maggioranza semplice. Il centrodestra ha disertato l’urna. Tuttavia quando i voti sono stati contati, Prodi ne ha ricevuti solo 395, cento in meno rispetto a quelli in possesso del centrosinistra. Questa volta a sabotare non è stata tanto la fazione di Renzi, quando i seguaci del suo arcinemico D’Alema, che ancora coltivava rancore contro Prodi dai tempi della loro rivalità negli anni ’90. Il PD si è ritrovato a dimostrarsi una marmaglia demoralizzata, apparentemente incapace di un minimo di lealtà e unità politica. In lacrime, Bersani si è dimesso da leader e in mezzo ad assordanti ululati della stampa circa i pericoli di ingovernabilità cui si trovava esposto il paese, il partito è corso a unirsi a Berlusconi nel pregare Napolitano di salvare l’Italia accettando un secondo mandato. Con molte proteste che ciò era contro la sua volontà, egli ha graziosamente accettato e al sesto voto è riscivolato senza problemi nel palazzo che aveva appena apparentemente lasciato vuoto. All’età di 87 anni, secondo solo a Mugabe, Peres e al moribondo re saudita.
Il governo doveva ancora essere formato ma con Bersani – una figura troppo trasparente per essere congeniale – tolto di mezzo, Napolitano poteva procedere a ricreare un governissimo [in italiano nel testo – n.d.t.] di suo gradimento, di un incastro di centrosinistra e centrodestra. Questa volta poteva farlo più apertamente, convocando i leader a conferire con lui e dettando le loro scelte. Come premier ha scelto il vice presidente del PD, Enrico Letta, un ex democristiano il cui zio, Gianni Letta, era il più raffinato dei consiglieri di Berlusconi. Vicepremier è diventato Alfano, responsabile della legge che aveva conferito immunità a Berlusconi e a Napolitano. Un funzionario della Banca Centrale è stato insediato al Tesoro come garanzia di continuità con le politiche di Monti e di rispetto del Fiscal Compact. Berlusconi, tuttavia, che doveva la sua ripresa elettorale alla promessa che avrebbe cancellato l’imposta di Monti sulla casa e bloccato qualsiasi altro aumento dell’IVA ha fatto dell’attuazione di queste promesse una condizione dell’assenso alla coalizione. Il risultato è stato un governo che ha zigzagato inefficacemente tra impegni incompatibili. Arrivati alla fine d’anno l’economia si era contratta di un ulteriore 1,9 per cento e il debito era salito al 133 per cento del PIL. Dati economici a parte, il governo Letta è stato rapidamente macchiato da due scandali di un genere familiare. Alfano, che era anche ministro dell’interno, è rimasto colluso nel trasferimento della moglie e della figlia di un dissidente kazako nelle grinfie di Nazarbaev, mentre il ministro della giustizia, Anna Maria Cancellieri, è stata colta a dire alla figlia incarcerata di un magnate delle costruzioni diffusamente ritenuto avere collegamenti con la mafia (in tempi passati un sostenitore de Il Moderno) che da amica di famiglia avrebbe fatto il possibile per lei, a tempo debito liberandola a motivo della sua anoressia. Pur se ci sono state proteste in entrambi i casi, nessuno dei due ministri è caduto, avendo Napolitano e Letta al loro fianco. In parlamento il culto del presidente ha raggiunto un punto talmente grottesco che i presidenti di entrambe le Camere hanno formalmente vietato addirittura di citare Napolitano dai banchi, in quanto affronto alla dignità della repubblica. Naturalmente lo stesso innominabile ha deprecato una protezione così eccessiva.
L’altro obiettivo principale del governo era la riforma elettorale per cancellare il porcellum e una modifica della Costituzione per cancellare il Senato. Poiché in base alle norme esistenti quest’ultimo sarebbe stato un processo lungo, è stata introdotta una proposta di legge per accorciarlo. L’attenzione del pubblico, comunque, è stata presto distratta dal dramma delle disgrazie di Berlusconi. In giugno è stato giudicato colpevole di induzione alla prostituzione di una minore e condannato a sette anni di carcere. Pur non aiutando la sua immagine, la sentenza lo ha danneggiato poco nel breve termine; appelli successivi contro di essa sono stati in grado di ritardare il giudizio finale di anni. Ma in agosto è arrivata sentenza simile: quattro anni di carcere (tre di essi cancellati) per evasione fiscale personale – 7,3 milioni di euro pagati in meno – e un’interdizione di due anni dai pubblici uffici. La condanna al carcere, a sua volta, ha fatto scattare la previsione di una legge approvata nei mesi finali del governo Monti che escludo dalla carica per sei anni chiunque subisca una condanna simile. La sua applicazione ha comportato l’espulsione di Berlusconi dal Senato.
Consapevole che ciò avrebbe rischiato una ribellione del centrodestra che avrebbe fatto cadere il suo governo, Letta non ha avuto alcuna fretta di accelerare il provvedimento, mentre Berlusconi indirizzava appelli sempre più frenetici a Napolitano perché lo salvasse, nella speranza, o convinzione, che la loro intesa del passato si sarebbe estesa a tale solidarietà. Napolitano era disponibile a far intendere che se Berlusconi avesse chiesto la grazia, ammettendo la sua colpevolezza (egli protestava la sua innocenza) avrebbe potuto riceverla in considerazione della sua importanza per la vita politica del paese. Ma non c’era possibilità che Napolitano si spingesse oltre. Non era un sentimentale: Berlusconi non era più da tenere in considerazione come in passato. Furioso per questa freddezza, Berlusconi ha preteso che i ministri del suo partito si dimettessero dal governo, come preparativo per farlo cadere. All’inizio hanno obbedito ma poi hanno riflettuto sul loro posto e sul probabile destino del centrodestra se ci fossero state nuove elezioni in una situazione simile. La conseguenza è stata una scissione aperta, con Alfano che ha portato fuori dal controllo di Berlusconi un numero di parlamentari sufficiente a formare un nuovo partito di centrodestra, dando al governo una maggioranza stabile non più subordinata ai suoi capricci. Dieci giorni dopo Berlusconi è stato allontanato dal Senato.
La vittoria di Letta pareva completa. Le sue abilità diplomatiche, affinate in una tradizione democristiana, avevano avuto un ruolo chiave nello staccare Alfano e i suoi seguaci dal loro leader. Fini era stato un outsider. Alfano era un membro vero, l’erede apparente: la sua defezione è stato la prima vera scissione nel partito che Berlusconi aveva costruito attorno a sé stesso. Ma il trionfo di Letta si è dimostrato breve. Nel giro di giorni Renzi aveva fatto man bassa alle primarie per la presidenza del PD lasciata vacante da Bersani e fatto piazza pulita della vecchia guardia del partito, imbottendo la direzione in carica del suo apparato con esperti e simpatizzanti della sua generazione. Ancora sindaco di Firenze e neppure in Parlamento, ma ora al comando del più numeroso contingente di deputati, aveva più potere reale di Letta e non ha sprecato tempo nel dimostrarlo.
Berlusconi poteva essere un reo condannato, ma non era un paria; piuttosto era l’interlocutore naturale del nuovo leader, un politico che si era ritirato all’opposizione ma non buttato fuori dal ring, a capo del secondo partito maggiore del paese. La via da percorrere era concludere un patto con lui. In men che non si dica Renzi ha avuto discussioni confidenziali con Berlusconi e i due hanno raggiunto un accordo sulle modifiche costituzionali ed elettorali da far passare in un Parlamento di cui nessuno dei due era membro, in un patto che superava la maggioranza di Letta al suo interno. E il primo ministro? In messaggi twitter come un adolescente che tranquillizza una fidanzata prossima a essere scaricata, Renzi gli ha scritto: ‘Enrico stai sereno, nessuno ti vuol prendere il posto’ [frase riportata in italiano, e poi tradotta in inglese, nel testo – n.d.t.]. Un mese dopo aveva cacciato Letta e si era insediato da più giovane primo ministro italiano.
Come la sua vittima, Renzi proviene da un passato democristiano – suo padre era consigliere DC nella loro città natale fuori Firenze – anche se, per motivi di età, è cresciuto nel movimento degli scout cattolici non, come Letta, nell’organizzazione giovanile della DC. L’azienda gestiva un’azienda di marketing che lo ha impiegato fino al suo ingresso a tempo pieno in politica; tra i suoi clienti c’era il giornale locale La Nazione. Aderendo a uno dei residui della DC dopo che questa si era sciolta, Renzi ha proseguito nel partito centrista “Margherita” che a suo tempo si è fusa con i resti del Comunismo Italiano a formare l’ala destra del PD e all’età di 29 anni è stato scelto per diventare presidente della provincia di Firenze: il genere di posizione che in seguito avrebbe denunciato come uno spreco di soldi e che avrebbe cercato di abolire. All’epoca ne ha ricavato il massimo, costruendo rapidamente un apparato di assistenti e dipendenti e promuovendo sé stesso con una serie di eventi mediatici organizzati da una società creata e controllata da lui come organo di propaganda della provincia, i cui debiti sono cresciuti sotto di lui e i cui conti sarebbero stati contestati dai revisori statali.
Dopo cinque anni ha vinto la candidatura del PD a sindaco di Firenze, uno dei bastioni del centrosinistra in Italia. Tra grandi applausi la sua amministrazione ha pedonalizzato il centro storico e lustrato la sua immagine turistica; i cittadini potevano essere nuovamente orgogliosi della loro città. Scarsi progressi sono stati compiuti, tuttavia, nel ridurre l’inquinamento. Fuori dal centro il traffico è peggiorato, gli autobus sono stati privatizzati contro l’opposizione dei sindacati. Dopo essersi assicurato all’inizio un vasto consenso come miglior sindaco del paese, la reputazione di Renzi è scesa, in parte a causa del fatto che troppi dei successi di cui si vantava si sono dimostrati vuoti. Ma sin dall’inizio egli guardava avanti. Le attività comunali erano concepite non tanto come arena di competizione locale ma come trampolino per la scena nazionale. La priorità era attribuita a spettacoli di grande visibilità, con esibizioni di celebrità di tutto il paese in eventi multimediatici, con una serie di raduni nella stazione ferroviaria convertita della Leopolda, sfoggianti titoli quali ‘Prossima fermata Italia’, ‘Big Bang’ e così via: musica rock e video a piena potenza mentre imprenditori, attori, filosofi, musicisti, scrittori assortiti proponevano citazioni al pubblico con l’esaltante finale dello stesso sindaco. La priorità era sempre all’immagine.
La cosa non ha sempre funzionato bene. Tipiche del modo di agire di Renzi sono state due scommesse di lucrare sugli artisti simbolo della città. Sotto gli affreschi del Vasari a Palazzo Vecchio, aveva assicurato al mondo, c’era ancora la Battaglia di Anghieri di Leonardo e con la tecnologia moderna sarebbe stata recuperata, se si fossero trovati donatori che finanziassero le necessarie ricerche, per trovare i quali – in un’aura di pubblicità a spese del comune – si è recato diverse volte negli Stati Uniti. Dopo mesi di attenzione mediatica non ne è seguito nulla. In un bluff ancor più vacuo ha annunciato piani per coprire la basilica di San Lorenzo con la facciata di marmo progettata per essa da Michelangelo ma che non era mai stata costruita. Anche questo gli è valso chilometri di servizi sulla stampa e sulla televisione, prima di essere messo in ridicolo da storici dell’arte e di sparire dalla vista.
Dal suo periodo a capo della provincia Renzi era andato costruendo una rete di collegamenti con imprese locali. In quel settore il suo sostenitore finanziario chiave era un boss locale delle costruzioni, Marco Carrai, i cui interessi si estendevano oltre Atlantico e i cui collegamenti arrivavano all’Opus Dei. Una volta arrivato Renzi a Palazzo Vecchio, Carrai è stato messo a capo dei lucrativi complesso dei parcheggi e aeroporto, mentre Renzi si insediava senza pagare l’affitto in un appartamento a disposizione di Carrai, un accordo attualmente sotto indagine della magistratura. Correndo per la presidenza del PD tre anni dopo, la sua campagna finanziata al ritmo di 600.000 euro dalla Fondazione Big Bang, molti dei cui donatori sono rimasti segreti, Renzi non ha badato a spese. Uno dei maggiori contributi è arrivato dal manager del maggior fondo speculativo italiano, Davide Serra, la cui Algebris Investments include una nicchia nelle Isole Cayman. Residente a Londra, Serra è divenuto l’uomo di punta di Renzi nel più vasto mondo della finanza, dove un banchetto in onore del candidato ha riunito durante la campagna l’élite bancaria milanese. A Firenze l’Ente comunale Cassa di Risparmio ha investito – indubbiamente per pura coincidenza – in titoli Algebris. La fidanzata di Carrai, nel frattempo, una ventiseienne laureata in filosofia, è stata uno dei curatori della maggiore mostra fiorentina di quest’anno, un’acrobazia pubblicitaria che promuove forzati collegamenti tra Michelangelo e Jackson Pollock per un costo di 375.000 euro. Uno degli slogan più popolari di Renzi è l’appello a un paese dove ‘ottieni un lavoro grazie a quello che conosci, non a chi’.
Il mondo degli affari può godere di scambi di favori a livello municipale, ma su un fronte più vasto è stato il messaggio ideologico di Renzi a guadagnargli i sorrisi dei grandi capitali. Sollecitare la rottamazione dei più anziani di lui nel PD gli ha fatto buon gioco sulla stampa e presso un pubblico deluso dalla classe politica. Per banchieri e industriali il suo appello era più visibilmente economico. I mali dell’Italia derivavano da uno stato scialacquatore e da ostacoli corporativi al mercato, in particolare – se non esclusivamente – da parte di sindacati egoisti. Dovevano essere smantellati. Il liberismo – libero commercio di beni, compresa terra e lavoro – era una dottrina non della destra, bensì della sinistra illuminata. Il suo motto doveva essere innovazione, piuttosto che uguaglianza, per quanto valida come ideale fosse quest’ultima, se correttamente intesa come una carriera aperta ai talenti, soprattutto imprenditoriali. Blair era il leader che aveva compreso tutto questo, creando un esempio ispiratore del genere di politica di cui l’Italia aveva urgente bisogno.
Il culto blairiano di Renzi riflette, in un senso, le limitazioni provinciali della sua cultura: egli è chiaramente inconsapevole del fatto che l’oggetto della sua ammirazione osa a malapena mostrarsi in pubblico nel paese che un tempo ha governato. Ma in un altro senso è servito da biglietto da visita per il più grande amico di Blair in Italia. Contatti informali con il centrodestra esistevano dall’inizio dell’ascesa di Renzi a Firenze, dove la sua vittoria su un candidato più noto alle primarie del PD che non richiedevano l’iscrizione al partito è spesso attribuita a voti provenienti da quella parte politica. Circa da questo periodo era in rapporti con un banchiere fiorentino, Denis Verdini, il cui Credito Cooperativo Fiorentino sarebbe crollato in mezzo a incriminazioni penali a suo carico, ma che da figura di spicco nell’organizzazione di Berlusconi in Toscana sarebbe a tempo debito diventato un interlocutore chiave del centrodestra. Mentre era sindaco, Renzi si è recato alla villa di Berlusconi ad Arcore per un pranzo discreto con lui, un pellegrinaggio tabù nel PD dell’epoca, rivelato solo in seguito. Ad attrarre i due non era soltanto una comune simpatia per Blair e un apprezzamento del valore dell’imprenditore. Berlusconi ha spesso spiegato che considera Renzi una versione più giovane di sé stesso: lo stesso stile, audacia e fascino con cui egli aveva affascinato la nazione vent’anni prima.
Chiaramente, quanto a stile politico i due hanno effettivamente molto in comune. In primis e soprattutto un’inattaccabile sicurezza di sé quanto alla propria capacità unica di guidare il paese. La personalizzazione berlusconiana della politica è leggendaria. La promozione di sé stesso da parte di Renzi è di registro diverso, ma si accorda a essa. Sbattuto sui manifesti lungo il percorso del suo giro per l’Italia, lo slogan della sua campagna per conquistare il comando del suo partito ha tralasciato qualsiasi programma diverso dalla sua stessa persona. Diceva semplicemente: “Matteo Renzi ora!” Come nel caso di Silvio, era sufficiente.
Tale sicurezza di sé eleva entrambi al di sopra di dubbi o scrupoli dei loro pari. Le loro forme di spietatezza tattica differiscono. Ma da politici condividono la qualità di non fermarsi di fronte a nulla, giustificati da due convinzioni: che solo loro sono in grado di realizzare ciò che l’ora richiede e che solo loro godono di un rapporto con gli elettori – non tutti gli italiani, ma i migliori, quelli che formano la maggioranza della nazione – che investe ciò che fanno di una legittimazione irrefutabile. Entrambi anche, naturalmente, sono balzati in primo piano in tempi di crisi, promettendo al paese una nuova partenza quando l’ordine politico era caduto in diffuso discredito.
Tali sono gli evidenti paralleli. Ci sono anche evidenti differenze. Di queste, quattro sono le più significative. Berlusconi è entrato in politica a capo di un impero imprenditoriale, usando la sua vasta fortuna per conquistare un potere che potesse proteggere i suoi interessi. Era prossimo ai sessant’anni allora. Il suo strumento principale nel conquistare e conservare il potere era il controllo della televisione come canale. Le sue abilità nella comunicazione erano quelle di un professionista del piccolo schermo che ne conosceva intimamente rituali e risorse, da venditore e proprietario dei canali su cui appariva in discorsi alla nazione allestiti attentamente.
Renzi, per conto, è una creatura della politica pura. La sua ascesa può essersi lasciata dietro una tenue zaffata di fetore; pecunia non olet può applicarsi marginalmente. Ma i fondi, dubbi o alla luce del sole, sono stati dei meri mezzi per le sue ambizioni: la ricchezza non un fine. L’obiettivo è il potere. Il suo possesso – questa è la seconda principale differenza – è stato conseguito da un individuo sulla quarantina, non sui sessanta: di una generazione più giovane. Berlusconi aveva basato gran parte della sua iniziale attrattiva sull’affermazione non solo di essere un estraneo al sistema politico, ma anche uno che aveva dimostrato le proprie competenze creando ricchezza da imprenditore e da manager: era in grado di gestire l’Italia bene quanto aveva gestito le sue stazioni televisive e la sua squadra di calcio. L’appello di Renzi è all’età, non all’esperienza. Di per sé il giovanilismo è una carta banale giocata dovunque dai politici in ascesa nelle società postmoderne. Ma Renzi ha fatto della sua giovinezza qualcosa di più che un mero attributo individuale: la spada emblematica di un ringiovanimento collettivo a venire, a fendere le disfunzioni geriatriche del sistema politico e i suoi detriti nella vita sociale ed economica in generale. Questo genere di promessa è privo delle credenziali tangibili del successo materiale vantate da Berlusconi ma, in collegamento diretto con le frustrazioni delle due generazioni di italiani soffocate dall’immobilismo e dalla decadenza della Prima Repubblica, è un’attrattiva assolutamente altrettanto potente.
Assieme alla differenza nel messaggio c’è una variazione nel mezzo. Renzi è arrivato la prima volta all’attenzione del pubblico da vincitore di un popolare programma televisivo a premi e non ha mai perso il suo entusiasmo per le apparizioni di ogni genere in televisione, dove il suo piacevole aspetto rubicondo e le sue maniere impertinenti ne hanno fatto un’attrazione naturale, una volta entrato in politica. Ma col tempo il suo vero punto di forza è diventato la rete. Facebook per proiettare la sua immagine e coltivare il sostegno in modi molto più agili di quelli consentiti dagli studi televisivi e sotto un controllo molto più completo (anche se ancora suscettibile di gaffe occasionali, come l’impaziente pubblicazione di una sua foto al capezzale di Mandela in ospedale, una frazione di secondo dopo l’arrivo della notizia della sua morte); Twitter per fornire un flusso continuo dei suoi detti e opinioni sugli affari del momento. Berlusconi, pur appassionato narratore di barzellette da osteria in contesti informali, tendeva all’ampollosità formale nei suoi discorsi politici importanti, tenuti in abiti a doppiopetto in un grandioso studio pieno di libri ad Arcore. Renzi per contro, è ostentatamente informale nell’abbigliamento e nel parlare. Salendo al potere si è rivolto al Senato con le mani in tasca. La cosa non è stata molto gradita. Ma in generale è molto superiore a Berlusconi come comunicatore, molto più rapido nel passo politico, con un fiuto eccezionale per battute fulminanti e pungenti botta e risposta. In confronto a lui i suoi modelli di ruolo, Blair e Obama, sono creature goffe di chi scrive i loro discorsi. Renzi non solo è molto più veloce in campo verbale. Come ha segnalato il suo miglior ritrattista, virtualmente diversamente da qualsiasi altro leader dell’occidente oggi, non ha bisogno di curatori d’immagine. Se la cura agevolmente da solo. Il pericolo per lui sta in un’arroganza troppo esibita, che invita alla satira. Nella sua salita in alto ha saputo come trasformare in sorridente autoironia le parodie che gli sono state riservate. Se ciò continuerà oggi che è al vertice, quando troppe delle sue battute e offese buttate lì rischiano di irritare, resta da vedere.
***
Per il momento sta andando bene. Per vent’anni i discendenti del comunismo italiano hanno cercato invano quello che egli ha ottenuto in un paio di settimane con una stretta di mano a Berlusconi. Per il PD, come per i suoi predecessori, la disgrazia in ogni elezione in Italia era la presenza, rappresentanza consentita dal sistema elettorale, di rivali minori alla sua sinistra oppure – un mal di capo minore – di alleati un po’ a destra. Se solo, anelava il partito, avesse potuto eliminare tali concorrenti con un doppio turno in stile francese, in cui dopo una dimostrazione di proporzionalità al primo turno la vittoria arrivava a maggioranza semplice nel secondo, avrebbe occupato senza ostacoli il posto che gli spettava di diritto di partito di governo del centrosinistra in un sistema politico limitato, e al sicuro, a sé stesso e a un omologo del centrodestra. Ciò era sempre rimasto fuori portata, in parte per la naturale riluttanza a votare per esso in Parlamento dei partiti destinati all’impotenza o all’estinzione in tale sistema. E’ stato anche – più crucialmente – perché Berlusconi, anche se spesso agitava simili rumori, non soltanto non stava meglio del centrosinistra quanto al tenersi dietro una vasta coalizione di forze con meno da guadagnare da una riduzione drastica della loro gamma, ma aveva anche bisogno del sostegno di una forza particolare, la Lega Nord, che aveva un’identità forte e una base organizzata che non poteva essere facilmente inquadrata in una Gleichschaltung [allineamento] del genere immaginato dagli ex comunisti.
Un’equa rappresentanza dell’opinione politica in Italia, una caratteristica della Prima Repubblica, è stata gettata a mare nell’atto fondante della Seconda. Ma i sistemi elettorali ibridi installati dopo non hanno soddisfatto nessuno. Tra questi il Porcellum è stato diffusamente considerato il peggiore. Napolitano, una volta saldamente sulla sua sella ultra-presidenziale, ha esercitato pressioni sul Parlamento per liberarsene. Come per il partito cui un tempo apparteneva, e per le stesse ragioni, non era un segreto che egli riteneva il doppio turno la soluzione ideale. L’esito delle elezioni del 2013, una protesta contro lo stallo istituzionale seguitone, rendeva le sollecitazioni a una riforma elettorale – per anni un’ossessione nei titoli dei media – ancora più forti e urgenti. Tale era la situazione quando nella prima settimana di dicembre dell’anno scorso la Corte Costituzionale alla lunga ha dichiarato incostituzionale il Porcellum per due motivi. Il premio di una maggioranza assoluta assegnato al partito con il numero maggiore di voti, indipendentemente da quanto pochi fossero, era una distorsione della volontà democratica. Le liste bloccate presentate da ciascun partito, che fissavano i candidati in una gerarchia d’importanza in ciascun distretto elettorale, negava agli elettori la scelta dei propri rappresentanti.
La decisione della corte è arrivata come un’improvvisa doccia fredda per il PD. Se le cose fossero rimaste così le elezioni successive avrebbero dovuto essere combattute con un sistema proporzionale, senza alcun premio, e gli elettori sarebbero stati in grado di scegliere i candidati preferiti nella lista, cosa ripugnante per i bonzi di ogni genere, in quanto indeboliva il loro potere sulle truppe. Uno scenario simile era quello che il PD aveva maggiori motivi di temere. Era vitale metterlo al bando. Provvidenzialmente, era arrivato l’uomo per farlo. Cinque giorni dopo la decisione della corte, Renzi ha attaccato il PD. In poche affrettate sessioni a porte chiuse, Renzi e Berlusconi, ciascuno assistito da un collaboratore dotato di competenza tecnica – il politologo Roberto D’Alimonte, da lungo tempo all’Università di Firenze per Renzi; il suo faccendiere fiorentino Verdini, per Berlusconi – hanno concluso un patto per dividersi tra loro la torta elettorale. Insieme avrebbero forzato in Parlamento un sistema progettato per garantir loro la parte del leone della rappresentanza politica nel futuro.
Dopo modifiche minori le disposizioni della legge che dovrà entrare in vigore darebbero un premio del 15 per cento dei seggi alla Camera a qualsiasi partito ottenga il 37 per cento, o più, dei voti nella prima tornata, con un limite superiore del 55 per cento dei seggi; e se nessun partito raggiungesse il 37 per cento, un totale del 52 per cento dei seggi a quello dei due partiti con i maggiori voti al primo turno che arrivasse primo al secondo. In ciascun distretto elettorale, di cui ce ne sarebbero molti di più, ci sarebbero ancora liste bloccate, ma sarebbero più corte – da tre a sei candidati – rendendo più facile agli elettori scegliere. Scopo dello schema era aggirare le obiezioni della Corte al Porcellum, specificando un limite al di sotto del quale il premio non scatterebbe, pur preservando l’essenza del Porcellum, una sfacciata distorsione dell’opinione degli elettori, cui è stato concesso il contentino di un gesto simbolico in direzione di una maggior libertà di scelta tra i candidati. A completare il pacchetto – grandiosamente intitolato Italicum dai suoi architetti e definito Renzusconi dai suoi critici – c’era l’ulteriore assicurazione contro tentazioni di ritorno all’indietro dell’elettorato. Erano previste tre soglie diverse di rappresentanza politica di ogni genere: un partito che corresse da solo doveva superare l’8 per cento per aver diritto a un qualsiasi seggio; un partito interno a una coalizione il 4,5 per cento e qualsiasi coalizione il 12 per cento.
Il patto tra i due leader, tuttavia, prevedeva anche che il Senato sarebbe stato a tempo debito abolito tout court come organismo eletto, aprendo la via a un’assemblea di notabili regionali, in effetti una foglia di fico per un Parlamento monocamerale. Ma mentre un nuovo sistema elettorale può essere approvato a maggioranza semplice in entrambe le Camere, la Camera alta non può essere modificata senza cambiare la Costituzione italiana. Letta aveva tentato un corto circuito delle procedure per farlo, ma aveva fallito. L’articolo 138 della Carta rimane in vigore, integro: prevede che le modifiche della Costituzione richiedono due votazioni successive di ciascuna Camera, con un intervallo non inferiore a tre mesi tra di esse, e nella seconda le modifiche devono ottenere l’approvazione della maggioranza assoluta in ciascuna Camera, e devono essere sottoposte a un referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione, se un quinto dei membri di ogni Camera, o mezzo milione di cittadini, lo richiedono; una disposizione che può essere superata solo da una maggioranza di due terzi dei membri di ciascuna Camera, maggioranza di cui non esiste attualmente la possibilità. Alla legge elettorale potevano essere fatte bruciare le tappe nel giro di giorni. L’abolizione del Senato avrebbe richiesto almeno un anno, con la certezza di un referendum al termine del processo.
***
L’assenza di sincronia tra le due procedure ha consentito ai partiti minori della coalizione di centrodestra al governo, e a una minoranza interna allo stesso PD, di inserire un piccolo cuneo nelle ruote del carrozzone del Renzusconi. Se la legge elettorale fosse passata così come proposta, applicandosi a entrambe le Camere prima che il Senato fosse abolito, non ci sarebbe stato nulla che impedisse a Renzi di convocare elezioni seduta stante, in cui i partiti minori sarebbero stati distrutti e quella parte del PD la cui fedeltà era nei confronti di Bersani o D’Alema, sui cui corpi era volato al potere, sarebbe stata anch’essa spazzata via. Me se fosse stata limitata alla Camera, mentre procedeva la lunga attività di modificare la Costituzione per abolire il Senato, ci sarebbe stato almeno un anno di grazia prima che questi gruppi affrontassero il carro per la ghigliottina, e nell’intervallo poteva saltar fuori qualcosa a salvarli. Anche se in diminuzione nel numero, mentre gli oppositori di un tempo cominciavano a raggrupparsi attorno al nuovo leader, la freddezza di una minoranza interna al PD non poteva essere ignorata. Così da un giorno all’altro il nuovo sistema elettorale è stato limitato alla Camera, precludendo efficacemente il ritorno alle urne sino a quando il Senato non fosse stato cancellato, poiché altrimenti quest’ultimo sarebbe stato eletto con il Porcellum, ora ripulito del premio e delle liste bloccate, non garantendo altro che un esito asimmetrico rispetto a quello della Camera, come nel 2013.
Il calcolo di Renzi nel raggiungere il suo accordo con Berlusconi era duplice. Aveva uno scopo a breve termine. Nell’assicurarsi quel patto fondamentale con il più vasto partito oppositore del governo aveva dimostrato che Letta era a quel punto irrilevante e poteva essere allontanato senza altro clamore. Di importanza molto maggiore e più duratura era il palese vantaggio che l’accordo assegnava al PD, consentendogli di spostarsi più al centro, invadendo l’elettorato di Berlusconi, senza dover temere perdite a sinistra. Il doppio turno era da tempo il suo Santo Graal: il partito a quel punto lo aveva ottenuto.
Con Renzi molto più avanti di lui nei sondaggi, perché Berlusconi ha accettato un accordo dal quale aveva così poco da guadagnare e certamente tanto da perdere? Tre situazioni lo hanno spinto nella trappola. Dalla caduta in disgrazia di Bossi, la Lega Nord – che in passato era sempre stata necessaria per vincere le elezioni e che per motivi ovvii aveva posto il veto a tale accordo – era in eclissi. Berlusconi si è reso conto di non poterlo ignorare. Inoltre egli stesso era a quel punto un reo condannato, escluso dalla carica per due e forse più anni a seguire, che aveva tentato, e fallito, di far cadere il governo a costo di una divisione nel suo partito. Sigillando un patto con Renzi per trasformare il sistema elettorale e costituzionale, avrebbe potuto riposizionarsi al centro della vita politica, non solo indipendentemente dalle sentenze della magistratura contro di lui, ma nella speranza di poter essere appropriatamente ricompensato per il suo servizio disinteressato all’Italia da statista responsabile avendole messe da parte. Alcuni degli elementi del pacchetto, rafforzamento dei poteri del governo a spese del parlamento, erano dopotutto quelli che egli stesso aveva promosso, anche se non era mai riuscito a far molto al riguardo. Poteva sentirsi titolato a una parte dell’ispirazione del patto e a una ricompensa proporzionale da architetto di un ordine nuovo e migliore.
Infine, e criticamente, dalla primavera del 2012 in poi, quando il cerchio dei processi aveva cominciato a chiudersi su di lui, il giudizio politico dei Berlusconi era divenuto sempre più eccentrico. Rimosso dal potere da Napolitano senza mai divenir consapevole di ciò che gli era successo, si è sempre più allontanato da suoi consiglieri più esperti, circondandosi di un paio di soubrette semianalfabete del sud, una delle quali sua attuale compagna, che hanno cominciato a comandare nel partito, più il suo cagnolino e un indefinito giornalista televisivo. Nel suo bunker di sottane erano alimentate illusioni che sarebbe stato facile appropriarsi del Nord liberato dalla Lega e farla più o meno franca riguardo alle sentenze a suo carico. Persino Verdini, rischiando l’esilio da Arcore, ha manifestato sgomento. In tali condizioni Renzi, vedendo quanto debole era diventato Berlusconi, poteva sostanzialmente imporre le linee di un accordo favorevole al PD.
La manipolazione dei sistemi elettorali per influenzare i risultati non è una rarità nelle democrazie liberali: è semmai la regola, piuttosto che l’eccezione. In Gran Bretagna e negli Stati Uniti il sistema uninominale maggioritario risale alle organizzazioni premoderne di una società gerarchica di piccola nobiltà, a malapena emergente dalle sue origini feudali, in cui pochi seggi erano addirittura oggetto di contesa. Agli inizi del diciassettesimo secolo solo il 5 o 6 per cento dei distretti elettorali aveva più di un candidato; persino nel ‘Parlamento Lungo’ non più del 15%. La sua conservazione in tempi moderni la dice lunga sulla natura della democrazia anglosassone. La Quinta Repubblica in Francia e la monarchia restaurata in Spagna offrono altri esempi famigliari di sistemi elettorali manipolati per tener fuori l’indesiderata concorrenza della sinistra. In Italia il sistema oligarchico seguito al Risorgimento – nel 1909 l’elettorato era costituito da tre milioni su una popolazione di 33 milioni – mutuò un sistema uninominale maggioritario modificato dalla Gran Bretagna. Dopo la prima guerra mondiale il suffragio universale maschile e la rappresentanza proporzionale arrivarono insieme, come complementi logici della democratizzazione. Il fascismo, non meno logicamente, svuotò quest’ultima con la legge Acerbo. Quando la democrazia fu ripristinata dopo la seconda guerra mondiale, la Costituzione italiana emersa dalla Resistenza fu progettata per impedire qualsiasi ritorno a un governo autoritario. Nella Prima Repubblica una presidenza onorifica di ambito strettamente limitato, due Camere legislative di ugual peso che si equilibravano reciprocamente, nessun diritto del premier di licenziare ministri, voto segreto sulle proposte di legge parlamentari, referendum popolari su istanza dei cittadini – e rappresentanza proporzionale – andarono insieme.
Con la Seconda Repubblica questa configurazione cominciò a essere distorta a due livelli. In basso la rappresentanza proporzionale fu prima ridotta a un residuo del sistema elettorale, poi negata del tutto con l’introduzione di un premio sulla falsariga della legge Acerbo. In alto la presidenza divenne alla fine la carica più potente del paese, facendo e disfando governi. Il patto tra Renzi e Berlusconi introdurrà una Terza Repubblica, concentrando il potere nel governo e riducendo ancor più drasticamente la scelta degli elettori. Secondo ogni metro il nuovo sistema elettorale, approvato in prima lettura, è un mostro. Non contento di un premio che assegna al vincitore quasi la metà dei seggi rispetto a quelli ottenuti con il voto, si spinge anche oltre il regime mussoliniano negli ostacoli che oppone a qualsiasi partito o coalizione minore nell’assicurarsi dei seggi. Nelle parole dell’avvocato Aldo Bozzi – da cittadino privato – la cui causa alla fine ha ottenuto un verdetto della Corte Costituzionale contro il Porcellum, il Renzusconi è un Super-Porcellum. Persino D’Alimonte, uno dei suoi architetti, ha espresso pubblicamente dubbi sulla costituzionalità delle sue soglie.
Questo significa che, come quello che l’ha preceduto, sarà cassato? Una tale ipotesi sarebbe ingenua. In Europa le corti costituzionali sono raramente sorde alle necessità del governo in carica – la duttilità della Bundesverfassungsgericht in Germania è abbastanza tipica – e quella italiana meno di tutte le altre. Dieci dei suoi quindici giudici sono di diretta nomina politica, metà scelti dal Parlamento e metà dal presidente. Per avere un’idea dell’effetto, è sufficiente notare che la scelta più recente di Napolitano è stata il consigliere di Craxi, Amato, mentre il suo attuale vicepresidente, Mazzella – scelto dal Parlamento sotto Berlusconi – è stato ospite di Alfano, Berlusconi e Letta anziano a una cena privata pochi mesi prima che la corte dovesse pronunciarsi sul lodo Alfano. Dopo aver cassato le liste bloccate del Porcellum a dicembre, quando la Corte ha pubblicato a gennaio le motivazioni della sentenza ne ha lasciata aperta – ‘dopo consultazioni informali’ – l’ammissibilità, dopotutto, in circoscrizioni più ristrette. Tre giorni dopo, avendo in anticipo inquadrato la Corte, Renzi e Berlusconi hanno annunciato il loro pacchetto con questa sola modifica del Porcellum.
Comportamenti di questo tipo della magistratura sono lungi dall’essere specifici dell’Italia. In Gran Bretagna basta che pensiamo ai giudici Denning, Widgery o Hutton. Unico, tuttavia, è lo spettacolo di un Parlamento composto da deputati i cui seggi sono dovuti a una legge giudicata una violazione incostituzionale dei diritti dei cittadini, non solo continuare a riunirsi e a legiferare imperturbabilmente , ma addirittura riscrivere la Costituzione. Negli annali del diritto pubblico non si è mai visto prima nulla di paragonabile. Ma in Italia la Corte Costituzionale è imperturbabile. Spiegando che ‘la continuità dello stato’ sarebbe in pericolo se l’illegalità del Porcellum dovesse mettere in discussione il parlamento eletto in base ad essa, la Corte ha già legittimato il Parlamento a modificare la Costituzione. Secondo questa logica da Alice nel paese delle meraviglie, se domani un governo manipolasse interamente le elezioni, o proclamasse uno stato d’emergenza sospendendo le libertà civili, commetterebbe un abuso ma dovrebbe continuare il suo corso, perché altrimenti sarebbe a rischio la continuità dell’esistenza della repubblica; la dottrina dei due corpi del re aggiornata per i postmoderni.
Durante la rivoluzione del 1848, all’alba dei principi del proporzionalismo democratico – il primo piano per una rappresentanza politica equa era stato proposto da un seguace di Fourier due mesi prima – Lamartine osservò: ‘le leggi elettorali sono le dinastie della sovranità nazionale’. Non avrebbe saputo quanto appropriata e profetica si sarebbe dimostrata l’analogia. La dinastia oggi da imporre al popolo italiano è retrograda persino tra le sue pari: borbonica di varietà napoletana, si potrebbe dire [gioco di parole su Bourbon (borbonico, ma anche whisky) e Neapolitan (napoletano, ma anche ‘di Napolitano’ – n.d.t.]. Ma il suo creatore può esultare legittimamente. Con essa lo slancio di cui attualmente gode Renzi potrebbe essere mantenuto per parecchio.
Da un giorno all’altro il suo partito è divenuto una falange in larga misura sottomessa al suo seguito. Troppo compiaciuto di sé stesso e sprezzante degli altri estranei alla sua cricca fiorentina per essere molto amato a stretto contatto, nonostante ciò Renzi promette di consegnare al PD un potere di cui non ha mai goduto. Il partito alla fine ha trovato un vincitore, e per il momento le fronde saranno poche. I membri del suo gabinetto sono pesi leggeri incapaci di contrastarlo, la cui funzione è di proiettare giovinezza e parità di genere e di mettere al sicuro la sua preminenza. La stampa dominante è solidale a tutto campo, quando non addirittura lirica. Ma se il suo entusiasmo ricorda l’euforia dei media britannici per il primo Blair, il contesto è cambiato. Il neoliberismo era sulla cresta dell’onda. Oggi la sua marea prosegue, ma i suoi cavalloni bianchi si stanno assottigliando; l’esuberanza è svanita. Cameron e Clegg possono avere più pubblicità della Thatcher, ma non c’è ottimismo nei confronti del loro programma. Sotto Hollande o Rajoy, Kenny o Passos Coelho, per non parlare di Samaras, procedono i tagli alla spesa e la liberalizzazione del mercato del lavoro, ma in uno spirito di necessità arcigna, non di entusiasta emancipazione.
Lo stile di Renzi non permette questo. Il suo messaggio di speranza ed eccitazione richiede misure che siano qualcosa di meglio del tirare la cinghia. Salito al potere mediante un colpo di stato interno al partito, privo di mandato popolare, ha necessità di una convalida alle urne e le elezioni europee incombono. In passato le varianti di centrosinistra del neoliberismo erano tipicamente compensative, offrendo pagamenti risarcitori a elettorati strategici per assopirne l’impatto sociale. Con la crisi i margini per tali concessioni si sono ridotti. Per Renzi è cruciale che si amplino nuovamente. I risarcimenti collaterali devono arrivare in anticipo, senza ritardo, prima che gli elettori si disilludano. Perciò il suo pacchetto di apertura di misure sociali combina leggi che rendono tanto facile per i nuovi lavoratori essere licenziati che persino l’Economist ha aggrottato le sopracciglia, con un’elemosina di 1.000 euro di tagli fiscali ai pagati di meno, sfrontatamente presentata come un compenso per i voti.
Per pagare per queste e altre spese per indurre la crescita, Renzi ha chiarito che il corsetto del patto fiscale andava allentato. All’Italia, ha informato Bruxelles, non devono più essere impartite prediche come a uno scolaretto davanti alla lavagna. Poiché i calcoli della Commissione Europea, come quelli della Banca Centrale Europea e, non ultimi, quelli del regime di Berlino – le tre autorità che contano – sono alla fine sempre più politici che tecnici, è probabile che ce la farà. Il fervore di Renzi per le riforme strutturali può essere creduto, mentre non poteva esserlo quello di Berlusconi, perciò non ha senso rendergli la vita difficile essendo troppo pignoli sul tetto ammissibile dei deficit. Le regole nella UE, nel caso si dimostrino inadatte, esistono per essere ragionevolmente forzate, non seguite meccanicamente. Gran parte della stessa cosa si applica a Manuel Valls in Francia, salutato non meno entusiasticamente dalla stampa finanziaria, con il Financial Times ha immediatamente intitolato un editoriale: “Alla prova i nuovi ragazzi d’Europa – Bruxelles dovrebbe prendere in considerazione bilanci meno rigidi per Valls e Renzi”. Resta da vedere quanto simili aggiustamenti potranno offrire ossigeno all’economia italiana nel lungo termine. Quello che conta nel breve termine è l’ossigeno elettorale per il nuovo governante. Per il momento Renzi ha ogni ragione per essere fiducioso.
***
E riguardo all’autunno del patriarca? In una farsa tipica della giustizia italiana la sua condanna per un’evasione fiscale multimilionaria è finita con l’accusa che ha rinunciato a ogni pretesa di suoi arresti domiciliari e con la corte – mossa dal suo cambiamento di orientamento – che gli ha assegnato un oneroso servizio alla comunità di quattro ore in una residenza per anziani vicina al suo palazzo di Arcore: proprio l’esito necessario per tenere in sella il Renzusconi, che egli aveva minacciato di far naufragare se gli fosse stata imposta una punizione peggiore: ma chi potrebbe sospettare i governanti del paese di avere rapporti con i funzionari della legge? Tuttavia, pur avendo sin qui mantenuto la sua libertà personale, Berlusconi rischia pene molto più severe una volta che la sentenza a suo carico dello scorso giugno a sette anni di carcere per induzione alla prostituzione minorile divenga definitiva in una corte di secondo grado ed è probabile che la sua vita politica si approssimi alla fine. Il suo partito, Forza Italia, già semisommerso ai sondaggi, affonderà ancor di più o si capovolgerà nel caso egli non sia più in grado di gestirlo quotidianamente. Poiché il suo unico patrimonio è il suo nome, ci saranno pressioni dai suoi ranghi perché a portabandiera sia nominato uno dei suoi figli. Un figlio scioperato è impresentabile. Tra le sue figlie egli è più vicino alla maggiore del suo primo matrimonio, Marina, che dirige la parte Fininvest e Mondadori del suo impero. Ma lei è piuttosto schiva e non mostra segni di voler raccogliere lo scettro. Barbara, la sua figlia mediana che ha 29 anni, aiuta a gestire la squadra di calcio di Berlusconi, il Milan AC. E’ attraente, estroversa e ritenuta molto più tagliente. Sua madre, Veronica Lario, oggi profondamente isolata da suo padre, si è presa cura di allevarla protetta quanto più possibile da lui, perciò le relazioni tra loro sono più distanti. Meno popolare della sua sorellastra, ha più passione per la politica. A tempo debito un ticket Barbara Berlusconi non è inconcepibile.
Gli eredi biologici, comunque, saranno la parte meno importante dell’eredità di Berlusconi. Per i vent’anni della Seconda Repubblica l’Italia ha segnato il passo, in qualcosa di simile a un equivalente peninsulare del ‘periodo di stagnazione’ nell’URSS. La corruzione è stata scarsamente ridotta e il paese è entrato in un declino sociale ed economico. I governi di Berlusconi sono stati peggiori di quelli dei suoi avversari, ma non di un grande margine, visto che né gli uni né gli altri hanno lasciato una grande impronta legislativa. Il cambiamento maggiore del periodo si è avuto con l’ingresso dell’Italia nell’unione monetaria sotto Prodi, ma è stato ambiguo, riducendo i costi dell’indebitamento del paese, ma minandone le esportazioni. A parte questo il libro mastro è in larga misura bianco, e poiché Berlusconi ha governato un po’ più a lungo del centrosinistra, la sua responsabilità è in qualche modo maggiore.
Ma sarebbe un errore concludere che egli non ha ottenuto nulla, alla fine nemmeno l’immunità per cui era entrato in politica. Il grande risultato di Berlusconi è consistito nell’aver trasformato i suoi avversari in sue immagini. L’Italia ha una lunga tradizione di studi politici di elevata qualità. L’anno scorso una delle sue menti migliori, Mauro Calise, ha pubblicato un libro intitolato ‘Fuorigioco’. In esso ha sostenuto che la personalizzazione della politica non è stata soltanto uno spettro antidemocratico che richiama le tentazioni di un passato screditato, come ha temuto a lungo la sinistra italiana, ma anche la forma egemone di governo in ogni democrazia atlantica ad eccezione dell’Italia. Weber pensava che la leadership patrimoniale o carismatica fosse storicamente in declino in occidente. Ma in realtà è stata l’autorità legale-razionale, che egli credeva caratteristica delle forme moderne di governo, a essere obsoleta. Poiché oggi la macro-personalizzazione del potere è pubblica, chiamata a rispondere e criticabile. Risponde a un mondo in cui la comunicazione non è più uno strumento della politica, bensì la sua essenza, di cui non c’è motivo di avere timore. Poiché la video-politica si autolimita, producendo leader che sono al tempo stesso molto potenti e molto fragili, vulnerabili ai sondaggi d’opinione e alle urne. Ciò che una politica simile eleva, può velocemente abbattere. La verità è che la macro-personalizzazione non è in antitesi con la democrazia, bensì ne è la condizione, in un’epoca in cui i partiti hanno perso la loro forza. La sinistra italiana si è rifiutata di afferrare questo, associando erroneamente la norma liberale del ‘presidenzialismo monocratico’ ai ricordi del fascismo, e poi stigmatizzandola come berlusconismo. Ritirandosi in forme collettive introverse di dirigenza, mancando di un qualsiasi carisma, ha consegnato il campo della competizione relativa a Berlusconi, un maestro di ciò.
Calise ha pubblicato il suo libro un paio di mesi prima che Renzi s’impossessasse del PD, e il libro può essere letto come note programmatiche di esemplare lucidità a proposito di ciò che sarebbe seguito, una volta che il centrosinistra ha trovato un leader capace di sconfiggere Berlusconi sul suo stesso terreno. Ciò che è lasciato tra parentesi, naturalmente, nella sua diagnosi ottimista delle forme necessarie della vita democratica oggi è ogni riferimento alla sua sostanza. La macro-personalizzazione non è ideologicamente neutra. Per adottare la terminologia di Calise, essa risponde a un mondo in cui le personalità sono divenute grottescamente amplificate – Super Mario e il resto – mentre le differenze di parte, e con esse le scelte dell’elettore, si avvizziscono di pari passo. Il duraturo successo di Berlusconi, di cui egli è consapevole, consiste nell’aver riprodotto in Renzi non semplicemente uno stile di leadership, ma anche un genere di politica paragonabile alla sua, in gran parte ciò che la Thatcher fece con Blair. E’ grazie a lui, ha affermato ripetutamene, che Renzi ha trasformato completamente il PD, seppellendo una volta per tutte qualsiasi vestigio del passato socialista-comunista. E’ una rivendicazione legittima.
Ma l’Italia, che dopo la guerra ha conosciuto più ribellioni politiche, di un genere o dell’altro, contro l’ordine costituito di qualsiasi altra società europea, non si è ancora liberata del tutto di esse. Mentre Berlusconi e Renzi capitalizzano l’uno sull’altro, la loro forma più recente permane attiva. Il M5S non si sottrae certo all’eziologia di Calise, anche se non si tratta di video-politica. Grillo incarna il Movimento Cinque Stelle da suo fondatore e leader esagerato. Autocrate che non tollera dissenso, opera anch’egli fuori dal Parlamento, tenendo sotto stretta osservazione i suoi seguaci all’interno di esso e procedendo all’espulsione sommaria di quelli che rompono i ranghi, mentre il numero di quelli che votano le delibere in rete del movimento resta esiguo, non più di trentamila, o giù di lì. La rozzezza di molti interventi di Grillo ripugna tanto quanto attira; analogamente l’indeterminatezza ideologica di gran parte del suo appello, consentendo intonazioni sia di destra sia di sinistra. Il suo rifiuto generale – è un no quasi invariabile – di fare accordi con altri partiti è stato anch’esso controproducente. Se fosse stato disponibile, dopo il successo del M5S alle elezioni dell’anno scorso, a prestare sostegno esterno a Bersani in cambio di un accordo sulle riforme politiche, oggi al Quirinale non ci sarebbe Napolitano, Renzi starebbe ad agitarsi a Palazzo Vecchio e l’Italia avrebbe evitato un Neo-Porcellum.
Se vuol essere efficace, la protesta richiede manovre dell’intelligenza e intransigenza della volontà. Forse Grillo, imparando dall’esperienza, si dimostrerà più esperto e meno autoritario in futuro, e il movimento che ha creato più di un passeggero vortice di turbolenza. Gli italiani devono sperarlo, poiché con la scomparsa di qualsiasi sinistra significativa, della quale non esistono sostituti, il M5S potrebbe ben emergere come l’unica opposizione rilevante nel paese, e nonostante tutti i suoi difetti e paradossi, continua a rappresentare l’unico abbozzo dovunque in Europa di una forza antagonista a ciò che si è impossessato della democrazia rappresentativa. Fortunatamente, in mezzo a un deserto di conformismo mediatico – con cinica benevolenza, un senatore del centrosinistra ha una volta descritto privatamente La Repubblica, il principale quotidiano della nazione come ‘la nostra Pravda’ – l’Italia possiede un giornale, Il Fatto Quotidiano, fondato quattro anni fa da un gruppo di giornalisti indipendenti, che non teme nessuno e infrange ogni tabù: un caso unico nel suo genere da un versante all’altro del continente. In generale amichevole nei confronti del M5S, Il Fatto è anche spesso critico in modo tagliente di esso: esattamente quello che serve.
I discorsi sul ‘miracolo italiano’, di moda all’epoca di Fellini e della Vespa, si sono da tempo trasformati nell’opposto. Per decenni gli italiani hanno superato gli stranieri nel lamentare il Disastro Italiano con, al meglio, pochi spiriti coraggiosi a mantenere qualche nicchia redentrice di eccellenza qui e là: la moda, la Ferrari, la Banca Centrale. Non c’è dubbio che il paese occupa oggi un posto speciale nel concerto degli stati europei. Ma è solitamente frainteso. L’Italia non è un membro ordinario dell’Unione. Ma non è neppure deviante da qualsiasi standard cui potrebbe essere riferito. C’è un’espressione consacrata per descrivere la sua posizione, molto usata dentro e fuori dal paese, ma è sbagliata. L’Italia non è un’anomalia in Europa. E’ molto più prossima a esserne un concentrato.
www.znetitaly.org
Fonte: http://zcomm.org/znetarticle/the-italian-disaster/
Originale: London Review of Books
traduzione di Giuseppe Volpe
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa