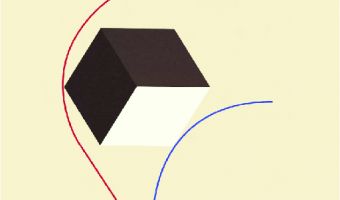Il conflitto sindacale o politico è una droga potentissima: fa concentrare l’attenzione dei protagonisti sull’assoluto presente. Si sta attenti a cosa si può vincere o perdere in questa battaglia concreta. È necessario, se si vuole “stare sul pezzo”, attaccare e difendersi in tempo reale. E si perde inevitabilmente di vista il lungo periodo, i cambiamenti strutturali che intervengono, specie se investono sfere al di fuori del nostro controllo immediato. Occorre sempre uno sforzo soggettivo incredibile per “fare il punto” ad ogni stazione rilevante di questo cammino, per accumulare l’esperienza collettiva, fissarla in organizzazione stabile, ma reattiva agli inevitabili cambiamenti. È esattamente il contrario di quel che predicavano, decenni orsono, certi sciagurati che facevano “l’elogio dell’assenza di memoria”, inventandosi il bizzarro principio per cui, se non si sa nulla delle sconfitte passate, si procede più risolutamente sulla via del conflitto. Ricominciando ogni volta da sciame, folla, plebe, racaille, “massa” consapevole soltanto dei propri bisogni e del proprio numero. Senza progetto, storia, futuro. Ovvero quel che più desidera qualsiasi potere, diciamolo: un avversario incompetente.
“Come siamo arrivati a questo incrocio?” è invece la domanda che ogni viaggiatore è costretto a porsi se vuole procedere oltre, verificando se davanti ci sono strade già tracciate o sentieri incerti. Per scegliere ogni volta – soppesando certezza e scommessa – il cammino da qui in poi.
Per questo motivo libri come quello di Giorgio Cremaschi sono indispensabili. Necessari. Magari non saranno precisi come un saggio scientifico (né, giustamente, pretendono di esserlo), certo saranno discutibili in questo o quel giudizio, su questo o quel passaggio storico. La loro necessità non dipende dal quantitativo di “verità” che ogni affermazione possiede, ma dalla verità intrinseca di un percorso ultraquarantennale all’interno del più grande sindacato d’Europa, vissuti “al fronte”, nella trincea da cui i metalmeccanici hanno spesso guidato offensive travolgenti e in cui sono stati più volte ricacciati. Fino al baratro odierno, per tutto il movimento operaio.
Si può arrivare alla fine di questa cavalcata in una posizione minoritaria di fatto pur senza nutrire alcuna passione per il minoritarismo, per il restare “pochi ma buoni”. Si sfugge a questa trappola ponendosi sempre i problemi dal punto di vista generale, tenendo conto della “grandi masse” dei lavoratori – quelli veri, capaci di rabbia e paura, di solidarietà eroiche e di rese vergognose, animati da slanci rivoluzionari e inchiodati a mutui da pagare – e non solo della “linea giusta” sul piano astratto.
 Lavoratori come farfalle. La resa del più grande sindacato d’Europa (Jaca Book) ha questo respiro; non si accontenta di ribadire un punto di vista storicamente eccentrico rispetto al compassato corpaccione del funzionariato Cgil, ma ricostruisce il come e il perché di tanti conflitti, scontri, attacchi, rese; viviseziona un lento ma colossale cedimento culturale che ha accompagnato (a volte seguendo, a volte precedendo) le sconfitte degli ultimi 35 anni. A partire naturalmente da quell’autentico big bang negativo che fu l’esito dei “35 giorni di occupazione alla Fiat”, preceduto non per caso dalla “svolta dell’Eur”, nel ’77, e dall’adozione di una linea strategica “compatibilista”, di accettazione dei “sacrifici per salvare il paese”. Per arrivare infine al presente “cambio d’epoca”, segnato dal trasferimento delle decisioni politiche centrali dentro un reticolo di istituzioni sovranazionali, politicamente irresponsabili e programmaticamente sottratte alla verifica democratica.
Lavoratori come farfalle. La resa del più grande sindacato d’Europa (Jaca Book) ha questo respiro; non si accontenta di ribadire un punto di vista storicamente eccentrico rispetto al compassato corpaccione del funzionariato Cgil, ma ricostruisce il come e il perché di tanti conflitti, scontri, attacchi, rese; viviseziona un lento ma colossale cedimento culturale che ha accompagnato (a volte seguendo, a volte precedendo) le sconfitte degli ultimi 35 anni. A partire naturalmente da quell’autentico big bang negativo che fu l’esito dei “35 giorni di occupazione alla Fiat”, preceduto non per caso dalla “svolta dell’Eur”, nel ’77, e dall’adozione di una linea strategica “compatibilista”, di accettazione dei “sacrifici per salvare il paese”. Per arrivare infine al presente “cambio d’epoca”, segnato dal trasferimento delle decisioni politiche centrali dentro un reticolo di istituzioni sovranazionali, politicamente irresponsabili e programmaticamente sottratte alla verifica democratica.
Il titolo parla del futuro, non del passato. Quando i lavoratori saranno farfalle solo alla fine di un lunghissimo percorso analogo a quello che – dallo stato di larva – porta a spiegare le ali solo alla fine della vita. E poi si muore. È la sintesi metaforica del “contratto a tutele crescenti”, la vecchia idea di Ichino che questo governo ha fatto sua: da apprendista a precario, lungo una scala infinita di ricatti e licenziamenti, in cui la meta della “certezza della non licenziabilità” (sempre che l’azienda resti in piedi tutto quel tempo…) verrà toccata un attimo prima della pensione. Di breve durata, naturalmente, perché “agganciata alle aspettative di vita”.
Lo sguardo di Cremaschi è decisamente empatico con la condizione del lavoratore dipendente, con l’”operaio”; ma è questa volta uno sguardo dall’alto, per individuare appunto la strada oltre il baratro presente, e i contorni della soggettività che dovrà essere in grado di prendere il posto di quelle tramontate senza neanche un gesto di dignitosa ribellione finale. Inizia con la “scoperta” che la condizione di oggi è quasi esattamente la stessa che aveva trovato da giovanissimo, quando i volantini chiedavano di “l’abolizione dell’apprendistato e dei contratti a termine, perché, si scriveva, servivano solo a pagare di meno e a sfruttare di più”. Un apprendistato, per la precisione, che “durava due settimane per un operaio, poco più di un mese per un impiegato”, ossia il periodo che in effetti serve per apprendere le funzioni base della mansione per cui verrai pagato. Altro che i tre anni (rinnovabili) dell’anticipo di Jobs Act approvato in giugno!
Stessa condizione, oggi, ma senza più tutte le altre. Ovvero un’economia in espansione, un mondo diviso in due (con una “alternativa di sistema”, anche se discutibilissima), un sindacato generale, un Partito capace di scontrarsi, contare i morti in piazza e gli arrestati, un mondo da conquistare, sia in versione sol dell’avvenire che – riformisticamente – come “accesso alla società del benessere”. Non c’è un futuro roseo, davanti agli occhi delle generazioni che hanno 20 o 30 anni. E nemmeno una nutrita schiera di difensori dei più deboli. E neanche più una cultura condivisa, di massa, sul diritto ad avere una “vita dignitosa”.
Il pregio del lavoro di Giorgio, lo ripetiamo, sta nel non darsi ragione a prescindere, come avviene a tanti protagonisti della storia, quelli che “se mi avessero dato retta in quell’occasione…”. La storia va come va, ci sono ragioni infinitamente più potenti dei singoli ìndividui a spingerla in un senso o nell’altro. E anche le organizzazioni che dovrebbero “esercitare la soggettività alternativa” sono al dunque condizionate – favorite o ostacolate, supportate o bombardate – dai rapporti di forza sociali, dallo sviluppo storico, dalla collocazione geopolitica, ecc.
La situazione attuale, per quanto attiene sia alla cultura che all’organizzazione concreta “della classe”, è un autentico “buco nero”, che solo l’ottimismo della volontà riesce a rappresentare come “una prateria da occupare”. Ma conoscere la Storia serve a sapere che è la durezza della condizione oggettiva che costringe il pensiero a diventare “forte”, altettanto duro e impietoso, anche con se stessi. Non ci sono soluzioni indolori, bacchette magiche, “pensate creative” che ci possano permettere di ribaltare in due mosse lo squilibrio delle forze in campo.
Siamo di fronte a un potere padronale organizzato su scala quantomeno continentale, in cui le decisioni fondamentali di politica economica sono sottratte a ogni verifica democratica. Sul piano della rappresentanza si è di fatto privi di strumenti all’altezza della sfida. Sul piano sindacale, la rappresentanza stessa è blindata dall’accordo del gennaio di quest’anno, una sorta di “patto di palazzo Vidoni” che vieta – nei fatti, se non nella norma – l’esistenza di una soggettività non “compatibilizzata” con le esigenze del sistema. Cosa si fa, in questa situazione? Il “conflitto a km zero”? Si moltiplica il pulviscolo sperando che prima o poi si addensi in una massa critica di qualche rilevanza?
Oppure si prende atto che “lo scambio vincente” offerto dal capitalismo negli ultimi trenta anni – “niente più garanzie socialiste (diritti, keynesismo, costituzione, ecc), ma crescita economica infinita che produce benessere per tutti” – è a fine corsa, fallito disastrosamente? Che, quindi, il conflitto deve darsi nuovamente una prospettiva di cambiamento generale?
La risposta implica un salto di qualità, una rottura con la cultura sindacale e politica dominante dall’89 in poi (ma nata molto prima, spiega bene Giorgio). Anche perché “il nemico” non si accontenta di aver vinto, ma vuole stravincere: “Le persone devono essere educate alla paura e all’arte di arrangiarsi individualmente, cancellando anche nell’immaginario la possibilità dell’azione collettiva e del conflitto. I sindacati devono invece accettare la resa incondizionata, ridursi a entità corporative e complici nelle imprese, a burocrazie di servizio nella società”.
In questo eccesso – implicito nella natura stessa del capitale, che non conosce né ammette limiti al proprio avanzare – sta anche la possibilità di rimettere il conflitto sociale con i piedi per terra. Sapendo da dove si viene, di come si dà battaglia, si vince e si perde, facendo scienza dell’esperienza accumulata nel tempo. Ricordando per fare meglio, senza nostalgie.
* dal blog Tempo Reale
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa