Nel 1845 nell’Introduzione a La situazione della classe operaia in Inghilterra Engels scrisse che: «la storia della classe operaia in Inghilterra ha inizio nella seconda metà dello scorso secolo, con l’invenzione della macchina a vapore e delle macchine per la lavorazione del cotone [e] mentre con la prima macchina [la cosiddetta Jenny] si sviluppava il proletariato industriale, la stessa macchina dava anche origine al proletariato agricolo […]. Il proletariato [in altre parole è] stato creato dall’introduzione delle macchine [nel ciclo produttivo]» (MEW 2, 237, 240, 250/31, 34-35, 44).
Ma da quando lo sviluppo della tecnologia ha iniziato a significare qualcosa di primaria importanza per gli uomini? In che modo essa è divenuta funzionale allo sviluppo della produzione? E soprattutto per il tramite di chi la tecnologia moderna è divenuta il pensiero politico fondamentale con cui la classe borghese in formazione riuscì a rovesciare il vecchio mondo per riscriverne un altro?
Secondo Marx ed Engels le risposte a tali quesiti arriveranno solo quando riusciremo nel difficile compito di elaborare una Storia critica della tecnologia: ma da dove essa sarebbe dovuta ripartire a riflettere lo sviluppo della tecnologia stessa non è dato ancora saperlo; forse dalla prima rivoluzione industriale?
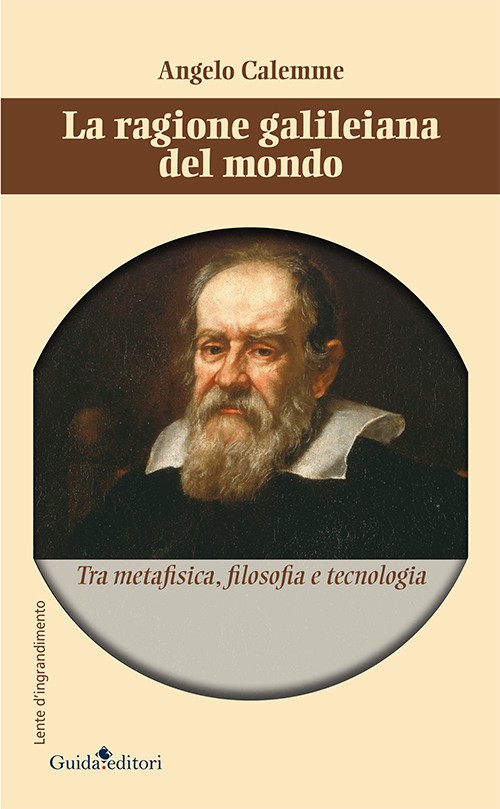 A seguire Marx e Engels sembrerebbe di sì. Tuttavia, sulla base di ricerche ulteriori, La ragione galileiana del mondo. Tra metafisica, filosofia e tecnologia (Guida Editori, pp. 283, euro 18), di Angelo Calemme, pare non essere d’accordo. Secondo quest’ultimo infatti prima di cominciare a parlare di una storia critica della tecnologia, sarebbe più opportuno individuare quando lo sviluppo di una logica degli oggetti tecnici divenne una preoccupazione di primaria importanza per gli uomini. Attraverso una sorta di genealogia della prima modernità, quella classica, con Calemme scopriamo come converrebbe incominciare a retrodatare l’origine di una storia critica della tecnologia di almeno un secolo e mezzo prima della prima rivoluzione industriale e cioè fino al 1610, anno in cui Galileo Galilei, con i sui strumenti di lavoro, «svincolò il pensiero della natura dalla volontà divina e innalzò l’oggetto tecnico a organo di conoscenza».
A seguire Marx e Engels sembrerebbe di sì. Tuttavia, sulla base di ricerche ulteriori, La ragione galileiana del mondo. Tra metafisica, filosofia e tecnologia (Guida Editori, pp. 283, euro 18), di Angelo Calemme, pare non essere d’accordo. Secondo quest’ultimo infatti prima di cominciare a parlare di una storia critica della tecnologia, sarebbe più opportuno individuare quando lo sviluppo di una logica degli oggetti tecnici divenne una preoccupazione di primaria importanza per gli uomini. Attraverso una sorta di genealogia della prima modernità, quella classica, con Calemme scopriamo come converrebbe incominciare a retrodatare l’origine di una storia critica della tecnologia di almeno un secolo e mezzo prima della prima rivoluzione industriale e cioè fino al 1610, anno in cui Galileo Galilei, con i sui strumenti di lavoro, «svincolò il pensiero della natura dalla volontà divina e innalzò l’oggetto tecnico a organo di conoscenza».
In altre parole quando Galilei, con un atto puramente politico, fece del mito scientifico dell’autonomia degli oggetti tecnici (e dell’indipendenza che la filosofia con questi ultimi raggiunse nell’ordine di una Nuova scienza) il nuovo fondamento ontologico su cui scrivere una nuova gerarchia della società, quella della prima modernità. Ciò è stato dimostrato da Calemme in un denso ma chiaro volume, che ad un certo punto non solo rilegge gli scritti del Pisano e dei suoi detrattori, ma addirittura riesce a restituirli al lettore in forma quasi filmica in quei rivoluzionari effetti politici di verità che distrussero l’autorità di Aristotele e della Chiesa per crearne una di nuovo genere.
Come scrive lo stesso Calemme, la sua ricerca è riuscita, attraverso una prospettiva completamente diversa da quelle tradizionali, a dimostrare che Galilei con la sua filosofia tecnologica è divenuto l’irrinunciabile «padre simbolico delle scienze esatte o naturali […]; che egli fu prima di tutto un filosofo e solo poi uno scienziato, precisamente un filosofo politico e solo poi un fisico moderno; che la galileiana elaborazione ontologica del metafisico concetto di una natura indipendente e di un pensiero automatico e oggettivo delle cose (la tecnologia nell’accezione moderna del termine) ha, in maniera determinante, rivoluzionato la cultura […] del XVI e XVII secolo, agglutinando e organizzando, sulle macerie di essa, un nuovo orizzonte di senso; che la complessiva rivoluzione galileiana dei saperi ebbe la sua origine e trasse il suo primo cruciale sviluppo nella diffusione, parallelamente accademica e cittadina, di una opinione privata, che, ad un certo punto della sua divulgazione, seppe farsi convinzione politica; che quest’ultima […], sulla base del consenso che riuscì a provocare attorno a sé, arrivò a […] organizzare la lotta politica [della borghesia nascente] contro le autorità tradizionali» (pp. 267-268); che Galilei, al contrario di quanto ancora si creda sul suo conto, debba la sua svolta storica rivoluzionaria non all’eliocentrismo o alla matematizzazione del mondo, ma alla scoperta di un pensiero (non tanto con gli oggetti ma) degli oggetti; questo è un aspetto del tutto inedito di Galilei e che con Calemme vale la pena di accogliere se si vuole elaborare prima o poi una storia rigorosa della tecnologia.
Inoltre se il testo di Calemme può sembrare superfluo, per chi come noi, marxianamente, volesse riflettere sul ruolo, per nulla neutro, che la tecnologia ricopre nel dominio borghese della società, scoprirà invece che è uno scritto assolutamente necessario, ad esempio, per comprendere la svolta digitale del mondo.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa





Eros Barone
“La svolta storica rivoluzionaria” e l’asse dello scontro fra lo scienziato pisano e la Chiesa sono da individuare, oltre che nel conflitto epistemologico fra realismo e strumentalismo (alla genesi, alla dinamica e all’esito del quale, quindi al ‘compromesso bellarminiano’, sarà opportuno dedicare altrove un’analisi specifica), nel processo di disantropomorfizzazione della natura avviato dalla scienza moderna. La carica potentemente materialistica ìnsita in tale scienza era infatti destinata a produrre un antagonismo irriducibile con la cosmologia e con l’ontologia religiose e, alla fine, malgrado il ricorso alla dottrina della ‘doppia verità’ ed i tentativi di operare distinzioni tra ‘come vadia il cielo’ e ‘come si vadia in cielo’, con la stessa teologia. E, quando evoco questa carica esplosiva, intendo riferirmi in primo luogo non alle concezioni filosofiche della scienza moderna elaborate da Cartesio o da Newton (che non erano materialistiche), ma a quel carattere distintivo (còlto invece con grande consapevolezza da Galileo) che fa di essa una forma di conoscenza metodologicamente atea.
Orbene, se è vero che il finalismo, in senso proprio, è stato introdotto nel mondo dall’uomo (= antropomorfizzazione della natura), è altrettanto vero che l’estensione di esso, operata dal pensiero filosofico, alla biologia e in genere alla realtà fisica non è altro che un ‘idolum tribus’ (Bacone) o, per dirla in altri termini, un ‘asylum ignorantiae’ (Spinoza). L’evoluzione biologica dimostra infatti ‘tendenze’, non ‘fini’, e scambiare le une con gli altri… è peggio d’un delitto, è un errore (per riprendere la frase che usò Fouché, quando apprese la notizia della fucilazione del duca d’Enghien): ossia è un errore di grammatica epistemologica.
Anche per questo motivo Marx poteva salutare con entusiasmo “L’origine delle specie” di Darwin e scrivere ad Engels, per l’appunto nel 1859, quanto segue: «È proprio stupendo. Per un certo aspetto la teologia non era ancora stata sgominata e lo si è fatto ora». Non a caso anche l’analisi marxista della società mette in evidenza ‘leggi di tendenza’, non ‘fini’. I ‘fini’ sono propri semmai degli individui umani, intesi come singoli o come gruppi operanti nella società e condizionati da essa, ma non sono propri della società stessa quale prodotto e risultato del loro operare.
Naturalmente, questo non significa che la definizione dell’uomo come ‘un animale che si pone dei fini’ non sia corretta e non individui una proprietà che è caratteristica dell’essere umano. D’altra parte, che cos’è il ‘lavoro’, in senso specificamente umano, se non un’articolazione decisiva di questa proprietà caratteristica dell’uomo? Tuttavia, incorrerebbe ancora una volta in un errore di grammatica epistemologica chi volesse estendere questa proprietà all’intera unità sociale, come se quest’ultima fosse un semplice aggregato di individui. Errore nel quale – va detto –, grazie alla sua profonda sensibilità scientifica e malgrado la sua concezione finalistica del mondo, evitò di cadere lo stesso Aristotele, il quale si rese conto che la società non è una semplice proiezione degli individui che la compongono (= macroantropo platonico), neanche se tali individui sono intesi non come individui singoli, ma come strutture economico-sociali (cfr., nel contesto della società antica, la famiglia quale insieme di liberi e di schiavi).
Può essere utile, infine, poiché giova a illuminare il problema del rapporto fra astrazione e mondo reale, un chiarimento sul modo in cui la teoria marxista concepisce l’universale (modo che, a mio giudizio, supera l’antitesi fra essenzialismo ed empirismo, che caratterizza le due principali varianti della filosofia borghese). Ancora una volta, proprio quell’Aristotele di cui Galileo soleva dire che, se fosse stato vivo, avrebbe approvato il suo modo di ragionare e non quello degli aristotelici, ci spiega come vada inteso l’universale, quando, ad esempio, distingue ‘realiter’ (e non ‘formaliter’) fra le tre anime, evitando di postulare l’esistenza di un’anima che, senza corrispondere a nessuna di esse in una qualsiasi forma determinata e semplice, sia il ‘quid commune’ a tutte e tre; così come sempre Aristotele ci chiarisce la natura dell’universale, quando osserva che, rispetto alle diverse figure geometriche (triangolo, quadrato, pentagono ecc.), l’elemento comune ad esse, qualora venga inteso come ‘la figura in generale’, è solo un vuoto ente di ragione, mentre la figura veramente universale (che ricompare anche come quadrato, pentagono ecc.) è il triangolo, poiché esso è la figura-base, determinata e semplice, cui si può ridurre ogni altra figura.
In ciò risiede, fra l’altro, la genialità scientifico-filosofica dei primi pensatori greci, i tanto bistrattati (per il loro materialismo…) ‘physiológoi’, che concepivano l’universale come una sostanza completamente fisica, di natura acquea o aerea o ignea. Ma allora il prodotto dell’astrazione (di quella astrazione che, per poter tornare al mondo reale con efficacia euristica, deve prima ‘obliterarlo’ e allontanarsene, vicariandolo con un modello teorico e realizzando in tal modo il galileiano e marxiano circolo metodico ‘concreto-astratto-concreto’), ossia l’universale, non solo si manifesta (senza separarsi da essi) nei fenomeni particolari, ma esiste altresì come individuo particolare insieme con gli altri individui particolari, da esso prodotti (esattamente, per usare un paragone, come il padre che, dopo averli generati, vive spesso a lungo insieme con i suoi figli).
A questo proposito, in una sua lettera a Engels del 25 marzo 1868, Marx, soffer-mandosi sull’etimologia del termine ‘universale’, esclama con ironica soddisfazione: « Ma che cosa direbbe il vecchio Hegel se sapesse nell’aldilà che l’Universale (‘Al-lgemein’) in tedesco e in nordico non significa altro che la terra comune, e il Partico-lare (‘Besondere’) null’altro che la proprietà particolare separata dalla terra comune? ».
Ecco perché l’identificazione quasi automatica dell’universale con l’idea è la tesi centrale di ogni idealismo: una tesi che viene assunta come un assioma, mentre in realtà non è altro che un pregiudizio ereditato dal medioevo. Ed ecco perché Marx ed Engels, pur usando il metodo dell’astrazione determinata (= generalizzazione, logicamente e storicamente differenziata, delle esperienze particolari), affermano la realtà oggettiva dell’universale (certo non nel senso di Platone e di Hegel ma) nel senso della esistenza di un legittimo nesso tra i fenomeni materiali, nel senso cioè della loro unità in una legge, la quale tuttavia non li unifica sopprimendo le loro differenze ed opposizioni, bensì li riconduce ad una genesi comune. E quest’ultima, definita di volta in volta con sempre maggior precisione, ad esempio, in fisica, come movimento, inerzia, massa, gravitazione, spazio-tempo ecc., che cos’è, rispetto a quei fenomeni che ne costituiscono le multiformi modificazioni, se non una medesima sostanza, la cui natura pienamente materiale la rende indipendente sia dal pensiero che dalla parola? Ancora una volta Spinoza si rivela il “maestro di color che sanno” dell’età moder-na, il pensatore che, coerentemente con l’immagine meccanicistica del mondo nell’età della manifattura, declina la sostanza come ‘grande filiera dell’essere’, mentre Althusser non fa altro che seguire le sue tracce quando, per caratterizzare la totalità complessa a dominante, riprende il concetto hegeliano del “processo senza soggetto”.
Angelo Calemme
Commentando il commento di Eros Barone confermo che la cosa che in prima istanza è straordinaria dell’opera di Galilei è la stretta interconnessione che nella filosofia sperimentale avviene tra la convinzione atea della natura, la metafisica dell’autonomia e dell’automatismo degli oggetti tecnici di misurazione e il progresso storico della conoscenza che si scorgono in Galilei. Il problema galileiano non è dunque se Galilei fosse stato ateo o meno ma se lo fosse stato il pensiero sperimentale. Le ricerche sviluppate hanno dimostrato, con fonti alla mano, che l’esperienza sensata di Galilei poneva Dio, l’uomo e la simpatia tra questi, fuori dal mondo naturale e questo è il gesto puramente politico che spodesta la Chiesa e la teologia della loro autorità. I moderni (i galileiani) divengono maggiorenni, una volta posto fine al regno di Dio, del padre del mondo: ragion per cui la natura da conoscere d’ora in avanti sarebbe stata quella sorda e inesorabile (la natura leopardiana era la natura di Galilei infatti) degli stretti rapporti di necessità fisica che l’autonomia dei nuovi oggetti di scienza esprimevano nel loro funzionamento. In altre parole da Galilei in poi si studierà non solo la natura oggettiva, fisica, del mondo ma anche e soprattutto come pensano gli oggetti, perché pensando come pensano gli oggetti sarà possibile scoprire la verità fisica.
In Galilei, a proposito della teleologia, il finalismo continua a sopravvivere, solo che non è più la teleologia aristotelica o quella scolastica ma è una teleologia di nuovo genere, del pensiero autonomo e automatico degli oggetti. In altre parole, prima di Kant, la teleologia tecnologica di Galilei è senza un fine, una pura legge di ignoranza insita nella natura sorda e inesorabile. Per certi versi la stessa pretesa avviene in Darwin, dove egli (come si vede dai suoi taccuini) elabora il concetto di autonomia della vita (di selezione naturale) come finalità senza scopo nel fenomeno, solo che la vita darwiniana non è fisica (galileiana), non varia in base a condizionamenti ambientali, non tende a variare obbedendo a leggi galileiane (come credeva Lamarck, il quale fece una teoria dell’evoluzione e non della selezione naturale), ma in base a scelte ignoranti che la vita esprime in maniera autonoma (Darwin è figlio non della metafisica dell’indipendenza galileiana ma dell’autonomia della volontà kantiana). Marx quando ragionava sulla sua storia critica della tecnologia per analogia (i ragionamenti per analogia portano irrimediabilmente a grossi errori) con la teoria della selezione naturale, tentava di forzare categorie non forzabili e se il fallimento del suo tentativo fu evidente non lo fu solo per la sua sopraggiunta morte ma anche per queste forzature. Prima di tutto il paradigma marxiano si sviluppa da una critica al pensiero hegeliano, quest’ultimo di per sé rimane una storia del lavoro (dell’incessante lavoro dello spirito), ovvero una storia dell’umanità dei lavoratori, che ontologicamente rifiuta l’impostazione schellinghiana della storia naturale (del selvaggio circolo della vita) come storia della vita come volontà autonoma nel fenomeno (dove tutte le vacche sono nere). Quindi il pensiero economico di Marx non puo’ dialogare con quello biologico e l’analogia tra accumulazione e selezione è insostenibile dal principio. La tecnologia non “accumula” le conoscenze produttive come fa la “selezione naturale”, quest’ultima obbedisce a leggi diverse (non a caso Darwin, coscientemente, rifiuta di assecondare la richiesta di Marx di farsi dedicare il Capitale). Marx in altre parole credette di fare un ragionamento darwiniano, ma fece invece un ragionamento lamarkiano, meglio ancora galileiano (-newtoniano). Una storia critica della tecnologia andrebbe riscritta non cercando di capire la vita e le sue leggi (vedi Kant, Schelling, Darwin) ma le leggi indipendenti e galileiane del pensiero degli oggetti e, sulla base di ciò, del loro rapporto con la storia del lavoro (le scienze esatte in rapporto con quelle kantiane). In un certo senso, provando ad andare oltre, andrebbe capito in che modo la tecnologia moderna (la filosofia galileiana) si appropri del lavoro e della sua storia a fini privati e, contemporaneamente, in che modo la logica degli oggetti sia consustanziale, almeno in questa fase storica di minorità della tecnologia) allo sfruttamento del lavoro. Bisogna prima capire come funzionano i saperi esatti (galileiani) e quelli critici (kantiani) e poi sulla base delle loro contaminazioni storiche come la tecnologia moderna si sia sviluppata in questa lacerazione ontologica ed epistemica tra questi due orizzonti di sapere. Capire la filiazione dei saperi ci aiuta a capire il senso autonomo, ateo e inumano, del senso, della logica, degli oggetti moderni (la tecnologia moderna), per poi poter ricostruire la storia di quest’ultimi e predire (come fecero già Galilei e Turing) come nel telescopio e dopo di esso nel computer, cosa ci riserverà il futuro dell’intelligenza artificiale e quali nuove schiavitù e libertà la sua maggior età, la sua maturità (la sua completa e realizzata autonomia, la sua indipendenza assoluta), ci riserverà. La questione è molto complicata e andrebbe portata finalmente al centro del dibattito nazionale e internazionale, cosa che i comunisti prima di tutti dovrebbero prima o poi inaugurare. Ciò avverrà, credo, solo se i comunisti ritorneranno a “pensare” politicamente e con ciò il loro contributo per rovesciare i rapporti di forza esistenti non solo tra capitale e lavoro ma anche quelli tra natura, tecnologia e umanità.
Redazione Contropiano
Per quanto concerne il rapporto tra marxismo, darwinismo e lamarckismo, può essere interessante ricordare come lo stesso Stalin, in una sua opera giovanile intitolata Anarchia o socialismo?, composta di una serie di articoli pubblicati tra giugno e luglio del 1906 nel giornale «Akhali Tskhovreba», si fosse riferito a tale controversia, mostrando la sua propensione per la posizione dei fautori dell’ereditàrietà dei caratteri acquisiti. «Il sistema periodico degli elementi di Mendeleev», egli notava in quell’occasione, «dimostra chiaramente la grande importanza che ha nella storia della natura il prodursi di cambiamenti qualitativi da cambiamenti quantitativi. Questo è dimostrato anche in biologia dalla teoria del neo-lamarckismo, che sta soppiantando il neodarwinismo». Nella stessa opera Stalin sottolinea acutamente la debolezza del darwinismo, che consiste nel fatto che «…il darwinismo non respinge soltanto i cataclismi di Cuvier, ma anche lo sviluppo dialetticamente concepito, comprendente la rivoluzione, poiché dal punto di vista del metodo dialettico, l’evoluzione e la rivoluzione, il cambiamento quantitativo e quello qualitativo, sono due forme necessarie di un solo e stesso movimento». Merita di essere ricordata altresì la posizione di Anatolij Lunačarskij, commissario del popolo per l’istruzione pubblica, il quale era talmente convinto dell’incompatibilità della genetica con il marxismo-leninismo da farsi promotore della realizzazione di un film, di cui egli stesso scrisse il commento, sul naturalista austriaco Kammerer, che aveva creduto di dimostrare l’ereditarietà dei caratteri acquisiti. Questi primi tentativi di stabilire una forma di contatto tra la dialettica, da una parte, e la biologia e la genetica, dall’altra, provocarono un’ampia discussione, che si concentrò quasi immediatamente attorno alla questione della ‘riducibilità’ della forma biologica di movimento della materia alla forma fisica e chimica: una questione particolarmente importante e delicata, dal momento che coinvolgeva il problema della natura e dello statuto del metodo dialettico nelle sue relazioni con i metodi specifici di ricerca. Fu su questo problema, per l’appunto, che divampò con accenti particolarmente aspri, non solo tra i filosofi ma anche tra i biologi, la disputa tra i ‘meccanicisti’ e i ‘dialettici’. Così, dopo la morte di Lenin i teorici sovietici si divisero in due scuole: da un lato, per l’appunto, i dialettici che, guidati da Deborin, interpretavano il materialismo dialettico come una ‘filosofia’ i cui antecedenti storici andavano rintracciati nella dialettica hegeliana e nel materialismo feuerbachiano; dall’altro, i meccanicisti che, guidati da Timirijzev (appoggiato da Bucharin), interpretavano il materialismo dialettico come una ‘scienza’ alla quale spettava il compito di estendere le leggi elaborate dalle singole discipline specialistiche a tutto il complesso di fenomeni concernenti l’essere e il pensiero, talché, in base a siffatto punto di vista, la concezione materialistica veniva a coincidere con l’insieme delle conclusioni ultime e più generali della scienza contemporanea. Così, la serrata polemica che i biologi, aderenti al gruppo di Deborin, condussero contro le ristrette posizioni dei meccanicisti in fatto di ereditarietà e variazioni, cominciarono ben presto a indirizzarsi contro quella particolare varietà di meccanicismo, che venne battezzata con il curioso termine di «meccanolamarckismo». Per quanto riguarda l’Occidente, nella letteratura scientifica si è vista rifiorire, come ai tempi di Lysenko, l’idea neo-lamarckiana. Piaget per esempio, nel suo “Biologie et connaissance” (1966), si fa propugnatore della rinascita dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti e questo in nome del rifiuto dell’atteggiamento ferreamente deterministico della genetica molecolare. All’altro estremo si trovano naturalmente i sostenitori del darwinismo stretto, che fanno anch’essi appello ad un finalismo rigoroso, quello di una selezione manichea che guida su un cammino stretto tutte le forme di vita, ivi comprese le sue implicazioni sociali. I sociobiologi utilizzano perciò in nome del darwinismo gli stessi princìpi informatori dei seguaci del trasformismo lamarckiano. A prima vista, questo potrebbe sembrare contraddittorio, ma basta leggere le infiammate dichiarazioni di Lysenko nella sua “Agrobiologij” (1943), nella quale si proclama fervente discepolo di Darwin pur “dimostrando” l’ereditarietà dei caratteri acquisiti, per capire che questi due atteggiamenti sono antitetico-speculari. In realtà, Lysenko fu tutt’altro che un ciarlatano prono al potere e strumento passivo della sua propaganda ideologica, come vorrebbero far credere i suoi denigratori. Egli fu certamente uno scienziato organico al potere socialista sovietico e attento alla traduzione pratica delle sue teorie biologiche sul terreno delle concrete politiche agricole, ma fu anche un valente ricercatore, come dimostra la sua fondamentale scoperta della “vernalizzazione”, che influenza ancora oggi la biologia vegetale.
Eros Barone