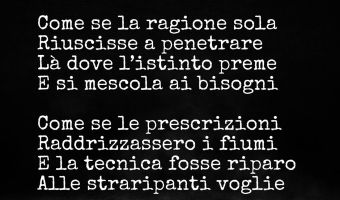Macchina da presa ferma. Una donna, chiusa in una stanza, è al telefono e parla col suo amore, ormai perduto. Sussurra languida e grida in preda alla disperazione. Piange e placa le lacrime, intingendole in un rosso cupo di vocale intensità cromatica. Si lascia sedurre dalla momentanea ragionevolezza della propria legge morale e sventrare dalle implacabili stelle della follia, incendiate nel cielo nero della sensualità in delirio.
La voce disegna tenui acquarelli, racconta storie in tonalità pastello, vira in un mare di fiamme cobalto, sprofonda negli abissi della sua inconfessabile vulnerabilità, per poi impennarsi, repentina, nello stridore di un’angoscia calda e melodrammatica. Il corpo si contrae, si avvita, si raffredda, si scuote, modula e lascia vibrare le emozioni, attraversando, con la sua carne e i suoi nervi, un volto che non è mai maschera re/citante, ma anima pulsante sangue, infetto di dolore e di passione. Mentre guardiamo, sullo schermo, quella donna – e l’attrice che le dona voce e corpo – ci sembra di ascoltare, in un’unica, ipnotizzante sinfonia, “La patetica” di Čajkovskij e il “Bolero” di Ravel.
In quell’attrice non c’è ossessione tecnica, non c’è la pulizia asettica, efficiente, irritante, degli hollywoodiani interpreti dell’Actor Studio; non c’è il titanismo individualista del cinema statunitense, dove il personaggio è la creta spettacolare attraverso cui l’attore prende forma di star, nel dorato empireo dello star system. No, quell’attrice è tremito furente di vita. Vita sporca quanto si vuole, ma vita. Essenza emozionale, colta grezza al suo immediato sbocciare. Realtà, intima e dolente, di un cinema creato immergendosi nella quotidianità più semplice e, forse, disperata, ma mai artefatta, per quanto verosimile.
Un cinema collettivo, quello dell’Italia neorealista, dove il personaggio – e dunque l’attore – era al servizio della collettività e del contesto storico, sociale, culturale, di cui si faceva specchio esistenziale, attraverso il film, senza mai, però, divenirne l’eroe, in tutte le sue innumerevoli declinazioni.
L’attrice è Anna Magnani. Il film è Amore, di Roberto Rossellini, diviso in due episodi. Quello al quale si fa riferimento, è il primo: “Una voce umana”. E la prova interpretativa a cui assistiamo è un vero e proprio archetipo dell’arte attoriale. Qui non siamo di fronte all’esasperante perfezione di un attore travestito da superuomo o da professore di filosofia morale. Qui siamo sul lato opposto della strada. Dove camminano, vivono, sentono, donne e uomini qualunque.
Un’interpretazione, quella della Magnani, che dovrebbe essere proiettata in tutte le scuole di recitazione. Un’interpretazione che dovrebbe essere studiata a fondo, da chiunque voglia definirsi attore. Un lavoro il cui senso, da tempo – che si tratti di teatro o di cinema – sembra essere quello dominante in ogni settore della nostra società. La merce!
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa