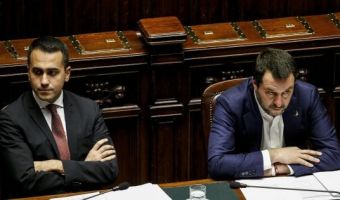Ancora un teatro che chiude. Ancora un teatro al Mezzogiorno. Dopo lo sgombero, avvenuto qualche giorno fa, del Teatro La Giostra, in Via Speranzella, a Napoli – sgombero ordinato dall’assessora al Patrimonio del Comune partenopeo, Alessandra Clemente, con l’accusa di morosità mossa nei confronti della proprietà, le sorelle Maria e Valeria Tavassi, malgrado l’amministrazione di Palazzo San Giacomo avesse, precedentemente, concesso l’utilizzo degli spazi alla cooperativa omonima – anche il Teatro Bertolt Brecht di Formia, di Maurizio Stammati, non ha più una casa. Trent’anni di attività culturale e di resistenza teatrale rischiano, così, di scomparire, in un territorio di provincia dov’ è sempre molto difficile far nascere e sopravvivere progetti culturali.
La causa di questo ennesimo sfregio ad un settore teatrale già pesantemente colpito dalla crisi – e al mondo della cultura più in generale – è il previsto abbattimento dell’edificio in cui hanno sede la scuola Vitruvio Pollione e il Brecht stesso. Un edificio da tempo danneggiato e già più volte ristrutturato, seppur in maniera approssimativa e senza rispettare gli standard di sicurezza. Il comune di Formia, probabilmente, si sarebbe dovuto muovere per tempo, per ricollocare gli spazi teatrali, e invece, come sempre, si è atteso l’inevitabile e drammatico esito. Dove andrà il Bertolt Brecht resta dunque, al momento, un punto interrogativo.
Intendiamoci, tanto nel caso de La Giostra, quanto nel caso del Bertolt Brecht, non proponiamo qui difese d’ufficio, convinti, come siamo, che vadano accertate le resoonsabilità sia delle proprietà che delle istituzioni.
Lascia però l’amaro in bocca, questa ennesima vicenda di malaccorta gestione delle politiche culturali, soprattutto in territori, come quelli meridionali, dove la necessità di attività culturali è impellente e il cui obiettivo deve essere la crescita di un pensiero critico e di una coscienza civica, troppo spesso mancanti. Specie in una fase tanto travagliata come quella che sta attraversando il nostro paese.
Due storie, perciò, evidentemente molto diverse tra loro. Due storie, però, entrambi imputabili, senza dubbio alcuno, al sempre più lampante e sempre più intollerabile menefreghismo politico nei confronti della cultura e dell’arte. Specie quando si tratta di arti sceniche, come il Teatro.
Linguaggio antico, il Teatro. Che fatica a reggere la concorrenza dei Tempi veloci. Carrozzone di parole, di frasi, di gesti, di persone, di attrici e attori, in affanno di fronte alla concorrenza crudele della modernità, con la sua comunicazione superficiale, smart. Occhi, braccia, mani, piedi che subiscono l’affronto degli avatar, partoriti nell’etere della realtà virtuale. Degli ologrammi nati sulle onde del web. Delle immagini in 3d, proiettate da universi paralleli, quantici, che stanno soppiantando, ormai, finanche le piccole stelle e i piccoli Dei del Cinema e della Tv.
Linguaggio antico, il Teatro. Antico come la Donna e l’Uomo. E come il fango che li ha generati. Come i graffiti dell’arte rupestre. Come il carro di Tespi e il canto ebbro di Dioniso smembrato.
Mestiere impastato di polvere e legno. Fatica fatta di studio e di nervi. Sforzo inciso nella carne e sui corpi. Lavoro profumato del sudore dei saltimbanchi della vita. Sacrificio di artigiani e di mani. Creazione di intelligenze pratiche e di immaginazioni oniriche. Di sogni di sabbia e di illusioni imbastite nel vento.
Linguaggio antico, il Teatro. Follia amletica, nascosta nell’ ombra di un sipario. Disperazione d’amore, sussurrata tra i fantasmi che popolano la notte. Come gli incubi di Lady Macbeth. Rito inattuale, celebrato da sacerdotesse pagane. Gioco sfrenato, come il primo orgasmo goduto.
Linguaggio antico. Invenzione costruita sulle lettere di piombo dei libri. Calici di vino e scrittura, trangugiati, di nascosto, al primo chiarore del giorno.
Gente di bottega, i teatranti. Attori di un’economia piccola, fatta di bassi salari. Inadeguati al circo contemporaneo del Capitale divenutovisione impalpabile. Maestri e allievi di un apprendistato stregonesco, sciamanico, ancestrale. Inadeguati ai tempi della merce, spacciata nei fantasmagorici megastore della cultura.
Un linguaggio antico, che sempre meno interessa alla politica e al mondo degli affari, il cui solo obiettivo è abbattere i costi e massimizzare i profitti. Ricerca, avanguardia, sperimentazione sono, dunque, concetti abrogati, in un contesto economico dove conta l’impresa, la produttività, il far cassa, il mercato, l’aspetto effimero della Bellezza. O che tornano utili solo quando quella ricerca, quella sperimentazione, quell’avanguardia, si ammantano di elitarismo intellettuale, per pubblici di nicchia, genericamente radicali e chic, che spendono soldi e portano ricchezza, per lasciarsi sedurre, il più delle volte, da astrusi codici che fingono di comprendere ma al cospetto dei quali, per la maggior parte, restano come l’uomo di Nietzsche che ammira l’abisso e da esso viene ammirato.
È la grande magia del postmodernismo e della sua ermeneutica a-finalistica, dove il relativismo del segno linguistico ed artistico sprofonda in baratri semiotici, in fanatismi polisemici, in citazionismi rimasticati e utili solo all’auto gratificazione narcisistica dell’arista/demiurgo. Una Grande magia, capace di affascinare il pubblico, con la struggente malia di un manierismo poetico sovraesposto, spesso frutto di un’inautentica volontà creatrice, indirizzata sapientemente al solo guadagno.
E allora, in un simile contesto, appare fin troppo evidente come tanto il Bertolt Brecht di Formia quanto La Giostra di Napoli, siano palesemente vittime predestinate di un sistema politico ed economico che considera la cultura un bene superfluo ed effimero. Fattore di svago per la borghesia ed il popolo, sebbene ciascuno con la propria cifra. Oppure, come si accennava prima, semplice veicolo di propaganda ideologica, di matrice neoliberista, e pertanto, giammai strumento per la costruzione di un pensiero critico, o presunto tale, che non abbia il consenso delle elites finanziarie, produttive e politiche al comando. In perfetta sintonia con la logica governamentale che sovrintende tanto il sistema paese, tanto l’Unione Europea di stampo ordoliberista, quanto l’intero mondo occidentale, sempre più modellato, anche nei suoi non secondari fattori intellettuali, in base ai principi del profitto, dell’individualismo, del protagonismo esacerbato, del fashion & cool. In una parola, dello spettacolo fine a sé stesso.
Un mondo e un sistema da cui – recuperando la tesi espressa da Walter Benjamin in L’Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica – l’opera d’arte stessa, lungi dall’aver perduto la sua tradizionale aura cultuale e divina per acquisire quel valore di choc rigenerante, indispensabile per la costruzione di un’arte sinceramente e nobilmente di massa e finalmente rivoluzionaria, rischia di venire posta ai margini, se non cancellata nel suo stesso valore intrinseco!
Se si continua, difatti, a ritenere che la cultura e l’arte siano un semplice orpello decorativo del pensiero e delle città; o, ancora, superfluo svago borghese; o, peggio, un ingranaggio del sistema produttivo, attraverso cui il capitale tende alla sua infinita autovalorizzazione, mercificando arte-cultura-artista (Marx: Manoscritti e Teorie sul plusvalore).
O quando addirittura – ancora per riprendere Benjamin – si considerano arte e cultura alla stregua di armi nelle mani di totalitarismi pseudo democratici, il cui obiettivo è quello di imporre il dominio del pensiero unico e di un’estetica ad esso funzionale, utilizzando l’esperienza artistica come strumento di controllo delle masse attraverso un’estetizzazione della politica (in virtù della quale l’esperienza estetica viene strumentalizzata come forma di comunicazione non razionale ma carismatica, per coinvolgere e massificare la folla) ebbene, quelli che abbiamo sotto gli occhi sono i miseri risultati che, unici, ci si può attendere. Una cultura e un’arte di Potere. Con buona pace di quella Controcultura che un fondamentale ruolo vivificatore ebbe nella creazione e lo sviluppo delle esperienze rivoluzionarie, che si diffusero in Italia e in tutto il mondo tra gli anni ’60 e ’70.
Oggi, invece, con il compimento della ristrutturazione capitalistica, portata a termine alla fine degli anni ’80, anche la cultura è stata ridotta a merce.
L’idea, esclusiva e distorta del mero profitto, sta passando sulle nostre intelligenze come le ruspe salviniane, aggredendo la nostra stessa dimensione umana. Una dimensione esposta al rischio, sempre più evidente, di smarrire -smarrendo cultura e arte– la propria stessa sensibilità, empatia, capacità relazionale, coscienza critica e civile.
Il Mercato detta le sue leggi del desiderio. I desideri si conformano. E le nostre vite si riducono ad un grafico di borsa. Arte e Cultura, inequivocabilmente, subiscono la stessa ed inevitabile sussunzione.
Le misure di austerità, dettate dall’Europa, rappresentano, d’altra parte, la causa prima -in Italia e altrove- non solo del decurtamento della spesa nel settore, ma anche dello svuotamento degli stessi contenuti culturali. Restando in quest’Unione Europea di impronta ordolibetista (dove la stessa Germania investe appena l’1% del Pil in cultura, la Spagna l’1,1 e la Francia l’1,3) è illusorio prospettare un cambiamento radicale, tanto delle condizioni di lavoro delle figure del comparto (artisti o maestranze che siano) quanto dei “prodotti” culturali, soggiacenti, per larga parte, alla logica dell’effimero, dello svago e dell’intrattenimento. Per di più, legata all’indotto turistico, in un’ inaccettabile e svilente sinergia, imposta dall’ideologia dominante, di stampo neoliberista.
In Italia, poi, la spada di Damocle dell’Autonomia Differenziata, che l’attuale governo tiene sospesa sulle nostre teste, fa fortemente temere che, se questo progetto dovesse effettivamente tramutarsi in Legge, la sperequazione tra Nord e Sud, circa la gestione della spesa, sará ancor più evidente di quanto non sia attualmente. Si tenga presente che l’Italia investe lo 0,7% sul Pil in Cultura: di cui l’80% nelle regioni settentrionali e solo il 20% in quelle meridionali. Le conseguenze, com’è facile intuire, sarebbero drammatiche per l’intero settore, al Mezzogiorno. Con ricadute, in termini di disoccupazione e precarietà, ancor più nefaste sui lavoratori.
Dunque, com’è facile intuire, si galleggia in un mare in tempesta in tutti i settori della nostra vita, e anche sul versante dello spettacolo dal vivo, dell’arte e della cultura in generale. Nonostante ciò, un concetto va affermato, con forza e senza tema di smentita.
Un sistema senza cultura, che schiaccia o, di fatto, espelle intellettuali e artisti scomodi, per assumere, nell’alveo della cosiddetta intellighenzia, esclusivamente mezze figure genuflesse al potere, ai prìncipi o agli autocrati di turno, è un sistema debole. Che ha paura. Un sistema che, per tanto, deve essere aggredito proprio nel suo ganglio sovrastrutturale, ideologico, culturale.
Come comunisti è un problema che dobbiamo porci. E con urgenza! Ricordandoci, sempre e comunque, che senza socialismo c’è la barbarie. Ma anche un socialismo senz’arte e senza cultura sprofonderebbe nella Vandea.
È tempo di mettersi in ascolto perché, come dice Bertolt Brecht: «Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili». In morte di Lenin. Ricordiamolo!
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa