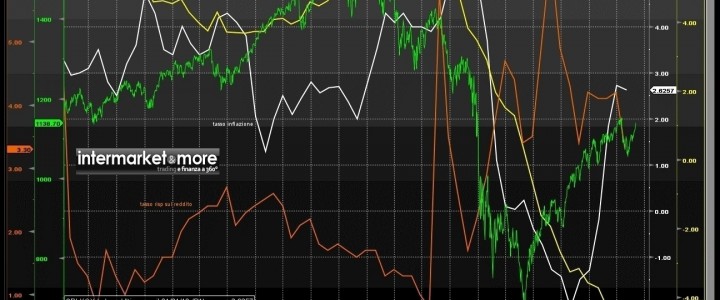Quello che sta accadendo negli Usa non ha bisogno di commenti. Dimostra, semmai, l’impotenza di Obama costretto a estenuanti trattative con i repubblicani e soprattutto con l’ala più conservatrice che spera di buttare a mare, il prossimo anno, il primo presidente di colore degli Stati uniti. Negli Usa è soprattutto in atto uno scontro politico che assomiglia molto a quanto successo in Italia con la manovra correttiva per la quale il governo proponeva solo una «manutenzione» dei conti per il 2011 e il 2012, in modo da poter affrontare in pace le elezioni che, se perse, avrebbero lasciato agli eredi di Berlusconi il compito di una stangata enorme.
Obama, infatti, vuole perseguire una politica più progressista annuciando tagli alla spesa (anche quella sociale) ma anche ai privilegi imposti fin dai tempi di Bush che varò una riforma fiscale con la quale il 90% degli sgravi è finito nelle mani dei più ricchi. Insomma, il presidente insiste per una politica di tagli acompagnata da un aumento della pressione fiscale su chi di tasse ne paga (legittimamente) poche. Al contrario i repubblicani insistono per tagli profondi che colpirebbero il welfare lasciando immutata la pressione fiscale in vase al principio (falso) che se si pagano poche tasse la gente ha più soldi da spenedre per i consumi. In questo modo favorendo la ripresa.
I repubblicani però dimenticano che l’esplosione del debito publico è iniziata con la’mministrazione di Bush padre, mentre ai tempi di Clinton il bilancio era addirittura in attivo. E dimenticano che sono stati loro, con le scelte di politica imperiale (Iraq e Afganistan) a dare il via alla escalation del deficit e del debito. E sempre loro, con i tagli al welfare, hanno innescato la spirale di speculazione finanziaria che, causa la pessima distribuzione dei redditi, ha gonfiato la bolla che una volta esplosa ha messo in crisi il sistema globale. Di più: è stato George Bush ha dare il via al gigantesco intervento di salvataggio del sistema finanziario Usa che ha ridato fiato alle banche, ma non all’economia reale. Matenendo così immutata (al contrario di quanto era accaduto con Roosvel nel ’29) la distribuzione dei redditi. Una situazione alla quale Obama è riuscito solo a mettere delle «pezze» e non amodificare radicalmente.
Certo, alla fine tra repubblicani e democratici un accodo si troverà. Molti siti Internet commentano la situzione scrivendo che siamo di fronte a una grande «moina», cioè a un gioco politico. L’impressione, però, è che l’accordo sarà al ribasso: un brutto compromesso che servirà solamente a evitare la riduzione del rating degli Usa con tutte le conseguenze facilmente intuibili sul piano dei tassi di interesse (destinati a crescere) a di crescita del Pil destinata, invece, a rallentare. Tutto questo che copnseguenze avrà sull’Italia?
Molte e gravi: un paese con un debito pari al 120% del Pil è fortemente dipendente dagli investitori internazionali che per acquistare titoli del debito pubblico italiano chiederanno tassi di interesse più alti, come hanno dimostrato anche le aste di ieri. La crescita degli interessi, a sua volta, produrra una aumento del debito, vanificando gli sforzi di risanamento. E nuove stangate produrrano un ulteriore rallentamento della crescita del Pil, frenendo l’occupazione già a livelli infimi e drammatici. Il tutto, c’è da scommeterci, rilanciando le proposte più bieche – come negli Usa – di un ulteriore dimagrimento dello stato sociale.
Insomma, i tempi cupi sono dietro l’angolo e non è ben chiaro chi riuscirà a salvare l’Italia.
da “il manifesto” del 28 luglio 2011
******
Di tutt’altro parere, invece, il quotidiano di Confindustria
Il tetto al debito? Il nodo è politico
di Christian Rocca Mancano 6 giorni all’Armageddon contabile americano, a quel 2 agosto 2011 oltre il quale Washington non potrà più indebitarsi in mancanza di un accordo al Congresso sull’innalzamento del limite legale del debito pubblico. Ma per valutare le dinamiche delle trattative in corso tra Casa Bianca e Congresso, lo stato delle schermaglie politiche tra democratici e repubblicani e i dettagli delle proposte per evitare il fallimento tecnico del governo di Zio Sam bisogna tenere d’occhio un’altra scadenza, più lontana, ma fondamentale: mancano 495 giorni alle elezioni del 6 novembre 2012.
La partita è politica. L’America non rischia il default. Gli Stati Uniti non sono la Grecia. I mercati non sono preoccupati dall’insolvenza di Washington. Le agenzie di rating scalpitano, ma l’America non ha un problema di liquidità. L’economia non cresce come dovrebbe, ma gli investitori non mettono in dubbio le capacità di pagare gli interessi sui 15.476 miliardi di debito pubblico previsti per la fine dell’anno.
La crisi attuale nasce da una legge del 1917 – assente dai codici degli altri Paesi del mondo, con l’eccezione della Danimarca – che impone al presidente di non superare un certo limite all’indebitamento stabilito dal Congresso. Per risolverla basta un tratto di penna. In passato il tetto è stato alzato con qualche polemica, ma senza problemi, sia durante la presidenza di Ronald Reagan (18 volte) sia negli anni di George W. Bush (7 volte). Nel 2007, l’allora senatore dell’Illinois Barack Obama ha votato contro l’innalzamento del tetto, come oggi minacciano di fare i famigerati deputati dei Tea Party, motivando il suo no alla richiesta di Bush in nome di un rigore contabile molto simile a quello sbandierato oggi dai repubblicani e improvvisamente giudicato anti-patriottico dall’attuale Casa Bianca.
Il tetto al debito è una questione politica e i politici lo sfruttano per segnare punti in vista del ricco monte premi in palio il 6 novembre del prossimo anno.
Questo non vuol dire che il debito pubblico Usa sia una bazzecola né che nel Paese non ci sia un pericoloso irrigidimento ideologico tra repubblicani contrari a nuove tasse e liberal incapaci di rinunciare alla spesa pubblica. Ma a leggere i sondaggi si scopre che gli americani sono interessati ai posti di lavoro, non al debito (secondo Gallup, il 58% degli americani pensa che i problemi principali siano economia e occupazione, mentre solo il 16% cita il debito).
Non è una buona notizia per Obama, imbrigliato dalle manovre parlamentari repubblicane su un tema non stringente, mentre i suoi possibili avversari del 2012 se ne tengono alla larga e sono liberi di accusarlo di aver fatto sparire i posti di lavoro.
Un rapporto Goldman Sachs prevede che a novembre 2012 la disoccupazione sarà dell’8,8%, un po’ meno rispetto al 9,2 di adesso. La speranza di Obama è che gli americani si ricordino della situazione ereditata dal predecessore e si accorgano dell’estremismo dei suoi avversari. L’obiettivo dei repubblicani, invece, è dimostrare che le politiche economiche di deficit spending della Casa Bianca abbiano peggiorato la situazione, visto che ad aumentare è stato solo l’indebitamento, non l’occupazione.
Decisiva sarà la percezione finale della battaglia di questi giorni. Nessuno può prevedere come andrà a finire, anche perché i leader dei due schieramenti non sono certi di poter contare sull’adesione compatta delle proprie truppe. Il piano offerto dallo Speaker repubblicano della Camera John Boehner – rifiutato da Obama, ma non con la minaccia esplicita di veto – non piace all’ala intransigente del suo partito che già oggi potrebbe bocciarlo in aula. L’alternativa proposta dal leader democratico al Senato Harry Reid, accettata dalla Casa Bianca, non convince il mondo liberal, da Paul Krugman al New York Times, perché non prevede nuove tasse, ma soltanto una riduzione della spesa pubblica ritenuta però insufficiente dai repubblicani. Il presidente dovrà contenere i mal di pancia dei suoi, anche perché sulla necessità di tagliare la spesa è sceso sul terreno ideologico dei Tea Party. Ma rischiano anche i repubblicani. Ai tempi di Bush senior, dopo che il presidente aveva giurato di non aumentare le tasse, trovarono un compromesso con i democratici per la riduzione del debito e persero le elezioni. Negli anni di Bill Clinton, con Newt Gingrich alla guida della Camera, mantennero l’intransigenza, abbassarono le saracinesche del governo e regalarono un’insperata rielezione a un presidente che sembrava già sconfitto.
*****
Giocare con il fuoco
Luigi Zingales
Vista dall’Italia, la battaglia tra il Congresso americano e il presidente Obama sull’innalzamento del tetto al debito pubblico sembra assurda. Per legge la capacità del Governo americano di indebitarsi è limitata da un tetto numerico deciso dal Congresso. Periodicamente il Congresso lo innalza. Storicamente si trattava poco più di una formalità.
Oggi i repubblicani, che hanno la maggioranza nella Camera dei rappresentanti, stanno usando questa norma per costringere il presidente Obama a ridurre l’enorme deficit federale (11% del Pil). Il Presidente non vuole cedere al ricatto per non perdere la faccia. Senza l’innalzamento del tetto, il Governo americano sarà costretto a dichiarare l’insolvenza.
Al livello del fabbisogno statale corrente il tetto sul debito verrà raggiunto il due di agosto. Cosa succederà dopo quel giorno? Come tutte le imprese in crisi di liquidità il Governo americano cercherà di ritardare i pagamenti che può ritardare e anticipare gli incassi che può anticipare. Il Governo ha dichiarato che potrà tener fede ai pagamenti almeno fino al 10 di agosto. Se dice il 10 probabilmente significa che può tirare avanti fino al 20, ma non molto di più. Poi dovrà smettere di pagare i dipendenti pubblici, le pensioni, infine anche gli interessi sul debito, e dichiarare l’insolvenza.
Si tratta di un gioco molto pericoloso. La tanto preziosa AAA sul debito americano è già a rischio. Anche se l’accordo verrà raggiunto (come probabilimente sarà), queste tensioni indeboliscono l’immagine degli Stati Uniti come paese fiscalmente responsabile e potrebbero causare una riduzione del rating. Le agenzie di rating ammettono già che sarebbe più facile per gli Stati Uniti mantenere la tripla A se la legge sul tetto al debito venisse abolita. Un declassamento del debito comporterebbe un aumento dei costi di indebitamento, con un ulteriore peggioramento del deficit di bilancio.
Se poi l’accordo non venisse raggiunto in tempo per evitare l’insolvenza, i danni potrebbero essere enormi. Oggi il debito pubblico americano è usato come la garanzia più sicura in tutte le transazioni finanziarie in dollari. In caso di insolvenza, il debito americano perderebbe questa caratteristica, diventando meno appetibile. Il conseguente aumento dei costi di indebitamento è difficilmente stimabile, ma sicuramente molto elevato.
Perchè allora i repubblicani si assumono questo rischio? Sono trascinati in questa battaglia dai componenti del cosiddetto Tea Party, i quali interpretano il sentimento popolare. In un recente sondaggio condotto dalla Chicago Booth e la Kellogg School risulta che il 37% degli Americani è contraria all’innalzamento del tetto sul debito, contro un 17% a favore, mentre un 46% non sa. Sorprendentemente questa posizione non cambia quando agli intervistati vengono ricordati i pesanti tagli che il governo sarà costretto a fare in assenza di un accordo. Non si tratta quindi di una scelta inconsapevole. È una scelta cosciente che riflette la rabbia popolare contro una spesa pubblica giudicata eccessiva.
Per quanto molto rischioso, questo gioco sta avendo i suoi frutti. Voci di spesa ingiustificate (come i 6 miliardi di dollari all’anno in sussidi alla produzione di etanolo) un tempo giudicati intoccabili, oggi sono discussi e (speriamo) tagliati. Sembra un po’ assurdo che lo stesso Congresso che ha approvato questa spesa, oggi la voglia tagliare. Ma è meno assurdo se capiamo quali sono i giochi della politica. Se si discute sull’eliminazione del sussidio all’etanolo, tutti i deputati degli stati agricoli si sentono in dovere di votare contro. Non vogliono perdere il supporto (anche finanziario) della lobby agricola. Questa è la ragione per cui è pressochè impossibile tagliare spese individuali. In presenza di un limite complessivo, però, l’opzione di non tagliare viene rimossa: la scelta è solo dove tagliare. Quella che era una lotta tra le lobby e il contribuente per spendere di meno, si trasforma in una competizione tra lobby su dove tagliare. In questa competizione il contribuente è più tutelato. Il vincolo di bilancio è fastidioso, ma migliora l’efficienza delle scelte.
Paradossalmente la situazione in cui si trova l’America non è così diversa da quella italiana. Per gli americani il limite è autoimposto, per l’Italia il limite viene dettato dal mercato. Quest’agosto entrambi giocano con il fuoco: o tagliano le spese o rischiano il fallimento.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa