Il libro di Valerio Romitelli La felicità dei partigiani e la nostra. Organizzarsi in bande. (Cronopio, Napoli, 2015, pp.180, € 13) analizzando l’esperienza delle bande partigiane nel biennio 1943-’45, con una prosa scorrevole ed una argomentazione rigorosa, ci propone “il punto di vista di un pensiero politico, inteso in senso sperimentale, cioè che pensa la storia politica alla stregua di come si pensa la storia delle scienze e delle arti moderne: come succedersi di cicli di sperimentazioni.” (p.135)
Resistenza e partigiani. Romitelli apre la sua riflessione riprendendo una tematica già brillantemente affrontata nel suo precedente libro L’odio per i partigiani. Come e perché contrastarlo. (Cronopio, 2007), ovvero la distinzione fra Resistenza e lotta partigiana, dove l’esperienza partigiana viene analizzata sottolineandone l’originalità, sia rispetto all’antifascismo precedente l’8 settembre 1943, sia rispetto alla retorica resistenziale successiva al 1945. Significativo in tal senso che il termine Resistenza non fosse utilizzato dai partigiani, quanto dagli Alleati, così come la celebre “Bella ciao” non fosse cantata dai partigiani, conoscendo un successo postumo alla Liberazione.
I colori della Resistenza. Romitelli distingue tre mitologie resistenziali: una “nera”, che vede la Resistenza come tradimento ed i partigiani come disertori delinquenti; una “tricolore”, che presuppone una continuità fra l’antifascismo degli anni ’20, i partigiani e le attuali istituzioni repubblicane; una “rossa”, che inserisce l’esperienza partigiana nel movimento storico di emancipazione delle classi subalterne. In queste mitologie “si finisce sempre per appiattire la loro [dei partigiani] esperienza su una storia precedente, su un passato che fa torto a ciò che quell’esperienza è effettivamente stata nel proprio presente, con il suo linguaggio, le sue azioni e i suoi modi di organizzarsi.” (p.28)
Politica partigiana e politica partitica. Emerge dunque una netta differenziazione fra una politica partigiana, che sorge dal “buco nero” dell’8 settembre, dal bilancio critico dell’esaurirsi, per mancanza di adeguati livelli organizzativi e strategici, degli straordinari episodi di lotta antifascista che si susseguono nel 1943 (gli scioperi del marzo, Cefalonia, Porta S. Paolo, le quattro giornate di Napoli) tutta interna alle situazioni, ai territori ed alle popolazioni da cui sorse, ed una politica partitica, sospesa fra la nostalgia del passato antifascista e la prefigurazione del futuro eterodeterminato dalle potenze vincitrici. Queste due politiche si confrontarono anche aspramente all’interno dei CLN, dove però, dopo la “svolta di Salerno”, nella primavera del 1944, l’autonomia dell’iniziativa politica partigiana perse sempre più spazio, fino a non averne alcuno. Pure, le bande partigiane furono, oltre che il punto di riferimento per ogni azione antifascista, anche l’unico alveo in cui i partiti antifascisti riacquistarono credibilità, ma soprattutto, a dispetto della retorica che vuole i partigiani “martiri” volti al “sacrificio”, sperimentarono “la felicità di soggetti che sono riusciti a pensare e dirigere le loro passioni, non restandovi assoggettati, fino a creare un momento politico unico, dal quale resta sempre da imparare.” (p.39)
Un bilancio critico. Gran parte di La felicità dei partigiani, è dedicata al confronto fra opere letterarie e storiche che vertono su questa esperienza, il confronto critico fra la memorialistica di Levi, Fenoglio e Meneghello, offre spunti di riflessione non meno profondi della comparazione di classici della storiografia sul tema, come le opere di Battaglia, Pavone o Bocca.
Suggestioni della memoria. Romitelli, sulla traccia del libro di Sergio Luzzatto, Partigia. Una storia della Resistenza (Mondadori, 2013) analizza l’esperienza partigiana di Primo Levi e la sua intenzione di “normalizzare e umanizzare la figura dei partigiani mostrando le loro debolezze e i loro conflitti interiori, simili a quelli di chiunque in qualunque situazione storica ed esistenziale.” (p.60) Da una prospettiva antitetica si muove Fenoglio, per lui “partigiano, come poeta, è parola assoluta, rigettante ogni gradualità” (Il partigiano Johnny). Qui Romitelli trova una perfetta simbolizzazione dell’”aspetto poietico, creativo, inventivo dell’esperienza partigiana” (p. 57). Ancor più nell’opera di Luigi Meneghello I piccoli maestri (Feltrinelli, 1964) emerge quella “pura gioia” del sentirsi “veramente liberi” nel prender parte, indipendentemente dai partiti, al rinnovamento antifascista dell’Italia (p.69). Nella politica partigiana “non c’era cosa che non avesse rilevanza immediatamente collettiva, che non riguardasse cioè l’arcipelago delle diverse bande, il senso da ridare all’Italia, le prossimità e le distanze da tenere con gli alleati, le ostilità da esercitare contro nemici e collaborazionisti.” (p.61)
Dall’ideologia alla morale. Prendendo in esame alcune fra le più importanti opere storiche sulla Resistenza, Romitelli nota come il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica corrisponda ad un trascolorare dall’antifascismo all’antitotalitarismo, da una impostazione ideologica, come nella Storia della Resistenza italiana, di Roberto Battaglia (Einaudi, 1964) comandante partigiano e comunista, ad una impostazione morale, come in Una guerra civile, di Claudio Pavone (Bollati-Boringhieri, 1991). Tertium datur in questo schema dicotomico, Storia dell’Italia partigiana di Giorgio Bocca (Laterza, 1966) si caratterizza per la netta affermazione di una originale politica partigiana.
Costi e benefici della “svolta”. L’analisi critica del classico studio di Battaglia, ruota attorno alla “svolta di Salerno”, che Togliatti impose al suo rientro da Mosca nell’aprile del 1944, consistente nell’appoggio al governo Badoglio e gravida di implicazioni che impediranno quella radicale defascistizzazione dello stato per cui i partigiani lottavano. Romitelli non manca di riconoscere i fondamenti strategici della svolta, ponderando “costi e benefici della strategia di Togliatti” (p.89) che però, in ultima analisi, soffocò le aspirazioni di indipendenza ed autodeterminazione delle bande partigiane, consegnando il paese “in balia di giochi diplomatici decisi altrove.” (p.92) L’attenzione al contesto internazionale in cui maturò la svolta, consente a Romitelli di valutare approfonditamente alcune azioni promosse dai partigiani comunisti nei giorni precedenti (scioperi del marzo ’44, attentato di via Rasella) sia la successiva “restaurazione” dei partiti antifascisti.
Moralità della Resistenza. Se l’opera di Battaglia è fondata sull’ideologia del PCI togliattiano, quella di Pavone si basa su una “storiografia morale, comportamentale” (p. 108) che, pur fra i molti meriti che può vantare, porta al riconoscimento della dignità morale del fascismo repubblichino. Se da un punto di vista morale, la RSI aveva un carattere “endogeno”, fondato cioè sulla volontà di restaurazione dei fascisti rimasti fedeli al Duce, da un punto di vista politico non era altro che uno stato fantoccio che, per ammissione dello stesso Pavone, non sarebbe potuto esistere senza l’occupazione tedesca. Il sorprendente successo di Una guerra civile, viene contestualizzato da Romitelli nella crisi della Prima Repubblica, la fine dell’ideologia partitica, l’imporsi della “questione morale” e nella necessità di “unanimità morale” su cui fondare la Seconda Repubblica, in assenza ormai di contrapposte visioni del mondo che distinguessero gli schieramenti parlamentari.
Militarismo ribelle. Per Giorgio Bocca, la guerra partigiana fu appieno una guerra politica che riuscì a rigenerare lo Stato, superando l’originaria separazione fra esercito e popolo, ma la Resistenza fu anche una “rivoluzione incompiuta” (p.124) a causa della mancata defascistizzazione dello Stato. Centrale, in questa ricostruzione, per Romitelli è una “etica del soldato”, un “approccio militare”, che portano Bocca prima ad avvallare le strategie degli Alleati, anche quando queste erano mirate a soffocare ogni possibilità di reale indipendenza politica dell’Italia partigiana, e poi, nell’Introduzione all’edizione Mondadori del 1995, al riconoscimento della “dignità morale” dei repubblichini.
Politica partigiana. Qual’è dunque la lezione che si può trarre dall’esperienza partigiana? Romitelli affronta la questione a partire da una opportuna e salutare critica radicale alla Teoria del partigiano del “giurista del Reich” Carl Scmitt, libello uscito nel 1963 come “integrazione al concetto del politico” e che tanto seguito ha riscosso anche a sinistra, da Tronti a Curcio, da Agamben a Quadrelli.
Autonomia del politico vs. politica partigiana. Se le “banali generalizzazioni anticomuniste, congrue con l’impegno nel nazionalsocialismo assunto a suo tempo da Schmitt” (p.141) hanno tanta presa, è perché in esse la guerra irregolare del partigiano necessita ineluttabilmente di un sostegno da parte di una organizzazione regolare, non ha quella autonomia che è riservata al politico. In questo modo, l’ordine eurocentrico fondato sulla teologia (di cui i concetti politici sono la secolarizzazione) ed il diritto, viene tolemaicamente confermato. Romitelli propone invece “un approccio sperimentale di derivazione galileiana e materialista” (p. 148) in base al quale le bande partigiane non appaiono più come mera espressione della “inimicizia assoluta”.
Siamo banditi, non siamo soldati. Il fenomeno storico delle bande partigiane viene definito con precisione, a partire dal “censimento” effettuato da Bocca: a fine settembre 1943 i partigiani sono 1500 (di cui un terzo in Piemonte, un terzo nelle regioni centro-meridionali, un terzo nelle restanti regioni del nord) il 25 aprile 1945 all’insurrezione partecipano al massimo 300.000 armati (p.125). Il “nuovo antifascismo”, appartenente alla generazione nata sotto il fascismo, priva di una cultura politica, ha saputo connettersi al “vecchio antifascismo” degli esuli, dei prigionieri e dei confinati, ha saputo produrre lo strumento politico adeguato alla situazione: la banda. All’”idea della banda” (Meneghello) va stretta anche la definizione di Quazza: “microcosmo di democrazia diretta” (p.149) infatti, la categoria di “democrazia” rimanda a quella di “stato”, a “regole” che non paiono consone all’azione delle bande partigiane, che si caratterizzano altresì per “la loro capacità di mettere alla prova se stesse, i loro più o meno chiari ideali politici e le loro pratiche di guerriglia, in rapporto al contesto sociale, sia a quello direttamente incontrato, sia a quello più vasto rappresentato dall’Italia intera. Sarebbe grazie a questa capacità di sperimentarsi direttamente in rapporto alle popolazioni interpellate che questa politica, pur durata solo una ventina di mesi e condotta da un’esigua minoranza, sarebbe riuscita a unire e dividere gli italiani in un modo inedito, con effetti duraturi e idealmente senza tempo.” (p.151)
Il feticcio della legalità. Romitelli non manca di fare i conti con l’ideologia correntemente imposta dalle istituzioni statali ed ecclesiastiche che “allude ad uno spirito superiore proveniente dalle leggi” (p.162) dal cui punto di vista, l’attualizzazione dell’esperienza delle bande partigiane risulta quasi una blasfemia. Se però si guarda agli effetti pratici che tale imperante ideologia ha ottenuto in 70 anni nella tanto sbandierata “lotta alla mafia”, si possono osservare solo inconfessabili trattative, quando non dirette complicità, che disvelano il suo carattere mistificatorio.
Classe e partito. Si tratta ora di fare i conti con gli aspetti di La felicità dei partigiani che risultano non poco indigesti da un punto di vista rigorosamente marxista, riconducibili al rifiuto sistematico di un approccio classista. E’ un tema su cui Romitelli riflette da anni (cfr. Sulle origini e la fine della rivoluzione, CLUEB, 1996) ma qui conviene riferirsi unicamente al testo in esame.
Modi della politica. Schematicamente, vengono rintracciati tre modi di “fare politica”: uno “legalitario”, cioè vertente a far promulgare delle leggi, uno “giacobino”, che mira a danneggiare il nemico, ed uno “socialista e comunista”, il cui obbiettivo strategico è pedagogico, mira cioè a far acquisire al proletariato la propria coscienza di classe, intesa come “destino storico” (pp.168 e sgg.). Disorienta veder rubricata all’interno del giacobinismo la lotta sindacale ed il comunismo (che abitualmente vien rimandato alla celebre definizione leninista di “giacobinismo rivoluzionario”) ridotto a pedagogia scolastica d’apparato. Un’altra perplessità può sorgere quando Romitelli parla di partiti o di politica partitica, riferendosi pressoché unicamente ai partiti di massa, segnatamente del secondo dopoguerra, oggi sostituiti da “agenzie di comunicazione per occupare seggi” (p.157) ma i partiti di massa, se pure sono stati una realtà dal significato storico imprescindibile, non esauriscono le varie forme-partito che nella storia contemporanea si sono concretizzate o sono state teorizzate.
Gruppi ideologici e organizzazioni di classe. Le cose risultano più chiare in riferimento alla storiografia: per Romitelli, la storiografia resistenziale “rossa”, interpretando la storia come storia delle lotte di classe, ha generato, fra le altre, la confusione che fecero i gruppi della sinistra extraparlamentare ed i vari “nuclei armati” nati dopo il ’68, fra i tempi di guerra in cui si formarono le bande partigiane ed i tempi di pace in cui si trovavano, ficcandosi nel vicolo cieco del terrorismo (p.42). Se è comprensibile che Romitelli voglia evitare pericolosi fraintendimenti della sua proposta di “organizzarsi in bande”, pure certe banalizzazioni non sono accettabili. Il ciclo di lotte degli anni ’70 ha generato, accanto ad una galassia di effimeri gruppi ideologici di vario orientamento, una vitale massa di esperienze di organizzazione di classe, nei posti di lavoro e sul territorio, che hanno saputo resistere ad una fase controrivoluzionaria devastante negli anni ’80-’90 e che oggi, fra mille limiti e contraddizioni, continuano a sperimentare forme di lotta autonome: dai sindacati di base alle occupazioni di case, dai centri sociali alle lotte per la difesa dei territori (prima fra tutte la lotta contro la TAV). In queste situazioni, la memoria partigiana è viva, l’antifascismo militante una pratica quotidiana.
Dall’astratto al concreto. Se, invece che ad un astratto ambito “tra la gente più vessata” (p.175) “dove il sociale più fatica e soffre” (p.165), Romitelli vorrà guardare a quelle situazioni dove la lotta di classe è realtà concreta, nelle forme e con i nuovi soggetti che la praticano, potrà uscire dal pur necessario momento riflessivo “affilando più che mai l’arma della critica” (p.161) per trovare, nella prassi trasformatrice, nella lotta per bande, la soluzione al paradosso di Meneghello, che più volte torna nel libro: “perché c’è la guerra per bande, la pace per bande, no” (p.72).
Chi invece alle lotte di classe partecipa e cerca di svilupparle, può trovare in La felicità dei partigiani e la nostra numerosi spunti di riflessione su una questione cruciale come quella dell’organizzazione, riflessione indispensabile per poter uscire da una fase di resistenza ed iniziare a sperimentare una iniziativa felicemente autonoma.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa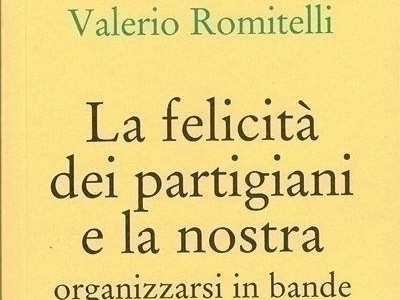





gian andrea franchi
Vorrei segnalare che nel numero di ALFABETA 2 dedicato ALLA RESISTENZA, uscito on line in Maggio, insieme al libro di Romitelli, La felicità dei partigiani, è stato recensito da Daniele Balicco il libro di Maria Antonietta Moro, Tutte le anime del mio corpo, Jacobelli 2014. Tra i due libri ci sono grandi differenze e grandi affinità. Il libro di Moro, innanzitutto, è un diario scritto fra l’inverno e la primavera del 1945 da una giovane donna che era allora partigiana garibaldina nella pianura pordenonese ma che prima era stata, benché italiana, partigiana nelle formazioni slovene del goriziano fin dal 1942, svolgendo in entrambi i casi importanti incarichi di informazione e organizzazione. Questa è la differenza. L’affinità sta nel fatto che questo diario, trovato in un cassetto solo dopo la morte dell’autrice, racconta un processo di rapidissima formazione personale, che porterà a una rischiosa scelta di vita da parte di una giovane di campagna (del Friuli occidentale), spinta da quell’esigenza di riscatto personale e insieme necessariamente collettivo di cui Romitelli parla nel suo libro a proposito della formazione della banda partigiana. Tale esigenza troverà per Maria Antonietta Moro il suo luogo naturale in un gruppo di giovani infermiere slovene del Convitto-scuola per infermiere di Gorizia in cui nel 1942 andrà a studiare. Assumerà quindi la decisione di entrare nella resistenza slovena e jugoslava, sfruttando la sua attività di infermiera che la metteva in grado sia di salvare vite di partigiani catturati e feriti, sia di raccogliere informazioni preziose da tedeschi e fascisti ricoverati in ospedali, usando anche, se necessario, farmaci adeguati. In seguito verrà mandata nella resistenza italiana. Ma quello che qui mi importa sottolineare, è il gesto etico-politico di una giovane di campagna, di formazione cattolica, che non esita a mettere in gioco la sua vita, rischiando tortura e morte, in nome di una solidarietà costitutiva di un sociale nei fatti alternativo a quello dominante, nazifascista da una parte, complice per viltà o indifferenza dall’altra.