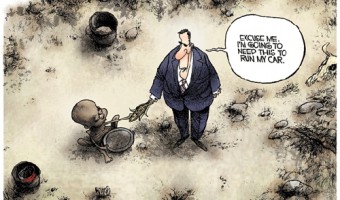Il “mistero” della rendita è uno dei meno indagati dagli economisti che si dicono marxisti. Nel migliore dei casi la confondono con l’interesse, fetazione ultima (V sezione del Terzo Libro de Il Capitale) del profitto. Nella vulgata quotidiana viene identificata tout court con il frutto marcio della “speculazione finanziaria”, quindi con le circonvoluzioni immaginifiche del “capitale fittizio” (che è invece sempre una “forma trasformata” del profitto).
Eppure Marx aveva avvertito chiaramente che questa “somiglianza” tra interesse e profitto (sociologicamente identificati come quote di valore incamerate da gente “che non lavora”, nemmeno come imprenditore capitalistico o manager) andava superata, riconoscendone la natura diversa. Completamente diversa. L’interesse è infatti visto da Marx come “remunerazione del capitale da prestito”, mentre la rendita è la remunerazione del proprietario terriero (e di quello che c’è sotto la superficie). La diversa fuzione economica globale è chiara, ma le rispettive apparenze inducono molti identificarli.
Anche nella crisi sistemica le due categorie agiscono in modo diverso, in qualche caso addirittura opposto. Il “capitale fittizio” (da prestito o da “assicurazione sul rischio”, come i “prodotti derivati”) si gonfia fino a raggiungere quantitativi nominali inconcepibili (solo il “mercato dei derivati” viene stimato in 10-12 volte il Pil mondiale annuo), mentre la rendita viene a sottrarre una quota crescente del nuovo valore. Gli esempi non mancano, ma non è neppure la “bolla immobiliare” la sua espressione più chiara. Le “materie prime” di origine mineraria (metalli, idrocarburi, carbone, ecc) ne sono una manifestazione eclatante, ma ben poco indagata dai “marxisti” novecenteschi.
La “colpa” di Marx, probabilmente, è di aver posto l’analisi della rendita alla fine de Il Capitale, nella VI sezione, cui gli studiosi attenti quasi soltanto al conflitto capitale/lavoro arrivano stanchi e distratti. Proprio lì, invece, la rendita si erge come forma precapitalista trasformata in elemento essenziale del capitale (permette la formazione di un prezzo per un elemento naturale che nessuno ha prodotto e che non può essere incrementato: la terra). Tanto “estranea” alla dialettica fin lì analizzata da Marx da presentarsi come il reddito di una “terza classe sociale” – il rentier – che si affianca e compete con le altre due (borghesia e proletariato) nella distribuzione conflittuale del valore prodotto. Tanto estranea, dunque, da “disturbare” quanto fin lì metabolizzato dal lettore (dallo studioso) e dall’attivista politico. Ma, ahinoi, ineliminabile. Nonostante l’auspicio dei socialisti di ogni secolo e infine dai keynesiani “di sinistra”, sempre diretto all'”eutanasia del rentier”.
*****
Profitto versus rendita
Alcune considerazioni intorno ai concetti di profitto, rendita e lavoro produttivo nel Capitalismo 2.0
Sebbene muovendo da un punto di vista schiettamente apologetico, Giulio Sapelli mostra di aver capito l’essenza dell’economia basata sul profitto più di quanto si è soliti apprezzare, ad esempio, nei teorici del cosiddetto Capitalismo cognitivo. Pochi passi sono sufficienti a dimostrarlo:
«I paesi industrializzati europei hanno un misuratore infallibile della bassa crescita: il progressivo trasferimento di quote ingenti di capitali dal profitto alla rendita, a quella immobiliare e a quella improduttiva pubblica e privata. Quindi la persistenza di alte quote di risparmio è indice di bassa crescita … Ecco un altro dato fondamentale. Laddove si investe, non si investe più nei tradizionali confini. Si pensi alla Germania. Ebbene la Germania ha potentemente delocalizzato la sua industria e ha promosso investimenti in aree strategiche del nuovo mondo industrializzato … Solo il profitto capitalistico rivoluziona la società, costringe gli operatori all’innovazione e alla benefica e darwiniana lotta per l’esistenza, che rinvigorisce le menti con la progettazione strategica … La dialettica rendita-profitto deve tornare a essere un elemento di misurazione della salute dell’economia e della società. Se la rendita prevale sul profitto la società si ammala, le forze vive dello sviluppo declinano a vantaggio dell’interesse parassitario … I classici da rileggere per meditare come sia difficile vivere in un mondo senza industria manifatturiera, sono quelli che vedevano nell’industria, nel profitto e nella nascita il sale della crescita e della civilizzazione» [1].
Qui si esprime senza infingimenti la lotta furibonda fra i diversi capitali (industriali, commerciali, finanziari) per la spartizione del bottino.
L’espansione della rendita e del parassitismo sociale, pubblico e privato, non rappresentano il «farsi rendita del profitto» [2], quanto piuttosto un attacco al profitto industriale (espressione diretta del plusvalore primario) e, quindi, all’accumulazione capitalistica, la cui base relativamente deve declinare a causa di una insufficiente quota di profitti da capitalizzare nel processo produttivo. Se le condizioni generali dell’economia restano sfavorevoli all’investimento produttivo, cospicue masse di capitali saranno sempre attratte dalla rendita, dalla speculazione e dal parassitismo genericamente inteso.
«Dal profitto alla rendita: non si è capito proprio nulla». Impossibile, per chi scrive, non condividere queste parole. Mi permetto di citarmi:
«Il fatto che ormai da oltre un secolo il centro di comando delle attività economiche sia radicato nella sfera della finanza mondiale non ha mutato il meccanismo della creazione della ricchezza sociale nella peculiare forma capitalistica, ma lo ha piuttosto enormemente potenziato ed espanso, creando una gigantesca base sulla quale è possibile il più ardito e spericolato gioco d’azzardo. Il profitto non si fa rendita, ma piuttosto in certe situazioni la permanente “dialettica” tra l’uno e l’altra si radicalizza … “La rendita non è mai una nuova creazione di reddito, ma sempre una parte del reddito già creato”: Marx accolse questa definizione ricardiana di rendita come decurtazione di parte del profitto industriale e, dunque, come poggiante in ultima analisi sul plusvalore estorto al lavoro sociale complessivo”» [3].
La teoria del profitto e della rendita di Toni Negri, Carlo Vercellone e degli altri “cognitivisti”, rovescia completamente l’analisi marxiana delle tendenze immanenti allo sviluppo capitalistico. Infatti, mentre i primi teorizzano il farsi rendita del profitto, che implica il superamento del Capitalismo fondato sull’estorsione del plusvalore nella sfera della produzione delle merci (dal «Capitalismo fordista» al «Capitalismo cognitivo»), Marx dava conto di un processo storico-sociale che vedeva il farsi profitto della rendita, ossia il prevalere del rapporto sociale capitalistico anche nell’ultima enclave dell’economia precapitalistica, nell’agricoltura, assoggettata progressivamente al moderno capitale (personificato nel fittavolo borghese). Il capitale, sviluppando «le scienze naturali e l’agronomia», non rese solo più fertile il terreno, aumentandone la composizione organica (il terreno da risorsa naturale diventa capitale fisso, «terre-capital», ossia «strumento di produzione»), ma rende soprattutto più fertile, per così dire, il lavoro di chi lo coltiva (il salariato agricolo), accrescendone la produttività. Naturalmente negli scritti marxiani non si riscontra alcuna hegeliana identità assoluta tra profitto e rendita, nella misura in cui questi due redditi rimandano a due differenti classi sociali interessate alla spartizione dello stesso plusvalore: quello generato dal lavoro salariato industriale e agricolo – qui la distinzione è meramente formale.
Quando la scienza (o, in una sua accezione più larga e pregnante, General Intellect, per usare una terminologia di gran moda presso i “marxisti cognitivisti”, i quali per l’essenziale non hanno compreso la dialettica reale che le dà sostanza); quando la scienza, dicevo, diventa la madre di tutte le forze produttive si ha il passaggio «dalla sottomissione formale del lavoro al capitale», la quale lasciava al lavoratore un residuo di autonomia pratica (tecnica) e intellettuale, alla «sottomissione reale del lavoro al capitale», la quale segna il completo asservimento del salariato al Moloch del processo di valorizzazione diretto scientificamente. Il Capitalismo 2.0 non segna il passaggio dalla sussunzione reale al General Intellect («La produzione e la distribuzione di conoscenze e informazioni è divenuta la fonte principale di creazione di valore», scriveva Carlo Formenti nel 2009), ma, semmai, il passaggio alla sussunzione totalitaria della società (natura compresa) al Capitale come rapporto sociale di dominio e di sfruttamento – per questo il più delle volte uso la c maiuscola.
La società-fabbrica come metafora può anche avere una sua pregnanza teorica e politica, ma solo se non oblitera la reale dialettica immanente al processo di creazione della ricchezza sociale nella sua attuale connotazione sociale, processo che non realizza l’hegeliana notte che fa nere (ossia produttive di plusvalore) tutte le vacche. La creazione del plusvalore nell’inferno industriale (Inferno 2.0, se la cosa può sembrare meno arcaica) segna ancora il limite storico del Capitalismo, che il Capitale cerca di superare in ogni modo. Senza riuscirvi, come dimostra anche l’attuale crisi economica.
La conoscenza nell’attuale configurazione sociale non è un «bene comune» di cui il Capitale si appropria gratuitamente e illegittimamente, saccheggiando un mondo (il cosiddetto Comune) che per molti aspetti già non gli appartiene più, ma è all’opposto il prodotto più tipico del Capitalismo giunto nella sua più alta fase di sviluppo, che corrisponde appunto allo sfruttamento capillare, invasivo, violento e, soprattutto, scientifico di tutto ciò che sta tra terra e cielo. Il General Intellect è in radice l’intelligenza del Capitale. È vero che, come scrive Marx, «Nella sua nuova forma il capitale s’incorpora gratis il progresso sociale compiuto mentre agiva la sua vecchia forma», ma esso può farlo perché «Scienza e tecnica costituiscono una potenza dell’espansione del capitale»(Il Capitale, I).
Lo sviluppo capitalistico promuove sempre di nuovo l’espansione del «cervello sociale» (scuola, università, agenzie formative, pubbliche e private, di vario genere, relazioni sociali mediate tecnologicamente e via di seguito), e questo a sua volta accresce direttamente e indirettamente la potenza sociale del Capitale, il quale sa come mettere a profitto lo sviluppo complessivo della sua società. Solo il rovesciamento rivoluzionario del Dominio può rendere possibile il pieno dispiegamento delle tendenze emancipatrici di cui è gravida, e non da oggi, la società borghese. Per Negri «Tutto, essendo prodotto da tutti, appartiene a tutti». Non c’è dubbio: nel Comunismo, però, non certo nel Comune dei “cognitivisti”.
Adesso ritorniamo, anzi: precipitiamo nel mondo perduto dell’industria.
«Industria: sì, pronunciamo coraggiosamente la parola», scrive Sapelli nel suo elogio del profitto industriale, prendendo un po’ in giro quegli economisti che fino al 2007 teorizzavano e magnificavano la creazione del denaro a mezzo di denaro. Tanto per lui quanto per chi scrive l’industria rappresenta il cuore pulsante della Civiltà borghese; ma mentre per Sapelli questa Civiltà parla il linguaggio del progresso (economico, tecnologico, scientifico, culturale, spirituale, antropologico), sebbene al netto delle inevitabili contraddizioni e magagne, peraltro sempre superabili ed emendabili; per me la società capitalistica parla invece il duro e maligno linguaggio del Dominio e dello sfruttamento. Proprio perché la produzione industriale è il cuore del processo sociale di produzione del plusvalore, base per ogni sorta di profitto (industriale, commerciale, finanziario) e per ogni genere di rendita; per questo il luogo della creazione immediata del plusvalore è per i salariati il luogo maledetto per eccellenza.
Una piccola digressione. Nel corso dell’illustrazione della Nota di variazione al DEF per il 2012-2015 al Senato della Repubblica (5 ottobre 2012), il Sottosegretario all’economia Gianfranco Polillo dichiarò che «come scrivevano economisti importanti, da Marx a Keynes, se non riparte il meccanismo dell’accumulazione l’economia rimane bloccata». Secondo il Sottosegretario ciò che blocca l’accumulazione è innanzitutto il ristretto margine (di profitto) delle imprese, il cui margine operativo lordo medio si aggira intorno al 33% sul valore aggiunto, un livello troppo basso soprattutto alla luce della fiscalità italiana. Più che la diminuzione dei consumi privati (quasi -3%), deve destare preoccupazione soprattutto il crollo degli investimenti, che ha fatto registrare quest’anno un inquietante -10%. Se il margine (di profitto) non cresce (oggi è al 7-8%), disse Polillo, gli investimenti ristagnano, impedendo la ripresa dell’accumulazione: come uscire da questo vero e proprio circolo vizioso?
Polillo individuò ovviamente nella scarsa produttività delle imprese italiane il problema centrale da risolvere, se si vuole dare una rapida risposta all’angosciante domanda di cui sopra. E la scarsa produttività chiama in causa direttamente il famigerato cuneo fiscale, ossia la differenza fra costo del lavoro, altissimo in Italia, e salario diretto, che è invece inferiore alla media dei paesi europei. Questa forbice tra quanto il lavoro costa all’impresa e quanto intascano realmente i lavoratori ha nel compromesso tra grande impresa, sindacato parastatale (trimurti sindacale) e Stato forse la sua spiegazione più importante.
Ecco cosa pensa Sapelli, da buon liberale, dello Stato e del sindacato italiano: «Meno lo Stato interviene e meglio è. Bisogna detassarle le imprese, e bisognerebbe fare una forte politica sindacale per aumentare i salari, ma questo non spetta allo Stato, spetta alle organizzazioni sindacali che devono finalmente ritornare ad essere dei sindacati e devono ricominciare a difendere i lavoratori» [4]. Che un liberale scavalchi “a sinistra” il sindacato collaborazionista, ciò può sorprendere solo chi non conosce l’autentico pensiero liberale, il quale non nega affatto l’esistenza del conflitto sociale, e anzi vi vede un contributo al rinnovamento sociale, un male che può generare un bene, secondo la nota astuzia del Dominio. Salvo riconoscere al Leviatano, che del Dominio è il più feroce cane da guardia, la piena legittimità di usare il bastone, il fucile e il carcere tutte le volte che questo conflitto supera i bronzei limiti della Civiltà borghese.
A proposito di Leviatano! Ecco cosa scrive Loretta Napoleoni, “economista di riferimento” (a quanto si dice) del movimento grillino, intorno all’Economia canaglia: «La genesi dello statonazione è la storia del contratto sociale attraverso il quale gli individui creano le nazioni e ne preservano all’interno l’ordine sociale. I presupposti di tale contratto dipendono dalla volontà dei cittadini di cedere alcuni diritti al governo in cambio della garanzia di pace e stabilità. La legittimità dei politici nasce quindi dalla volontà del popolo di ratificare il contratto sociale. Alla radice del contratto sociale c’è il caos dello stato di natura, sinonimo di anarchia. In tale stato non esiste la nozione di diritto … L’economa canaglia, caotica, anarchica e illegale, ricorda lo stato di natura» [5]. Qui la concezione pattizia che fonda sul piano politico-ideologico il potere delle classi dominanti non poteva essere esplicitata in termini più chiari e semplici, e forse con intenti pedagogici.
Alla radice del cosiddetto contratto sociale ovviamente non c’è «il caos dello stato di natura», ma precisi rapporti sociali di dominio e di sfruttamento, per tutelare i quali i dominanti si sono legittimamente impossessati del monopolio della violenza, imposto ai dominati col crisma della difesa del «bene comune» e della comune Civiltà. La genesi del moderno Stato-Nazione è la storia della moderna «società civile», spinta dal processo sociale sul terreno delle grandi aspirazioni storiche, ben oltre i vecchi limiti feudali e comunali. Per Hegel: «La società civile è il campo di battaglia dell’interesse privato individuale di tutti contro tutti»; e Marx chiosava da par suo: «È notevole la definizione della società civile come bellum omnium contra omnes». La società civile, signora Napoleoni, non il Capitalismo nella sua variante “degenerata”: «neo-liberale», «selvaggia», «illegale» ecc. Nel Capitalismo, ossia nella società più selvaggia e violenta che sia mai comparsa sulla faccia della Terra, il Diritto e la Politica devono necessariamente assecondare i processi sociali che disegnano sempre di nuovo il territorio della «società civile», ossia il luogo hobbesiano degli interessi materiali. Canaglia è l’economia capitalistica tout court, dagli Stati Uniti alla Cina, dalla Russia al Brasile, dalla Svezia al Sudafrica.
Naturalmente la Napoleoni non è la sola scienziata sociale che individua nella ripresa d’iniziativa economica del Leviatano il punto di svolta che può allontanarci dall’«economia canaglia». Ad esempio, Giorgio Ruffolo e S. Sylos Labini individuano, sulla scia di Hobsbawn e degli altri teorici della «terza via» (oltre il «socialismo» e oltre il Capitalismo liberista: che straordinaria originalità!) nel Capitalismo di Stato, o quantomeno nell’«economia mista che ci vide all’avanguardia fino agli anni Settanta», la strada da imboccare per uscire dalle secche della crisi sistemica. Ai due scienziati piace particolarmente il modello nazista di keynesismo. Ecco le prove: «Una reazione significativa per contrastare le tendenze involutive del capitalismo durante una crisi fu quella sperimentata in Germania agli inizi degli anni Trenta sotto l’impulso del ministro dell’Economia di Adolf Hitler, Hjalmar Schacht. Per sottrarre la Germania alla dittatura dei mercati finanziari che la stava trascinando a fondo, il regime nazista attivò delle misure eccezionali per riportare la sovranità monetaria sotto il controllo politico. Si realizzò così un mutamento fondamentale della strategia economica, che permise allo Stato di riprendere in mano le leve del finanziamento dello sviluppo sostituendo la propria autorità a quella del mercato. Naturalmente non c’è bisogno di Hitler»[6]. Naturalmente.
Come lo stesso Paul Krugman riconosce, fino a invocare “paradossalmente” l’invasione degli Alieni per spezzare la cortina di ferro dei rigoristi in materia di spesa pubblica, solo la corsa al riarmo e la guerra mondiale permisero agli Stati Uniti e agli altri paesi occidentali di uscire dalla Grande Depressione. Ecco perché quando ascolto chi propone una politica keynesiana «di ampio respiro» non posso fare a meno di mettermi il metaforico – per adesso! – elmetto sulla quasi pelata. D’altra parte, quel tipo di interventismo statale può avere successo solo se applicato in maniera massiccia, mentre il suo uso omeopatico è del tutto inefficace. Ma a quel punto la catastrofe sociale sarebbe imminente, e l’elmetto passerebbe, per dir così, dalla teoria alla prassi.
È anche opportuno ricordare come Keynes non pose mai la spesa pubblica nei termini dell’ammortizzatore sociale, bensì in quelli genuinamente capitalistici incentrati sull’attivazione, «artificialmente indotta» da una «domanda supplementare» (resa possibile appunto dallo Stato), di un capitale che il mercato non riusciva a mettere in moto “spontaneamente”. Più che della disoccupazione dei lavoratori, egli giustamente si preoccupò della disoccupazione del capitale, per superare la quale bisognava lasciarsi alle spalle vecchie remore di stampo democratico-liberale. «Ciò che il seguente libro intende illustrare, si adatta più facilmente alle condizioni di uno stato totalitario, piuttosto che a condizioni di libera concorrenza e di ampie misure di laissez-faire» [7]. Non a caso, come ricorda la storica dell’economia Amity Shlaes ne L’uomo dimenticato. Una nuova storia della Grande Depressione, i politici e gli intellettuali del New Deal guardavano con estremo interesse chi alla Russia di Stalin, chi alla Germania di Hitler. Molti guardavano con simpatia a entrambi i regimi, non disdegnando nemmeno di studiare il promettente «caso italiano» [8].
Quanto poi allo Stato che avrebbe riacquistato la perduta sovranità finanziaria e avrebbe «ripreso in mano le leve del finanziamento dello sviluppo sostituendo la propria autorità a quella del mercato», ebbene si tratta di una mitologia coltivata da chi non riesce a vedere ciò che si celò allora dietro l’apparenza, ossia il pieno asservimento del Leviatano agli interessi strategici del «mercato», cioè dei peculiari rapporti sociali capitalistici. Per questo Adorno poté scrivere nel 1944 i significativi passi che seguono: «La nemesi immanente di Hitler è questa: che egli, il boia della società liberale, era troppo “liberale” per capire come altrove, sotto il velo del liberismo, si costruisse l’irresistibile supremazia del potenziale industriale. Hitler, che scrutò come nessun altro borghese quel che c’è di falso nel liberalismo, non comprese fino in fondo la potenza che gli sta dietro, cioè la tendenza sociale di cui egli stesso non era che il tamburino … La stoltezza di Hitler è stata un’astuzia della ragione» [9]. Della ragione dominante, ossia del Dominio sociale nell’epoca dello sfruttamento scientifico di uomini e cose. Il massimo della razionalità posta al servizio di Potenze sociali irrazionali, cioè a dire ostili all’uomo, che pure le produce sempre dinuovo, giorno dopo giorno. È la tragedia dei nostri giorni.
Porre l’alternativa tra Stato (buono) e Mercato (cattivo) non è solo espressione di una concezione ultrareazionaria e disumana del mondo, ma è anche indice di un’indigenza dottrinaria davvero abissale.
Ma riprendiamo il filo del discorso. La voracità fiscale del Leviatano italiano per un verso ha distrutto molte fonti di profitto (il capitale investito in attività produttive) e ridotto i «margini» delle imprese; e per altro verso ha azzoppato la capacità competitiva di queste ultime, direttamente, ossia drenando risorse private altrimenti disponibili alla ricerca e allo sviluppo, e indirettamente, cioè non allocando nel privato capitali pubblici a sostegno delle iniziative imprenditoriali, a partire proprio dalla fondamentale politica aziendale volta all’innovazione tecnologica, a monte (strumenti produttivi e organizzazione del lavoro) e a valle (nuovi prodotti da collocare sul mercato).
L’obesità del bilancio sovrano ci parla della molta spesa pubblica improduttiva che si è accumulata nel tempo, e che incidere col bisturi, come in effetti si dovrebbe fare, risulta adesso estremamente difficile, perché il parassitismo sociale nel Bel Paese è quanto mai diffuso, radicato e politicamente protetto, avendo avuto esso soprattutto la funzione di ammortizzatore sociale per le sue aree economicamente depresse, nonché di greppia elettorale a disposizione dei partiti – dalla DC al PCI, dal PDL al PD. La tanto strombazzata spending review per adesso rimane un “libro dei sogni”, un vorrei ma non posso, nonostante sia l’Europa a chiedercelo, secondo l’insopportabile mantra ripetuto a destra e a manca.
Se non riparte l’accumulazione non c’è bacchetta magica che possa risollevare le sorti dell’italica economia: questo, in estrema e brutale sintesi, il concetto centrale difeso quel giorno al Senato della Repubblica dal Sottosegretario Polillo, che naturalmente condivido, sebbene a partire da una ben diversa prospettiva teorica e politica – compatibile, credo, con il pensiero dell’ubriacone di Treviri, e certamente del tutto estranea al punto di vista di Keynes, che lascio volentieri ai progressisti e ai dirigisti di tutte le tendenze politiche.
Scrive Carlo Vercellone: «Contrariamente al credo neo-liberale, le spese e i servizi sociali del Welfare non possono essere considerati in modo riduttivo come un costo il cui finanziamento dipenderebbe da un prelievo effettuato sulla ricchezza creata dal settore privato (pensato a torto come il solo settore produttivo di ricchezza). Spese e servizi collettivi del Welfare dovrebbero essere invece riconosciuti come i fattori motori di una dinamica di sviluppo fondata sulle produzioni intensive in conoscenza e di un’economia in cui la principale forza produttiva è ormai rappresentata dalla qualità intellettuale della forza lavoro – o come si è soliti dire con un’espressione ambigua dal capitale umano» [10]. A mio modesto avviso non il «credo neo-liberale» ma la prassi capitalistica mondiale mostra, al di là d’ogni ragionevole dubbio, come il Welfare costituisca, dal punto di vista del Capitale sociale, una necessaria distruzione di ricchezza sociale, e come «le spese e i servizi sociali del Welfare» abbiano, in un modo o nell’atro, un rapporto strettissimo con il processo di accumulazione, perché nel Capitalismo nessun pasto è gratuito. Per un Paese come l’Italia la famigerata spending review non è un complotto orchestrato dai soliti neo-liberali contro lo Stato Sociale, feticcio di tutti gli statalisti, compresi quelli in guisa benecomunista, ma una sempre più stringente necessità, perché la produttività generale del Paese non è più in grado si reggere il peso del parassitismo sociale. Questo è il linguaggio del Capitale, non del neo-liberale. Quanto poi al «capitale umano» si tratta di un mostruoso ossimoro che tuttavia la dice lunga sulla condizione dei lavoratori, compresi quelli “cognitivi”, in regime capitalistico.
Ritorniamo a Sapelli. Nemmeno l’economista di Torino si fa mancare il necessario corredo etico, senza il quale oggi non si va da nessuna parte. Egli, infatti, fonda la sua condanna della corruzione politica (vedi Bel Paese) e della degenerazione finanziaria (dai «titoli tossici» agli stock options del top management), che elenca tra i più importanti fattori di crisi, su una concezione etica dell’economia centrata non sul profitto ma sulla «libertà della persona». La crisi iniziata negli Stati Uniti nell’estate del 2007 matura nel seno di un’economia nella quale «Il fine dell’impresa non era più crescere e dare occupati, fare dei bei prodotti, offrire dei buoni servizi alle persone e, per questo fare profitti. Doveva, invece, essere quello del fare profitti tout court». Il profitto dulcis in fundo. Il profitto come remunerazione delle buone azioni e come servizio alla comunità. Certo non sarò io a stigmatizzare la concezione del mondo di Sapelli, tra etica della responsabilità di stampo anglosassone e personalismo cristiano debitore al comunitarismo di Jacques Maritain: il profitto come essenziale motore del Capitalismo, e il lavoro salariato come fondamento dell’economia che sfrutta uomini e cose in vista appunto del massimo profitto, del «profitto tout court», sono tesi che la Scienza Economica deve rifiutare, necessariamente e legittimamente. D’altra parte l’economista torinese attacca le «degenerazioni finanziarie» e la corruzione politica per scongiurare il rischio di «populismi anticapitalistici», mentre chi scrive tifa decisamente per il “populismo” più anticapitalista che un liberale (ma anche uno statalista) possa concepire.
«La crisi del capitalismo sta più, forse, negli uomini che nel sistema», scrive il Nostro. Forse. Nicchio, tentenno… Ci sono poi quelli che sostengono che la crisi «è nel sistema, ma non del sistema», e chiamano in causa i soliti errori di governance. Certo, è sempre colpa della cattiva governance. Assenza di una forte e responsabile governance a tutti i livelli e in tutte le articolazioni del sistema, per un verso; cieca brama di potere materiale e politico, riconducibile alle presunte tare antropologiche che ci porteremmo dietro da millenni, per altro verso: è dentro questa indigente griglia concettuale che dall’epocale crisi del ’29 in poi brancola la Scienza Economica. In realtà la crisi è per il Capitalismo un fatto fisiologico, non è un evento eccezionale. Tutt’altro. Lo sviluppo e la crisi costituiscono a tutti gli effetti il respiro dell’economia fondata sul profitto. La crisi è al contempo espressione delle contraddizioni immanenti al concetto stesso di Capitale, e processo di risanamento, ossia di superamento di queste stesse contraddizioni, in vista di contraddizioni ancora più aggrovigliate, globalizzate e violente. L’esplosione delle bolle speculative e la distruzione – svalorizzazione – di capitali (“liquidi” e/o fissati in cose materiali: merci, macchinari, materie prime, «capitale umano» e quant’altro) attestano questo doloroso, quanto necessario, processo di risanamento. Sulla base dell’economia capitalistica ciò che appare sorprendente e degna di riflessione non è tanto la crisi, che, come spiega Marx, alligna in ogni momento della prassi tesa a produrre la ricchezza sociale nella sua attuale forma («Ciò che in realtà gli operai producono è il plusvalore»); quanto piuttosto l’apparenza dell’armonia economica che si protrae per periodi più o meno lunghi.
Per questo sbaglia, a mio avviso, chi concepisce la presente crisi nei termini di un fallimento del Capitalismo, almeno nella sua variante «neoliberista» e «finanzcapitalistica»: il fallimento purtroppo sta ancora tutto dalla parte delle classi dominate, incapaci di farla finita con una società che ha nel profitto, nel denaro e nelle merci le sue ipnotiche divinità, dispensatrici di vita e di morte, di fortuna e disgrazia, di felicità e infelicità. Quando il profitto e il denaro governano l’esistenza degli individui, anche di quelli che detengono nelle loro mani il potere, la libertà e l’umanità non sono che menzogne. Questo segna il fallimento dell’umanità, nell’accezione più pregnante – filosofica – del concetto.
Ma che Sapelli non sia un economista banale lo dimostra il passo che segue, il quale allude al bestseller di Giulio Tremonti La paura e la speranza (2008): «È un libro molto bello dal punto di vista economico, un po’ debole come impianto filosofico … Quello che Tremonti non dice è che la sinistra aveva un fine non collettivista ma statalistico. Ha vinto Lassalle, non ha vinto Marx … Paradossalmente è stato Lassalle che ha vinto; cioè alla fine dell’Ottocento nella socialdemocrazia tedesca è passato un principio per cui il welfare andava allo Stato e lo Stato prendeva tutto» [11]. La tesi secondo cui alla fine del XIX secolo nella parte grandemente maggioritaria del movimento operaio la concezione socialstatalista di Lassalle si afferma contro quella rivoluzionaria (comunitaria, non collettivista!) di Marx è da sempre uno dei miei migliori “cavalli di battaglia”, che si sposa perfettamente con il mio radicale antistalinismo. Mi permetto di citarmi: «Che tanto nella Russia di Stalin quanto nella Cina di Mao si costruisse il Capitalismo in guisa di «socialismo reale», ebbene questo ci dice che il senso ideologico più pregnante dello stalinismo riposa proprio in questa gigantesca mistificazione, non importa se fatta in buona o cattiva fede. Sul piano dottrinario lo stalinismo fu debitore delle posizioni stataliste di Lassalle. Com’è noto, Marx aborrì di definirsi “marxista” soprattutto nel momento in cui il «socialismo di Stato» di Lassalle, ridicolizzato nelle potenti pagine della Critica al programma di Gotha (1875), iniziò a prendere il sopravvento persino nel movimento operaio tedesco, in teoria direttamente influenzato da lui e dal suo amico Engels» (Il Time e la “vendetta” di Marx).
Anche la tesi che segue mi pare degna di considerazione: «In realtà la tesi del declino degli USA sulla scena economica mondiale non considera alcune questioni rilevanti … Il ruolo svolto dagli Usa nella crescita asiatica e mondiale è fondamentale … La centralità degli USA è ancora inscritta nella storia del mondo. Lo prova inequivocabilmente la crisi che stiamo attraversando» [12]. Sulla critica dei teorici del declino inevitabile e assoluto degli Stati Uniti rimando al mio studio Geopolitica del Dominio.
Scrive Negri: «È interessante notare come tutte le scuole del pensiero economico si aggirino impotenti attorno a questa inaudita verità del postfordismo: il lavoro vivo si organizza indipendentemente dall’organizzazione capitalistica del lavoro» [13]. Si vuole forse affermare un nuovo concetto di lavoro produttivo e un nuovo concetto di lavoro vivo? Il problema è che Negri, in questo simile agli altri “cognitivisti marxisti”, si ostina a usare categorie marxiane per descrivere una realtà economico-sociale che, a suo avviso, esorbita non poco, anzi in maniera decisiva dal quadro di riferimento storico-sociale marxiano.
Il concetto marxiano di lavoro vivo si comprende solo in relazione al concetto di lavoro morto o passato, ossia al lavoro incorporato nei mezzi di produzione e nella materia prima e ausiliaria “agiti”, per così dire, dal lavoratore nel processo di creazione del valore. Se «il lavoro vivo si organizza indipendentemente dall’organizzazione capitalistica del lavoro» semplicemente cessa di essere lavoro vivo, almeno nell’accezione marxiana del concetto, e diventa un’altra cosa, e a questo punto non si capisce perché non si debba trovare un termine adeguato a questa cosa.
Di più: qualsiasi lavoro, anche quello genericamente produttivo, nella misura in cui si organizza «indipendentemente dall’organizzazione capitalistica del lavoro» non crea alcun plus di valore (o profitto che dir si voglia) al generico capitale che lo dovrebbe sfruttare, e perciò stesso esce dalla rubrica del lavoro produttivo. Poco male, ma occorre capire se stiamo parlando di mele o di pere, di Capitalismo o di un fantomatico Comune.
«Il lavoro immateriale non si riproduce nella forma dello sfruttamento, ma nella forma della riproduzione della soggettività … Questo rapporto [capitale-lavoro] non è più un rapporto di semplice subordinazione al capitale. Al contrario, questo rapporto si pone in termini di indipendenza dal tempo di lavoro imposto dal capitale» [14]. Possibile? Ovviamente no. Occorre ripeterlo: nella misura in cui un lavoro, «immateriale» o «materiale», «si pone in termini di indipendenza dal tempo di lavoro imposto dal capitale» semplicemente non esiste dal punto di vista della valorizzazione capitalistica. Salvo che non ci si riferisca al fondamentale fenomeno sociale generato dallo sviluppo quantitativo e, soprattutto, qualitativo del Capitalismo che abbiamo preso brevemente in considerazione a proposito del General Intellect. La potenza sociale del Capitale è così forte e capillare da mettere in qualche modo a profitto, anche in termini indiretti, a volte in modo assai mediato (d’altra parte, la forza gravitazionale del Capitale «c’è ma non si vede»), attività – anche quelle cosiddette ludiche – che un tempo sembravano del tutto tetragoni nei confronti di un loro qualsivoglia utilizzo in termini economici.
«La funzione progressiva del capitale è terminata», scrivi ancora Negri. «Anche in questo caso siamo ben oltre i termini (anche critici) dell’economia classica che ritiene produttivo solo il lavoro incorporato al capitale». Detto che per il pensiero critico-radicale la spinta storicamente progressiva del Capitale si è esaurita da un secolo, almeno per ciò che riguarda l’Occidente capitalisticamente avanzato (e il Giappone), ossia con l’affermarsi e il consolidarsi della sua fase imperialistica e con la Prima guerra mondiale che ne è derivata, e che anche “formalmente” segna l’inizio di una nuova epoca (quella che Lenin e i suoi compagni occidentali definirono «delle guerre e delle rivoluzioni»); detto questo, c’è da dire che è senz’altro vero che l’economia classica considerava produttivo solo il lavoro incorporato al capitale, ma nella sua forma materiale, ossia nella merce dura e pesante, per così dire. Di qui, la sua «concezione triviale e feticistica» del lavoro produttivo che Marx non mancò di rinfacciarle, senza peraltro sottovalutarne i grandi meriti scientifici.
Com’è noto, Marx riprende, incorpora e supera il concetto smithiano di lavoro produttivo attraverso la critica della teoria del valore elaborata dal grande economista inglese. Mentre Smith aveva ancorato quel concetto alla forma materiale del prodotto del lavoro, ossia della merce in quanto oggetto, Marx dissolve ogni residuo feticistico implicito nel concetto smithiano, e pone saldamente al centro della definizione del lavoro produttivo e della distinzione tra questo e lavoro improduttivo il rapporto sociale di scambio tra capitale e lavoro salariato. Per questo considerare la concezione marxiana del valore alla stregua di un mero sviluppo, più o meno creativo, della teoria classica del valore-lavoro è del tutto sbagliato, e chi lo fa mostra di non aver compreso né il metodo né il punto di vista “dottrinario” che guida l’analisi “economica” di Marx. Infatti, il perno attorno a cui ruota la sua riflessione critica sul Capitalismo non è il valore «in sé» cristallizzato in una cosa economicamente sensibile (Adam Smith), né la sua distribuzione sotto forma di reddito «trinitario»: salario, profitto e rendita (Ricardo), ma, appunto, il rapporto sociale che ne rende possibile sempre di nuovo la produzione e la distribuzione. Più che una teoria del valore-lavoro, quella marxiana è piuttosto una teoria dello sfruttamento del lavoro vivo da parte del Capitale.
La «forma materiale» (valore d’uso) della merce prodotta (spettacolo, piacere, frigoriferi, scienza, cultura) acquista una decisiva importanza solo se guardata dalla prospettiva del processo di formazione del valore che sempre di nuovo si aggiunge (ex novo) alla ricchezza sociale già prodotta. Da quella prospettiva, la sola che permette di capire il movimento della società capitalistica nel suo complesso, decisivo diventa la qualità del plus di valore incamerato dal capitalista: si tratta di una mera sottrazione di ricchezza (dalla tasca dei consumatori di arte e di corpi a quella dell’impresario e del magnaccia), ovvero di una creazione di valore prima inesistente? Il solo lavoro che, mentre conserva e vitalizza il vecchio valore (lavoro morto o passato, nella terminologia marxiana), ne crea di nuovo, prima inesistente sulla faccia della terra, è quello che produce la “triviale” merce materiale. E qui veniamo al limite storico del Capitalismo considerato in precedenza. Ma il mistero di tutta questa complessa dialettica non è chiuso nel corpo della merce, ma nell’immateriale rapporto sociale che ne informa la produzione.
«Che il fine della produzione capitalistica sia il prodotto netto, di fatto puramente nella forma del plusprodotto, in cui si rappresenta il plusvalore, deriva dal fatto che la produzione capitalistica è essenzialmente produzione di plusvalore» [15]. Per questo Marx sostiene che, stricto sensu, «è produttivo il lavoro che crea immediatamente plusvalore» (p. 67), mentre il lavoro genericamente produttivo (sfera della circolazione e dei servizi) crea un plus di valore solo mediatamente, ossia drenando sotto forma di profitto un’aliquota più o meno cospicua di plusvalore generato nel settore industriale, agricoltura inclusa, ovviamente. Di qui, la furibonda lotta tra le differenti “tipologie” di capitale per la spartizione del bottino. E di qui, ancora, l’invenzione di sempre più sofisticati prodotti finanziari atti a far lievitare fittiziamente una materia prima (il plusvalore primario) che non può certo soddisfare gli appetiti di un capitale sempre più vorace.
In tutto il mondo milioni di individui sono messi a sgobbare per inventare nuovi sistemi idonei a depredare la gente, ossia a intercettare una parte del plusvalore mondiale: dalla merce ai servizi commerciali e finanziari (intere nazioni si sono specializzate in questo peculiare settore: vedi l’Inghilterra), dai giochi più o meno “intelligenti” alle lotterie. Vendere certezze, sicurezze, stili di vita, “utopie”, sogni, dignità, status sociale, speranze: qualsiasi cosa che possa indurre il consumatore, attuale e potenziale, a “scucire” denaro. Questa industria “esistenzialista”, sempre più intrecciata con l’industria mainstream (basti considerare il nuovo oggetto di culto: l’iPhone, impasto di materia e di servizi) crea forse un plus di valore per il capitale? Certamente! Si tratta appunto di ciò che chiamo plusvalore secondario o derivato (ovvero, semplicemente, profitto), il cui presupposto di ultima istanza riposa appunto nella creazione del plusvalore primario o plusvalore stricto sensu.
Ho voluto fare questa rapida incursione in questioni assai scottanti e dibattute semplicemente per confermare l’idea che il punto di vista anticapitalistico marxiano rimane di gran lunga il migliore per dar conto del Capitalismo di questo inizio Secolo.
_____________________________________________
Note
[1] G. Sapelli, La crisi economica mondiale. Dieci considerazioni, pp. 9-13, Bollati Boringhieri, 2008.
[2] C. Vercellone, Il ritorno del rentier, in Posse – novembre 2006.
[3] S. Isaia, Dacci oggi il mostro pane quotidiano, p. 266. Testo scaricabile dal Blog.
[4] Dove va il capitalismo italiano, intervista a G. Sapelli di Rai News 24, 30 marzo 2011.
[5] L. Napoleoni, Economia canaglia, Il Saggiatore, p. 251, 2008.
[6] G. Ruffolo, S. S. Labini, Il film della crisi, p. 116, Einaudi, 2012.
[7] J. M. Keynes, Prefazione all’edizione tedesca del 1936 della General Theory.
[8] Più che la speculazione finanziaria, i cui “demeriti” peraltro l’autrice non disconosce, «dal 1929 al 1940, da Hoover a Roosevelt, [fu] l’intervento pubblico [che] contribuì a far diventare Grande la Depressione», (A. Shlaes, L’uomo dimenticato, p. 24, Feltrinelli, 2011). Un giudizio che in parte mi sento di condividere.
[9] W. Adorno, Minima moralia, p. 118, Einaudi, 1994.
[10] C. Vercellone, Modelli di welfare e servizi sociali nella crisi sistemica del capitalismo cognitivo, Uninomade, 15 novembre 2011.
[11] G. Sapelli, Sulla finanza esasperata Tremonti ha ragione, in Economia, politica, società, p. 41, Sussidiaria.net, 2008.
[12] G. Sapelli, La crisi economica mondiale, p. 56.
[13] T. Negri, Dalla transizione al potere costituente, Future Antérieur, 1990; in Inventare il comune, p. 37, DeriveApprodi, 2012.
[14] T. Negri, Lavoro immateriale e soggettività, Future Antérieur, 1990; in Inventare il comune, p. 56.
[15] K. Marx, Il Capitale, libro primo, capitolo sesto inedito, p. 78, Newton, 1976.
da http://www.sinistrainrete.info
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa