Un pianeta poco conosciuto, molto favoleggiato. Siamo stati tutti maoisti, almeno per giorno, ma non è che sapessimo molto di più di quanto scritto da Mao nei suoi libri (o anche solo nel “libretto rosso”). Qualcuno ha approfondito, certo, ma “la massa” dei militanti si fermava alle parole d’ordine generali.
Il movimento comunista in Occidente d’allora, e soprattutto il movimento del ‘68, si accontentava di trovare un’alternativa appassionante, stante l’insofferenza per il “socialismo reale” brezneviano.
Ovvero, le “guardie rosse”, “bombardare il quartier generale”, “potere alle masse” e non alla burocrazia.
Una ricezione molto ideologica, per forza di cose. Non del tutto sbagliata, ma indubbiamente parziale.
Poi la rottura dell’incanto: la morte di Mao, il ritorno di Deng, “arricchitevi”. La delusione che produce disinteresse. Di lì uno sguardo sempre più distratto su quel pianeta, considerato ad un certo punto “acquisito al capitalismo”.
Il lento ritorno all’analisi è parallelo alla crescita di rilevanza economica e tecnologica.
La pandemia e la crescita dei consumi hanno costretto tutti a riflettere nuovamente. A porsi domande, prima di sparare risposte piene di nulla.
La prima cosa su cui bisognerebbe riflettere seriamente è la differenza essenziale tra la lotta per la conquista del potere politico e la successiva costruzione della società. Quanto a tipo di partito, tipologia dei quadri, competenze utilizzabili, pianificazione dell’azione, priorità nel rapporto avanguardia-masse. Fare i guastatori del sistema dominante e gestirne/costruirne un altro, anche intuitivamente, sono mestieri differenti.
Il primo processo è sempre quello più studiato, o almeno letto. E’ la fase eroica, della lotta rivoluzionaria, della resistenza e della vittoria. In questa fase è facile trovare – soprattutto ex post e da lontano – l’identificazione con la “linea giusta”: è quella che fa vincere.
E’ facile immaginarsi sulla Sierra o nella Lunga Marcia, anche se per esperienza si sa che il 90% dei tifosi romantici, o dei “leoni da tastiera”, non regge a un solo giorno di quella vita.
E’ facile anche distinguere tra compromessi necessari e compromessi inaccettabili: il criterio del rafforzamento e della vittoria è il rasoio di Occam su ogni fantasticheria da “professorini”.
E’ facile anche identificare il ruolo degli intellettuali in relazione al popolo (intellettuale “organico” che lo aiuta ad arrivare alla vittoria, portando saperi che entusiasmo e volontarismo non possono inventarsi).
E tra gli intellettuali rientrano ovviamente gli “esperti” (ingegneri, architetti, ecc), coloro che possiedono il know how indispensabile per realizzare qualsiasi compito al di sopra del puro artigianato.
E’ facile assumere, senza pensarci davvero, un immaginario romantico e astratto di socialismo pane e cipolle, un immaginario pauperistico da “economia di guerra” che ovviamente è adeguato a periodi precisi e soprattutto limitati da una condizione oggettiva, il cui responsabile sia il nemico.
Una volta vinto, visto da lontano, è tutto scontato: “si fa il socialismo, no?”.
Al massimo bisogna stare attenti ai piccolo borghesi che provano a mantenere un ruolo, ma provvediamo con la lotta di classe, anche dentro il partito… Le condizioni materiali di partenza, in quell’immaginario, non sono mai un grosso problema. E anche la strada successiva…
Cosa significhi “costruire il socialismo”, a partire da condizioni date, non viene in genere troppo indagato. C’è stata una grandissima produzione, anche teorica, nello scomparso campo del “socialismo reale”, ma qui in Occidente – anche comprensibilmente – assai poca. Le eccezioni, non molte, confermano la regola.
Dietro questo immaginario soprattutto occidentale c’è il peso sottaciuto, ma incalcolabile, della principale sconfitta del movimento operaio del ‘900: la rivoluzione in Germania.
Qui in Occidente, da lì in poi, ma soprattutto dal secondo dopoguerra, il passo iniziale verso il socialismo – la conquista del potere politico, del rapporto di forza complessivo che rende possibile cambiare l’organizzazione sociale – è diventato un orizzonte dal profilo incerto, sempre in bilico tra desideri rivoluzionari e pratiche riformiste che li negavano.
Ma al di là delle pur importanti questioni politiche negative, quella sconfitta ha incubato la peggiore delle “deformazioni” che il pensiero del movimento comunista abbia subito, senza neanche accorgersene: il bisogno disperato di identificare un modello astratto, un socialismo ideale da prendere come riferimento. Rovesciando in modo radicale il rapporto dialettico tra progetto di trasformazione e realtà empirica che dovrebbe esserne oggetto.
Detto in altri termini, invece di analizzare a fondo le caratteristiche del Paese (o dell’area) in cui si operava, per delinearne la possibile trasformazione progettuale in senso socialista, attraverso una rottura politica necessariamente radicale, si è lentamente finito per immaginare una forma ideale di socialismo – esistente solo nel mondo delle categorie teoriche, e spesso diversa da setta a setta – rispetto a cui si decideva, di volta in volta, se e quanto le concrete esperienze storiche vi si avvicinavano.
Ne sono derivate due conseguenze opposte e complementari: l’incapacità di individuare una strategia politica per la conquista del potere politico e il confinamento del socialismo nell’empireo delle utopie.
Nei paesi industrialmente avanzati, in atri termini, ci si è adattati ad “adottare” la “variante giusta” tra quante ce ne venivano proposte dalle esperienze concrete di altri popoli. Ci sono state ovviamente delle eccezioni, tutte sconfitte e perciò velocemente dimenticate. Ma la principale “strategia originale”, da questa parte del mondo, è stata purtroppo la “democrazia progressiva” di Togliatti. Con gli esiti che possiamo ammirare guardando in faccia D’Alema, Fassino o Zingaretti.
Insomma: in Europa la Rivoluzione, dal dopoguerra in poi, ha popolato più l’immaginario che la pratica politico-sociale. In quell’immaginario, qualunque fosse il “modello preferito” (la Cina di Mao, la Cuba di Fidel, la Russia di Lenin e Stalin), socialismo era certamente sinonimo di giustizia sociale, mentre la questione della produzione di ricchezza restava sullo sfondo, un orizzonte di lunga durata cui si sarebbe arrivati a forza di sacrifici, militanza, disciplina.
Detta in termini teorici più precisi: in quella dimensione ideale, o utopica, ci si concentrava più sui rapporti di produzione (modificabili con la determinazione della volontà politica, anche in tempi rapidi) che non sullo sviluppo delle forze produttive (processo lungo o lunghissimo, da programmare ingegneristicamente secondo una pianificazione di enorme complessità e soggetta ad avanzamenti/arretramenti per i più diversi motivi).
In quel solco onirico, si poteva addirittura arrivare a pensare che “il capitale lavora per noi” – da Kautsky a Toni Negri – preparando cioè le condizioni per la socializzazione dei mezzi di produzione, ecc, che ci sarebbe caduta in mano quasi senza colpo ferire al momento dell’inevitabile “crollo”.
In questa prospettiva, insomma, la questione dello sviluppo delle forze produttive era affare che doveva risolvere il capitalismo; i socialisti-comunisti avrebbe dovuto “solo” cambiare i rapporti di proprietà e la strutturazione politica (con la rivoluzione o con le “riforme di struttura”, era tutto da vedere). Il resto sarebbe venuto da sé, senza problemi o quasi.
Mi sono soffermato a lungo su come dall’Occidente si guardava alla Cina, negli anni ‘60 e ‘70, perché oggi abbiamo bisogno di abbandonare quello stadio catatonico dell’immaginazione rivoluzionaria che si è incancrenito qui, nel “capitalismo avanzato”, e cominciare a lavorare seriamente per individuare le strade per un socialismo del XXI secolo che sia possibile in base alle caratteristiche della formazione sociale in cui concretamente viviamo. Senza più sognare di copiare esperienze irriproducibili, senza più sentirsi incapaci di pensare, organizzare, lottare, progettare.
Convegni come quello di oggi hanno questo scopo, non l’incoronazione di una nuova “guida suprema”.
Va abbandonato l’immaginario del ‘900, conservando la forza della teoria marxiana e la tensione al cambiamento reale, rivoluzionaria. Va sviluppata insomma l’immaginazione, la capacità creativa che sa tener conto dell’esistente, conoscendo esattamente le debolezze da cui si parte e la pochezza degli strumenti di cui si dispone. Che sa fare il fuoco con la legna che c’è…
E’ un passaggio che è già avvenuto nella Storia reale, con lo schianto del 1989-91, ma non è stato ancora metabolizzato nel pensiero comunista “europeo”, rimasto “frizzato” da quello choc. L’evoluzione della Cina, da questo punto di vista, serve a rimettere in moto il nostro agire e il nostro pensiero. Per trovare finalmente una visione rivoluzionaria e concretissima, “disegnata” sulle caratteristiche di questa parte del mondo allo stadio attuale.
Non a immaginare un altro “modello” che sostituisca quelli defunti con uno, per il momento, vincente.
Come abbiamo avuto modo di ragionare in altra occasione, la questione del passaggio dal modo di produzione capitalistico a qualche forma di socialismo – nella teoria marxiana – diviene matura a un livello avanzato dello sviluppo delle forze produttive. Il socialismo, in altri termini, è per Marx un superamento traumatico del capitalismo, che dialetticamente conserva e prosegue i livelli di sviluppo raggiunti nel mentre rovescia ed azzera i vecchi rapporti di produzione e di proprietà.
Come sappiamo, sul piano storico e politico, le cose sono andate fin qui diversamente.
La Rivoluzione ha vinto dall’Ottobre in poi esclusivamente in paesi capitalisticamente arretrati (la Russia zarista), o addirittura in colonie che hanno dovuto condurre lunghe lotte di liberazione nazionale, oppure ancora in Paesi oppressi dalla dominazione imperialista (tutta l’America Latina). Il massimo della fortuna/sfortuna poteva essere una certa ricchezza di materie prime (petrolio, gas, litio, ecc), che garantiscono una rendita estrattiva, quindi risorse da utilizzare, ma che rendono anche oggetto di appetiti multinazionali ben poco amichevoli.
La Cina post-rivoluzione ha a lungo riassunto in sé un po’ tutte queste caratteristiche, con in più una cultura millenaria profondamente diversa da quella occidentale di origine greca e, come si suol dire, giudaico-cristiana prima e illuministica poi. Il che ha probabilmente sempre pesato in negativo sulla precisione della ricezione, in Occidente, di quella esperienza e del suo contributo anche teorico.
Il tratto comune di tutte le rivoluzioni fin qui vittoriose è dunque stato: un forte direzione di un Partito Comunista guidato da grandi personalità in grado di saldare visione marxiana, politica rivoluzionaria leniniana e condizioni specifiche del proprio paese (livello di sviluppo, composizione sociale, cultura, tradizioni, modi di pensare e produrre).
Ma anche nei tentativi concreti di costruzione del socialismo in quel tipo di Paesi è possibile rintracciare un tratto comune a esperienze tra loro molto diverse: tutte partivano da condizioni di sviluppo industriale estremamente arretrate (spesso dopo guerre decennali), bassi tassi di alfabetizzazione, povertà di massa, stragrande prevalenza numerica dei contadini (fra loro divisi in molti “strati”, peraltro), scarsa popolazione operaia e cittadina.
Specie nei paesi più grandi – Russia e Cina, fondamentalmente, gli unici peraltro con alcune isole di produzione industriale di medio-alto livello – lo sviluppo si è tradotto in processi di industrializzazione a tappe forzate, equivalenti (per ampiezza dell’impatto sulla struttura sociale preesistente) alla “accumulazione originaria del capitale”. In parole povere, si doveva usare il sovrappiù di manodopera e risorse del mondo agricolo per finanziare un lungo periodo di investimenti industriali e infrastrutturali, verso cui far convergere la forza-lavoro “liberata” dalla terra.
Peggio ancora: si dovevano mantenere a lungo condizioni salariali e di riproduzione al limite della sopravvivenza per destinare tutto il sovrappiù agli investimenti per lo sviluppo (compresa la tara della corruzione, che è sempre arrivata a lambire diversi livelli del “partito”, in ogni Paese).
Processi sociali sconvolgenti, pieni di conflitto, con riflessi importanti anche all’interno dei partiti comunisti che li dirigevano (“la lotta contro i kulaki”, la collettivizzazione e le relative resistenze, ecc).
Da questo punto di vista, e fino a quando la relazione tra i due paesi è rimasta solida (fine degli anni ’50), l’avvio del processo di modernizzazione e sviluppo in Russia e Cina è stato nel complesso abbastanza simile, a grandissime linee. Ma anche successivamente, almeno fino alla morte di Mao, l’accento è sempre stato posto sulla politica al posto di comando (con il partito alla guida di tutti i processi), sulla giustizia sostanzialmente paritaria tra tutti i cittadini (nel reddito come nella divisione del lavoro necessario, o finanche nel vestire).
I risultati, che pure venivano conseguiti, spesso con tassi di crescita da “boom” economico, erano visti come conferma della correttezza della linea politica seguita. E gli insuccessi ascritti, all’opposto, a incomprensione della linea o sabotaggio degli avversari di classe, a corruzione, ecc.
Non sto qui a ripercorrere momenti o episodi fin troppo noti e non sempre apprezzabili. Di certo, il volontarismo e l’entusiasmo delle masse, la capacità di mobilitazione ideologica, non possono compensare deficit di conoscenze scientifiche, indisponibilità di tecnologie appropriate (anche se magari obsolete) e altre decine di “dettagli” molto concreti.
Basta forse fare l’esempio del tentativo di “produzione diffusa” dell’acciaio, tramite l’installazione nelle comuni contadine di decine di migliaia di “fornaci da cortile”, che fondevano resti metallici di ogni tipo restituendo – com’è inevitabile – qualcosa di molto lontano dalla qualità minima dell’acciaio utilizzabile per l’industria. La fisica dei materiali è del resto indifferente alla migliore volontà politica.
 L’esempio è però utile anche per illuminare visivamente il tipo di immaginario che dominava nel movimento comunista di quel tempo, non solo occidentale. Ossia quella visione “pauperistica” del socialismo che esalta la parità di condizioni e sottovaluta l’efficienza, l’efficacia, la maturità dello sviluppo (economico, industriale, sociale). O, nel migliore dei casi, che prova a fare anche nel campo della produzione ciò che tanto bene riusciva sul piano politico: mobilitare immense forze sociali nella convinzione che “dal basso” potessero nascere anche delle risposte efficaci (“cento fiori fioriscano, cento scuole gareggino”).
L’esempio è però utile anche per illuminare visivamente il tipo di immaginario che dominava nel movimento comunista di quel tempo, non solo occidentale. Ossia quella visione “pauperistica” del socialismo che esalta la parità di condizioni e sottovaluta l’efficienza, l’efficacia, la maturità dello sviluppo (economico, industriale, sociale). O, nel migliore dei casi, che prova a fare anche nel campo della produzione ciò che tanto bene riusciva sul piano politico: mobilitare immense forze sociali nella convinzione che “dal basso” potessero nascere anche delle risposte efficaci (“cento fiori fioriscano, cento scuole gareggino”).
Ma con la materia e la natura questa soluzione non funziona. Serve anche ricerca scientifica, know how, “un gatto che acchiappi i topi”.
 Sul piano teorico, mi sono sempre chiesto il perché della formula “il rosso vince sull’esperto”. Fino a pensare a un errore nella prima traduzione, che poi si era imposto con la forza dell’abitudine e del passaparola.
Sul piano teorico, mi sono sempre chiesto il perché della formula “il rosso vince sull’esperto”. Fino a pensare a un errore nella prima traduzione, che poi si era imposto con la forza dell’abitudine e del passaparola.
Il problema evidente è la sua mancanza di dialettica. Quella formula fissa un momento del conflitto e lo rende eterno, sottratto alla sintesi e alla dinamica. Mentre è ovvio, studiando seriamente i nostri “sacri testi” di riferimento, che la “scelta politica di classe” può e deve certamente determinare la direzione di marcia, il programma di medio-lungo periodo. Ma quando si passa alla fase realizzativa, al concreto dei progetti, la parola deve in larga misura passare agli “esperti” (se ce ne sono).
Non si costruiscono palazzi, dighe o autostrade, centrali elettriche o fabbriche di ogni genere senza ingegneri. Non si fanno farmaci senza chimici, biologi, ricercatori e laboratori. Non si costruiscono reti di comunicazione o architetture informatiche. E nemmeno un acciaio di qualità passabile.
Il come si fanno le cose è altrettanto importante, l’altra faccia, del cosa si vuol fare, produrre, ecc.
A risultato ottenuto (sintesi dialettica), effetti registrati, nuovi problemi emersi, di torna a decidere politicamente come andare avanti per risolvere le nuove esigenze. E torna “il rosso”, la decisione politica, il conflitto per stabilire la direzione di marcia.
Ma torna con un livello più alto di esperienza e conoscenza, non con quello di partenza. E’ una scala a chiocciola, non l’anello dell’eterno ritorno.
La ricostruzione dello scontro tra Mao e Deng, tra il 1974 e 1976 – fatta da Alessandro Russo in Com’è finita la Rivoluzione culturale? Gli anni Settanta in Cina e l’ultima disputa tra Mao Xedong e Deng Xiaoping (in 1985, Le rovine del mandato, Angeli; 2009, e Com’è finita la Rivoluzione Culturale?, Gli anni Settanta Tra crisi mondiale e movimenti collettivi, Clueb) – coglie con molta precisione l’intreccio di problemi cui il Partito cinese si è trovato allora di fronte. A partire, paradossalmente, dal quesito posto dallo stesso Mao all’inizio della “disputa”: “Perché Lenin parla di dittatura sulla borghesia?”
Una domanda, là dove ci si aspetterebbe un’affermazione perentoria.
Come si sa, Deng non amava le discussioni filosofiche fini a se stesse, ma non è che fosse ignaro del rivolto teorico dei problemi concreti. Anzi. Si sa anche che per due volte “cadde in disgrazia”, proprio in quei due anni, senza altre conseguenze che essere destinato ad incarichi di seconda fila (e senza organizzare scissioni, come qui accade sempre). Alla morte di Mao, e già durante la parentesi Hua Guofeng, la sua posizione diviene dominante. Stabilito che l’obbiettivo politico era sviluppare la Cina – e su questo non c’era disaccordo strategico neanche con i maoisti – si trattava “solo” di vedere come farlo.
Di certo, la sua posizione “più tecnica” implicava un approccio – come si dice – top-down. Ossia l’impostazione delle soluzioni a livello di vertice e con molto meno “discussione alla base”, almeno per quanto riguarda la grande industria e le infrastrutture strategiche.
Ma il cuore più antipatico del denghismo è certamente quell’”arricchitevi!” che segna l’inizio di una scommessa rischiosissima: usare la voglia di profitto tipica dell’imprenditoria privata per sviluppare e dinamizzare il Paese, ma senza perdere il controllo della macchina dello Stato e la forza/capacità di stabilire la cornice entro cui quell’ansia privatistica di ricchezza era legittimata a muoversi.
Programmazione e pianificazione centralizzati, grande “libertà di impresa” (anche per le multinazionali straniere!) per realizzare quegli obbiettivi.
Con le sue parole:
“Alcuni sostengono che man mano che affluiscono investimenti stranieri e che vengono create joint-venture, vengono introdotti sempre più elementi di capitalismo e quest’ultimo si espanderà in Cina. Ma a queste persone mancano competenze basilari. Nella fase attuale, alle imprese a capitale straniero in Cina è permesso di guadagnare, ma nel rispetto delle norme politiche vigenti. E il governo preleva tasse da queste compagnie, i lavoratori ricevono da queste ultime un salario, e noi acquisiamo tecnologia e competenze manageriali. Inoltre possiamo ottenere da queste aziende informazioni che ci aiuteranno ad aprire più mercati. Quindi, soggette ai limiti dettati dalla realtà politica ed economica della Cina, le aziende a capitale straniero costituiscono un’utile integrazione all’economia socialista e, in ultima analisi, giovano al socialismo” (Deng, 1994, in Una Cina “perfetta”, pag. 166)
Il prezzo sociale e ambientale di questa scelta “non troppo rossa” è stato enorme. Un paio di generazioni di lavoratori sono state spremute come limoni per accumulare quel “sovrappiù” che permetteva investimenti giganteschi nelle imprese statali e nelle infrastrutture. Il livello di inquinamento ha reso ampie parti del territorio invivibile, e l’aria delle grandi città irrespirabile. Molto più che in Occidente.
Ma a 40 anni di distanza non si può certo dire che quella scelta non abbia prodotto risultati, che sia stata inefficace. Né che il Partito si sia semplicemente messo a disposizione del capitale privato, come avviene in Occidente. Amazon, per dire, non corre certo il rischio di venir nazionalizzata, come sta per avvenire con Alibaba di Jack Ma…
Se non si vuole entrare in lunghe discussioni teoriche – sicuramente non semplici e non simpatiche – sul ruolo effettivo della classe operaia nella determinazione delle scelte strategiche fatte in suo nome, si può riflettere sulla svolta ecologica della Cina negli ultimi 10 anni. E confrontarla con quanto avviene, nello stesso campo, qui nell’Occidente neoliberista.
Come spiega magistralmente Michelangelo Cocco, nel suo recentissimo Una Cina perfetta, Pechino ha reagito ad alcune rivolte popolari locali provocate dall’inquinamento e/o dai tentativi di insediamento di produzioni inquinanti, tutte classificabili da lontano come classici fenomeni not-in-my-backyard (Nimby), in modo diametralmente opposto a quanto avviene in Occidente: ha rinunciato ad alcuni progetti “vecchio stampo” e ridisegnato completamente la politica energetica, industriale e ambientale. Promozione delle tecnologie energy saving, delle energie rinnovabili, ricerca e sviluppo (la Cina è oggi prima al mondo per brevetti in in questo campo: oltre 130.000), repressione serissima delle imprese che continuavano a smaltire liquami e rifiuti nei fiumi, nell’aria e nel suolo, bonifiche di dimensioni colossali. Che hanno creato competenze, pil, tecnologie innovatrici, occupazione di dimensioni superiore a quelle che venivano abbandonate.
In un certo senso, molto rarefatto, è stato colto il bisogno “delle masse” e gli è stata data una risposta di alto livello. “Dalle masse alle masse”, ma con diversi salti di qualità nel percorso di andata e ritorno…
Qui gli attivisti No Tav, No Muos, No Tap, ecc, non solo vengono massacrati dalla repressione, ma i progetti non vengono affatto fermati. Tantomeno cambiati. E nemmeno si cercano (sarebbe facilissimo) le fonti industriali inquinanti di fiumi e aria. Comandano le imprese, la politica obbedisce e chiude entrambi gli occhi (e anche il naso).
In Cina i risultati di questa politica, come ammettono anche le agenzie occidentali, si vedono. L’abbattimento delle emissioni nocive è stato drastico e promette (in base alle misure effettivamente adottate e alle pratiche messe in campo, non in base alle dichiarazioni di politici e imprenditori) di ridurle nei prossimi anni.
E’ in pratica stato cambiato il modello di sviluppo industriale, sia nelle modalità della produzione che nella tipologia dei prodotti (bici, moto e auto elettriche cinesi sono la stragrande maggioranza, sul mercato mondiale).
In campo ambientale, insomma, si può dire che il governo (il Partito), quando ha compreso che il vecchio modo di produrre stava distruggendo, oltre che l’ambiente, anche la possibilità di crescita futura, è stato in grado di cambiare marcia e obbiettivi.
Qui il paragone con l’Occidente dominato dagli interessi delle imprese private è imbarazzante: qualsiasi misura, per quanto timida, decisa legislativamente viene boicottata sul piano pratico. Evasa, aggirata, negata nei fatti. Miglioramenti dell’ambiente, poco o nulla, se non addirittura un peggioramento a volte anche drastico (con Trump e Bolsonaro).
Questione ambientale e pandemia, insomma, ci raccontano la stessa storia e mostrano entrambe una differenza di sistema. Che riguarda l’intreccio materiale tra modo di produzione, rapporti di proprietà e sistema politico. Non l’ideologia…
Nell’Occidente neoliberista i poteri statuali sono palesemente al servizio della classe dominante (finanza, multinazionali industriali, boss della logistica e delle piattaforme, ecc).
In Cina c’è un potere statuale che utilizza anche l’impresa privata per raggiungere gli obbiettivi programmati e pianificati politicamente.
In Occidente, dal crollo del Muro in poi, il processo di impoverimento dei lavoratori e dei ceti popolari è stato continuo; il welfare è pressoché abolito; il sistema pensionistico è sotto attacco da 30 anni e tutto lascia pensare che il post-pandemia sarà il momento dell’attacco finale.
In Cina la curva dei salari ha costantemente seguito un segno “più” anche rispetto alla dinamica dell’inflazione e il potere d’acquisto del salario medio è ormai confrontabile con quello dei paesi più avanzati, al punto da far dichiarare la povertà assoluta virtualmente estinta. Ossia che oltre 800 milioni di persone, in soli 40 anni, sono state portate a un livello di vita paragonabile a quello del cosiddetto “ceto medio” occidentale (le fasce “a tempo indeterminato” del lavoro salariato).
Sembra evidente che è piuttosto complicato definire con la stessa parola – “capitalismo” – i due sistemi. D’altro canto, sicuramente, quel sistema non è il socialismo che abbiamo in mente (quello del nostro immaginario).
Dunque va piuttosto capito, nella misura del possibile, se la struttura decisionale del Pcc sotto la guida di Xi Jinping stia pianificando un passo ulteriore in direzione della “liberalizzazione” degli animal spirits del capitale oppure verso una più esplicita caratterizzazione socialista.
Resta da comprendere meglio quell’altra formula che come un tormentone ricorre ogni due per tre nei discorsi delle personalità di Pechino: “socialismo con caratteristiche cinesi”. In fondo, non è difficile collegarla alle molte eccezionalità della Cina (dimensioni della popolazione, storia millenaria, coesione sociale altissima, ecc).
Ma è anche abbastanza facile notare che in quel modo si esplicita chiaramente il non voler essere un “modello di riferimento” per altri paesi. In questo, bisogna dire, la differenza con l’Unione Sovietica dei tempi d’oro (e anche di quelli grigi) è piuttosto forte, tanto da spiazzare spesso.
Ma forse si può proprio per questo cogliere più facilmente il lato che dovrebbe stimolare noi comunisti di quest’altra parte del mondo: la nostra idea di socialismo, insomma, non può che avere caratteristiche italiane, mediterranee, europee. Frutto cioè al tempo stesso di una determinata tradizione culturale e di un livello di sviluppo, in partenza decisamente meno arretrato di quello da cui hanno dovuto muovere sia quello cinese che di altri movimenti rivoluzionari.
Ammesso e non concesso, naturalmente, che si abbia prima l’immaginazione necessaria per delineare un percorso realistico di conquista del potere politico, e poi la fortuna di trovare un sistema produttivo non troppo devastato da crisi e conflitto sociale.
Ma anche per conquistare il potere politico, in definitiva, bisogna ragionare seriamente sulle caratteristiche uniche che rendono il nostro angolo di mondo qualcosa da affrontare senza idee prese a prestito.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa

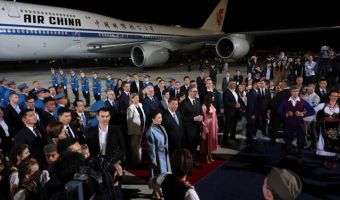


giancarlo staffolani
Un innovativo, serio e non scontato esempio di riflessione da condividere, esso è fondato sul “metodo dialettico” e sull’analisi marxista del “modello cinese”, la cui importanza non può più essere elusa o liquidata con superficialità, presunzione o “tifo” immotivato. Questo testo è molto importante, non solo per comprendere le scelte di valore mondiale dei comunisti cinesi, ma come contributo critico all’orientamento strategico di “tutti i comunisti” nelle varie e diverse realtà internazionali, compresa quella complessa e difficile che stiamo attraversando in Italia ed in occidente.