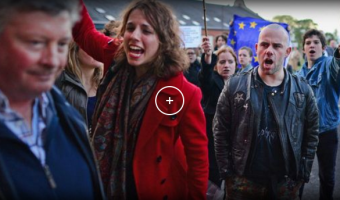Dopo mesi di attesa, il Governo ha “finalmente” presentato il suo disegno di legge sul premierato. Un progetto confuso, contraddittorio, denso di ambiguità, ma allo stesso tempo particolarmente insidioso, perché destinato a rivelarsi veicolo e collettore di una crisi democratica già grave e che l’eventuale irruzione dell’«uomo di fiducia di tutto il popolo» (schmittianamente inteso) non può che acuire ulteriormente.
D’altra parte, per far fronte alla ‘crisi della democrazia’ non vi è che una soluzione: alimentare i canali della partecipazione politica e immettere nel sistema più democrazia.
E questo avrebbe voluto dire: rafforzare i luoghi della rappresentanza (mettendo mano al bicameralismo, un sistema ormai virtuale e sempre più mortificato nelle sue funzioni); dare vita a un ordinamento elettorale in grado di esprimere e rappresentare la plurale articolazione politica del Paese (proporzionale); sperimentare nuove forme di legittimazione parlamentare dei governi (sfiducia costruttiva).
Insomma, provare a ripristinare la centralità del Parlamento.
Di converso, scansata con disprezzo ogni ipotesi finalizzata a rafforzare il pluralismo politico e sociale nel Paese, a prendere oggi corpo, tra i banchi del Governo, è un’altra soluzione: la reductio ad unum del sistema.
I suoi contenuti li abbiamo recentemente appresi dal disegno di legge costituzionale n. 935: blindare il vertice dell’esecutivo, marginalizzare ulteriormente le assemblee politiche, erodere il ruolo degli organi di garanzia costituzionale. Favorire, insomma, le condizioni per l’innesto di un Governo del capo.
Gramsci era solito definire un siffatto approdo: «cesarismo regressivo». Intendendo con questa definizione una forma di Governo del capo che può esistere «anche senza un Cesare, senza una grande personalità “eroica”».
È questa l’opzione oggi perseguita dalla destra di governo per traghettare il Paese verso un’altra Repubblica. Le soluzioni sono quelle di sempre: comprimere il ruolo del Parlamento, esautorandone anche le elezioni per far spazio al plebiscito del capo.
D’altronde, questa destra, alla retorica del capo non ha mai inteso rinunciare. L’elezione diretta è nel suo dna. Lo è sempre stata, sin dalle prime legislature della Repubblica. A ispirarne le ragioni, già negli anni Cinquanta del secolo scorso, era stato Carlo Costamagna: giurista di punta del fascismo e poi critico inflessibile della Costituzione Repubblicana, da questi ritenuta una «costituzione acefala». Cioè senza un capo.
Il disegno di legge sul premierato, invece, un capo lo prevede. Un capo, pressoché, indiscusso e il cui Governo non potrà essere rovesciato. Nemmeno da un voto parlamentare.
E questo perché, anche a fronte di un vistoso fallimento delle sue capacità di governo e delle sue politiche, queste continueranno provvidenzialmente a vivere, grazie alla contestuale assunzione dei poteri di governo nelle mani di «un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto» e al quale spetta ora il compito di operare in sua vece «per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia».
Di qui il tentativo, quantomai smodato, di blindare la durata degli esecutivi e, attraverso essi, l’intera legislatura.
In siffatte condizioni, ai parlamentari di maggioranza non resterebbe, pertanto, altra soluzione che voltare le spalle al divieto di mandato imperativo (art. 67 Cost.) e inchinarsi remissivamente alla volontà del Governo e del suo capo. Quel capo che li ha voluti e designati. E tutto ciò grazie ai singolari meccanismi di selezione verticistica del ceto politico, fino a oggi assicurati dalle leggi elettorali.
Meccanismi che l’attuale riforma si guarda bene dal mettere in discussione, anche perché funzionali alle logiche del capo.
Siamo, in definitiva, al cospetto di un’opzione istituzionale anomala (l’elezione diretta del premier) che non ha riscontri nel diritto comparato. E non perché ignota alla storia costituzionale, ma perché inidonea a funzionare (come la vicenda israeliana ha rovinosamente dimostrato).
A fronte di fibrillazioni politiche del sistema e di crisi che investono il vertice dell’esecutivo, solo due sono le soluzioni costituzionalmente perseguibili.
Nei regimi a vocazione presidenziale si torna al popolo. Nelle forme di Governo parlamentari si torna al Parlamento, al fine di verificare, attraverso appositi istituti a tal fine congegnati (la sfiducia costruttiva o il supporto attivo degli organi di mediazione politica o altro ancora), se esistono le condizioni per formare una nuova maggioranza di governo. Senza se, senza ma. E, soprattutto, senza preclusioni politiche di sorta.
Di converso, la prevista introduzione di una norma “antiribaltone”, così come avanzata dal Governo, rischia oggi di aggiungere confusione a confusione, all’interno del già fatiscente percorso di revisione costituzionale prospettato.
Un percorso non solo contraddittorio, ma anche rozzo. Perché rozza è la soluzione – in esso contenuta – di scansare le censure di incostituzionalità, facendo ingurgitare al testo della Costituzione un premio di maggioranza pari al 55%, assegnato su base nazionale (a questo punto, mi chiedo anche che ne è dell’art. 57, che prevede che l’elezione del Senato della Repubblica debba avvenire su base regionale).
Le conseguenze che rischierebbe di innescare questo sistema elettorale – farraginoso, selettivo e, per di più, senza soglia di scatto – non sono di poco conto.
Se fino a oggi si è detto che le distorsioni costituzionali dell’ordinamento sono, in gran parte, l’esito morboso della pressione esercitata dalla legge elettorale sul sistema. E se si è, da più parti, criticato il funzionamento delle regole elettorali, per aver trasformato istituti e organi di garanzia in variabili dipendenti delle maggioranze di governo, domani – rischiamo – di non poterlo più nemmeno dire.
E, soprattutto, di non poter più fare nulla. Questo perché la riforma, blindando il sistema elettorale, punta ad assegnare costituzionalmente al capo del Governo e alle forze che lo sostengono il potere di revisione e l’elezione del Presidente della Repubblica, dei Giudici costituzionali, dei Presidenti delle Camere.
Certo – si potrebbe obiettare – anche in caso di approvazione della revisione sarà sempre possibile modificare il sistema elettorale. Ma per farlo – è bene ribadirlo – la strada sarà (come mai) in salita, essendo necessario attivare il procedimento lungo e aggravato previsto dall’art. 138 della Costituzione.
Vi è però un dato che, in questo contesto, appare opportuno rilevare. Nel 2014, il giudice delle leggi ha severamente censurato il premio di maggioranza, ritenendolo «foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi.
In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto» (sent. n. 1/2014).
Si tratta di un passaggio cruciale di quella sentenza, con il quale la Corte ha inteso (espressamente e implicitamente) menzionare quelli che sono i princìpi costituzionali della democrazia politica: libertà del voto, principio di eguaglianza, pluralismo politico, diritti delle minoranze.
Principi supremi, che nessun potere costituito – non il governo e neppure il potere di revisione – potrebbero mai scalfire, intaccandone la forza politica e normativa: sarebbe opportuno che chi opera a difesa della Costituzione lo facesse, quanto prima, presente al Parlamento.
* giurista. Dalla newsletter del Centro per la Riforma dello Stato
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa