La storia della musica di protesta in Italia è lunga e importante. Questa storia si intreccia, in gran parte, con quella del folklore, anche se far coincidere musica folk e canto di protesta non è evidentemente possibile. L’apparente sovrapporsi della cultura folk con la musica di protesta è stato un risultato di pratiche musicali e politiche che per un certo periodo della nostra storia culturale, almeno sino ai primi anni ottanta, grazie a quei musicisti come Michele Straniero, Giovanna Marini, Paolo Pietrangeli e Ivan Della Mea – purtroppo omettendo altri nomi importanti – che, raccolti in gruppi permeabili tra loro nella composizione ma spesso diversi nella progettualità, si proposero di coniugare il canto di protesta con la storia della musica delle classi subalterne. Tra questi, Cantacronache di Torino e in seguito Il Nuovo Canzoniere Italiano, che tenne la scena di piazze e festival, con un discreto riscontro anche discografico, per tutti gli anni settanta e ancora in parte negli ottanta.
In effetti, la storia della musica folclorica in Italia ha una sua specificità poiché meno che in altri paesi essa è stata assunta come una base o un principio ispiratore della musica cosiddetta colta (fenomeno che caratterizza per esempio l’Est europeo) tanto che essa ha potuto evidenziare con chiarezza quei caratteri di cultura complessivamente alternativa alla cultura egemone che ne ha fatto un terreno di contatto tra ricercatori, intellettuali, militanti anticapitalisti e classi popolari.
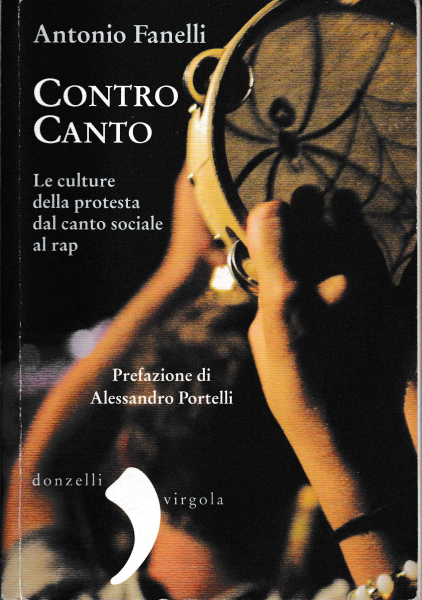 Si tratta di una storia complessa e per alcuni aspetti controversa, di cui Antonio Fanelli cerca di sciogliere alcuni dei nodi storici e politici più importanti nel suo libro Controcanto. Le culture della protesta dal canto sociale al rap (Roma, Donzelli, con prefazione di Alessandro Portelli, pag 281, €25).
Si tratta di una storia complessa e per alcuni aspetti controversa, di cui Antonio Fanelli cerca di sciogliere alcuni dei nodi storici e politici più importanti nel suo libro Controcanto. Le culture della protesta dal canto sociale al rap (Roma, Donzelli, con prefazione di Alessandro Portelli, pag 281, €25).
Fanelli, docente all’Università di Pisa, fa parte del Comitato Scientifico dell’Istituto Ernesto De Martino per la conoscenza critica e la presenza alternativa del mondo popolare e proletario. Da questa sua seconda appartenenza conseguono almeno due qualità del libro scritto da Fanelli. La prima è l’attenzione al pensiero di Ernesto De Martino, dai cui studi fondativi sulla cultura delle classi subalterne italiane derivò quel concetto di “folclore progressivo” in cui molti intellettuali videro il terreno sul quale radicare la fondazione di una nuova cultura alternativa e di rottura a quella delle classi egemoni. Come ho scritto, per diversi decenni e segnatamene dal secondo dopoguerra il folklore fu appunto il terreno d’incontro tra classi popolari e intellettuali.
La seconda è l’impianto gramsciano che Fanelli vuole dare al suo lavoro, ispirandosi alle note “osservazioni sul folclore” contenute nei Quaderni dal carcere del dirigente comunista. Ne risulta un libro denso e complesso, molto documentato, che forse avrebbe dovuto avere qualche pagina in più per consentire un’esposizione più estesa per coloro che – mi riferisco alle giovani generazioni – non hanno vissuto gli anni dei Dischi del Sole, oppure del Nuovo Canzoniere Italiano. S’intenda: questa critica non vuole sminuire il valore del libro, anzi metterne in luce la documentazione molto importante (i protagonisti del canto di protesta dal 1920 a oggi ci sono davvero quasi tutti, come i cantanti e i ricercatori e soprattutto i riferimenti al dibattito che tra di essi si è svolto) che avrebbe meritato di essere discussa e sviluppata più estesamente.
Il libro di Fanelli si propone anche di colmare una lacuna nelle ricerche sul canto di protesta, vale a dire la “poca attenzione prestata alle forme di produzione, circolazione e ricezione delle musiche che hanno accompagnato i momenti di tensione politica e di scontro culturale nel nostro paese” (dalla quarta di copertina). Per esempio, scrive Fanelli, è rimasta in secondo piano, in tutta la stagione degli anni sessanta e settanta, la riflessione sugli effetti dell’immissione nel mercato discografico delle produzioni militanti e del materiale folklorico. In effetti, sostiene l’autore, se si presta attenzione a quali fossero i circuiti di distribuzione (feste dell’Unità e dei movimenti della sinistra) e gli strumenti di diffusione (soprattutto il disco), i prodotti folklorici condividevano spesso gli spazi con la produzione popular e anche la forma canzone, seppure ricca di contenuti politici, finiva spesso con l’avvicinarsi a quella dei cantautori allora emergenti. Eppure, a dispetto di questa contiguità nelle forme di diffusione, e spesso anche della condivisione del pubblico, tra i ricercatori e i musicisti della musica folklorica, la musica pop era spesso vista con sospetto, come un prodotto esclusivamente commerciale. Questo perché se distribuzione e diffusione potevano essere in parte comuni, ciò che era molto diversa era la rappresentazione di sé dei musicisti folk e dei cantautori. Questi ultimi, anche i più “impegnati” infatti, erano e sono interni al mondo delle case discografiche, si concepiscono come artisti, mentre i cantanti del folk degli anni sessanta e settanta si sentivano spesso dei ricercatori di cultura popolare e dei militanti, quindi appartenenti a un progetto politico che partiva dalla scoperta e dalla diffusione del punto di vista delle classi subalterne. Primo tra tutti ad avere questa posizione era Ivan Della Mea, che nel libro di Fanelli è molto presente sia per il ruolo di rilievo avuto nella storia della canzone di protesta sia per la vicinanza culturale all’autore (Della Mea fu presidente per diversi anni dell’Istituto Ernesto De Martino). Come esempio di questa diversa concezione di sé si può ricordare quando Della Mea declinò la proposta di Francesco De Gregori di collaborare a una produzione comune perché, egli sostenne, vivevano in due mondi diversi (per la cronaca, ma diversi anni dopo, si realizzò invece un incontro musicale tra lo stesso De Gregori e Giovanna Marini).
Della contrapposizione tra canzone pop e di protesta, tra pop e folklore Fanelli ripercorre le tappe con attenzione, soprattutto per mettere in discussione tale contrapposizione già dalle prime pagine del libro, dedicate a Raffaele Mario Offidani, in arte “Spartacus Picenus” (in omaggio all’eroe della lotta contro la schiavitù), fortunato cantore comunista del periodo tra le due guerre. Fanelli ricorda che Spartacus Picenus usava trasformare in canti rivoluzionari le melodie delle canzonette di moda, cantandole con testi di protesta politica. Una tecnica, questa, di ri – uso di materiali peraltro diffusa nel mondo popolare al di là dello stesso Spartacus Picenus. Si tratta di un esempio significativo, che si inquadra nel tentativo di Fanelli di mettere in discussione delle differenze, forse troppo forzate, tra il mondo folk e di protesta e il mondo pop, tanto che l’autore in alcuni casi attribuisce ai protagonisti del primo un atteggiamento altezzoso e quasi censorio verso il pop. Si tratta in effetti di un tema molto complesso. In primo luogo credo che si debba proprio partire dalla figura e della rappresentazione di sé che avevano personaggi come i componenti del Nuovo Canzoniere Italiano che vivevano quel doppio ruolo di ricercatore e militante di cui ho scritto. Questo significava, per loro, includere nel proprio repertorio sia canti folklorici sia nuove canzoni di protesta, da loro scritte ma che volevano riprodurre stili, modalità e temi del canto popolare (mettendo al centro il punto di vista operaio, prevalene su quello “storico” dei lavoratori agricoli). Questi ricercatori – militanti, in gran parte riuniti appunto nel Nuovo Canzoniere Italiano, avevano una posizione diversa da coloro che invece si limitavano alla ricerca e alla riproposizione della musica folk e che erano evidentemente più lontani dal mondo dei cantautori. Quanto poi all’opposizione troppo forzata denunciata da Fanelli proposta da alcuni personaggi della folk music rispetto al mondo pop, giova ricordare che il primo dei gruppi folk sorti in Italia, Cantacronache, nacque proprio come reazione al repertorio “Sanremo” ritenuto borghese e corruttivo delle classi popolari. Tuttavia, se i componenti di Cantacronache erano ricercatori, nel progetto di quel gruppo era soprattutto la creazione di nuove musiche aderenti alla vita del popolo, quindi, per qualche aspetto di una pratica cantautorale che guardava agli chansonniers francesi e al teatro di Brecht – Weill.
Parliamo degli anni tra la seconda metà dei cinquanta e la prima dei sessanta, quando Umberto Eco, che fu vicino a Cantacronache, invitava a guardare con attenzione anche a quanto emergeva in una parte della musica allora detta “leggera” e del cabaret, come per esempio al lavoro di Dario Fo, Jannacci, Gaber e altri. Questi ultimi certamente vicini all’industria discografica, ma in modo totalmente diverso dalla cultura vigente a Sanremo dove Celentano presentava la canzone sessista Chi non lavora non fa l’amore contro gli scioperi degli anni sessanta e La coppia più bella del mondo contro la legge sul divorzio. Queste ultime canzoni si contrapponevano direttamente alle lotte operaie e a quelle civili, ma non c’è dubbio che lo stupidario sanremese e molta produzione – spazzatura tra gli anni sessanta e settanta abbia contribuito a un rifiuto generalizzato del pop al di là delle differenze che si vivevano in quella musica.
Il procedere di Fanelli non si arresta con la discussione dei casi e fattori storici citati, ma avanza sino a i giorni nostri, attraversando generi e repertori come il punk, il reggae, il ragamuffin sino al rap, visto come una nuova forma di canto sociale. Un passaggio importante è indicato nei primi anni novanta, quando si espande il movimento dei centri sociali e l’Istituto De Martino vive una crisi che lo porta quasi sull’orlo della chiusura a causa dell’indifferenza delle amministrazioni milanesi e lombarde, di tutti i colori politici, a trovargli una sede. Per la sopravvivenza dell’Istituto si impegnano anche i protagonisti della nuova scena musicale nata soprattutto nei centri sociali, Mau Mau, 99 Posse, Sud Sound System ecc. che affiancano gli studiosi, gli intellettuali i militanti politici e sindacali.
Proprio alcuni di tali gruppi, a cui si aggiungono gli Almamegretta, sono i protagonisti degli ultimi capitoli del testo.
Situazioni musicalmente e politicamente diverse: i 99 Posse, nati nel Centro Sociale Officina 99 di Napoli, assumono come orizzonte delle loro canzoni la nuova condizione giovanile meridionale, vissuta tra studi universitari di cui non si coglie a volte il senso, disoccupazione ed emarginazione, lotta antifascista. Vicini a loro geograficamente, ma con uno stile musicale diverso gli Almamegretta che contaminano alcune forme della tradizione campana con suggestioni vocali e mediorientali e suoni afroamericani.
Un discorso più complesso riguarda la riscoperta dei rituali del tarantismo da parte di diversi gruppi, soprattutto pugliesi e segnatamente salentini, e il fenomeno della “pizzica”. Come è noto, è stato soprattutto Georges Lapassade, sociologo ed etnologo francese, attivo in Salento negli anni novanta, a introdurre l’idea di una continuità tra l’attività del Sud Sound System e la terapia tradizionale del tarantismo, concependo il tarantismo “come un progetto vivo di trasformazione della vita quotidiana e della socialità in nome di una festosa danza catartica” (pag. 159).
Un’assimilazione che al di là di facili generalizzazioni musicali e ideologiche si mostra poco lecita poiché nel tarantismo la musica era usata per uscire dalla trance e per controllarla, mentre nelle musiche contemporanee ha esattamente la funzione contraria, associandosi appunto a momenti di danza catartica che fanno “sballare”.
Personalmente, mi sembra anche di poter aggiungere che nel tarantismo esisteva un definito orizzonte simbolico, quello del morso della taranta, che offriva un mito di riferimento al rito terapeutico – musicale mentre nelle musiche che si vorrebbero continuatrici di tale tradizione si ha solo un riferimento allo sviluppo di una socialità giovanile abbastanza confusa. Il merito del Sud Sound System sta quindi soprattutto nel tentativo di creare un rap italiano che si ponga in continuità, questa si, con la musica italiana di tradizione orale e sulla riscoperta delle tradizioni locali più che svilupparsi su basi campionate e sull’imitazione di radici giamaicane e del Bronx.
Molti altri sono i motivi d’interesse del libro di Fanelli che meriterebbero di essere discussi in una sede più adeguata, ma mi preme sottolineare la prospettiva che l’autore indica nelle ultime pagine. Tale prospettiva è quella di una necessaria ricerca da condurre sulle musiche dei migranti in Italia, un lavoro etnografico e anche politico che ancora stenta a prendere forma, ma che può aprire a nuovi scenari.
Riprendendo alcune osservazioni di Alessandro Portelli l’autore ci propone l’idea che la ricerca sulle musiche dei migranti non siano da studiare tanto sul metro della fedeltà all’origine quanto su quello della loro funzione nel luogo d’arrivo. Questa mi sembra un’indicazione interessante, poiché pone il problema della ri – contestualizzazione delle musiche, del significato che esse assumono in situazioni sociali diverse da quelle della loro origine. E, in definitiva, risponde a quanto già Portelli scrive nella prefazione al libro, cioè che un canto diventa sociale in relazione alla sua funzione in un contesto dato e in una situazione determinata prima ancora che per il suo testo o la sua musica.
In queste ultime considerazioni sta forse il pregio maggiore del testo di Fanelli, che è quello di far crescere la motivazione a scoprire e ricercare aprendo nuove prospettive pur saldamente ancorate alla tradizione di ricerca politica e sociale dell’ultimo secolo.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa




