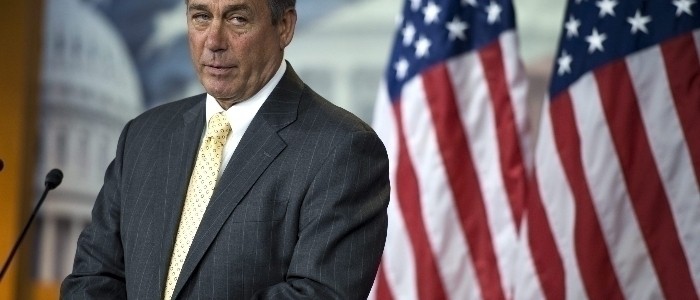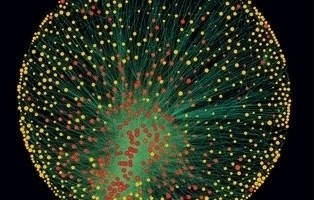Ovvero per la “sfera” più distante dai “teatrini” eurpei e soprattutto italiani. Ovvero nel punto considerato di massima forza per gli Usa, stato federale che “non deve mettere d’accordo 17 governi, 17 sistemi fiscali, 17 politiche economiche”; anzi, per il paese “che quando c’è una crisi si compatta come un sol uomo senza che nessuno debba ricordarglielo”.
Naturalmente, bisgna sapere che gli Usa sono anche il paese più indebitato del mondo e che finora ha potuto scaricare sul resto del pianeta i propri problemi grazie alla possibilità di stampare dollari a volontà senza che questi perdessero per questo valore (carta contro cose, che pacchia!) e, altrettanto naturalmente, alla forza militare. Sembra proprio che tutti e tre questi pilastri dell’unica iperpotenza rimasta stiano sgretolandosi sotto i colpi di maglio della crisi. E la politica ci arriva obbligatoriamente per prima.
Come titolava ieri sera la Cnn, alterando significativamente i lead d’apertura, “Chi paga?” oppure “Non è il 2008, o sì?”
Un test di credibilità fallito per John Boehner e per i repubblicani che, sempre più ostaggio dei Tea Party anti-tasse, saltano un appuntamento importante: il voto alla camera sul piano sull’aumento del tetto del debito di Boehner.
Un altro passo avenati verso l’impensabile default degli Stati Uniti. E la cosa stupefacente – per gli osservatori che da questa parte dell’Atlantico continuano a indicare quel paese come esempio – è che sta accadendo per problemi solo politici.
Il successo del voto mancato era ritenuto da molti osservatori cruciale per la credibilità di Boehner come speaker, invece si è dimostrato una battaglia fra lo speaker e i Tea Party che lo hanno nominato: a guidare la rivolta interna al partito gli ultra-conservatori è Michele Bachmann, che punta a un ruolo maggiore ed è candidata alle presidenziali 2012. Molti repubblicani non ritengono il mancato voto un fallimento, ma un voler mettere Boehner nella posizione più forte possibile per trattare con il presidente Barack Obama e il leader dei democratici in Senato, Harry Reid, che dietro le quinte starebbe lavorando a un piano alternativo con il leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell.
Le difficoltà di Boehner si ripercuotono anche sulla Casa Bianca: Obama e Boehner, anche se diversi, sono riusciti a creare un rapporto di lavoro efficace, che li ha portati a un passo da un ampio accordo per l’aumento del tetto del debito. Il team di Boehner le ha provate tutte per conquistare i voti necessari e mostrare ai democratici e al presidente barack Obama la forza del partito.
All’appello, alla fine di una giornata convulsa, sono mancati pochi voti. le difficoltà interne erano già emerse nei giorni scorsi, quando il voto in programma alla camera per mercoledì era stato rinvitato. Boehner nell’intera giornata di giovedì si è mostrato fiducioso ed ha convocato il voto per le 18.00. L’annuncio dello slittamento è arrivato una mezz’ora prima, ma lo staff dello speaker della camera ha immediatamente evidenziato che un voto in serata ci sarebbe stato. Alle 22.30 l’annuncio di Mitch McCarthy: la camera non voterà.
Lo speaker della camera John Boehner scivola dunque sui Tea Party in uno degli appuntamenti più importanti. Il movimento anti-tasse ha guidato la ribellione interna ai repubblicani gettandoli nel caos: dopo aver aiutato il partito a vincere le elezioni, ora sembra tenerlo in ostaggio dettando la linea da seguire.
Le due eroine del movimento, Michele Bachmann e l’ex governatrice dell’Alaska Sarah Palin, sono state fin dall’inizio tutte e due contrarie al piano sulla riduzione del deficit e del debito di Boehner. E tutte e due hanno aspirazioni più alte e sono in grado di influenzare e dettare legge nel partito. Qualche ora prima del clamoroso non voto alla Camera sul piano Boehner, Palin ha richiamato i ‘freshman’, i neo-eletti dei repubblicani, per spingerli implicitamente a far mancare il loro voto al testo di Boehner. E al suo richiamo ha ricevuto una risposta chiara: a Boehner sono mancati proprio i voti dei freshmen. Un dettaglio che fa capire quanto conti la Palin e in genere gli ultras anti-tasse all’interno del disastrato Grand Old Party.
Nel suo messaggio, la Palin ricorda a ognuno di questi parlamentari eletti alle ultime elezioni di medio-termine il senso di quella «vittoria storica», conseguita «grazie all’attivismo e al senso comune dei Patrioti». Poi ricorda loro «quali interessi sono andati a rappresentare una volta mandati a Washington dc». Infine, conclude il messaggio con un post scriptum vagamente minatorio: «Tutti quelli con cui parlo mi dicono di credere che le primarie saranno molto aperte».
Il movimento dei Tea Party prende il nome dalla rivolta dei primi coloni che nel 1773 scaricarono il tè nel porto di Boston per protestare contro le tasse imposte dal governo britannico. È nato la primavera nel 2009, dopo l’insediamento di Obama alla Casa Bianca, tenuto a battesimo dal giornalista della Cnbc, Rick Santelli che sparò a zero dalla Borsa Merci di Chicago sul salvataggio delle banche chiedendo alle masse di organizzarsi in proteste spontanee.
Della serie: le crisi sono occasioni da giocare, e naturalmente anche i reazionari giocano. Anzi, in genere sono i primi a muoversi. Ai compagni non resta che svegliarsi e uscire dal letargo del post-’89. Non è più tempo di “osservare” il mondo per capirlo, ma di agire a livello di massa per cambiarlo!
Sui Tea Party, intanto, riportiamo una spiritosa scheda dell’Ansa, giocata sul parallelo con i leghisti di casa nostra.
Non sopportano “Washington ladrona”. Tantomeno il palazzo, l’establishment di Capitol Hill, pieno di “parassitì di destra e di sinistra”, venduti alle lobby, alla Borsa e alle multinazionali, che vivono alle spalle dei contribuenti pensando solo a farsi rieleggere.
Ma il loro bersaglio principale, il motivo per cui sono nati, è Barack Obama, lo statalista, «l’ideologo socialista», il simbolo di quell’America multiculturale che loro vedono come una deviazione perversa del sogno americano. Accanto al presidente, le sue riforme, per cui non sono disposti a pagare un solo dollaro di nuove tasse per metterle in atto.
Sono gli uomini e le donne del Tea Patriot Party, una realtà a metà tra il movimento di protesta e il gruppo politico che da anni agita e condiziona la politica americana. Dopo l’esordio di piazza nell’estate 2009, attorno al Campidoglio, nel febbraio 2010 si sono riuniti alla Convention di Nashville per decidere cosa sono e cosa vogliono fare da grandi. Magmatici, a volte ingenui nelle loro idee guida, a unirli è la protesta, estremista e intransigente, amplificata dalle stelle della Fox. Per capire i loro toni basta leggere uno dei seminari in programma a Nashville, dedicato alle «connessioni tra l’amministrazione Obama e le dittature marxiste dell’America latina degli anni ’70», come dire Barack e Pinochet (e qui il notista dell’Ansa si rivela particolarmente a digiuno di storia recente!!), due statisti a confronto. Aperto dibattito.
Antistatalisti convinti, fortemente federalisti, antigay e anti immigrati, sembrano una Lega in salsa americana. Raccolgono le paure di un ceto medio composto di ‘small business’, il nostro popolo delle partite Iva, terrorizzato dalle politiche sociali della nuova amministrazione, che teme come il demonio la globalizzazione. Nel contestare apertamente il fisco federale, si rifanno ai primi americani che nel 1773 scatenarono la rivolta contro l’oppressore inglese gettando casse di tè nel porto di Boston. La loro scelta di vestirsi come i soldati della prima unione delle colonie americane, ricorda un pò quel folklore di chi a Pontida si veste da Alberto da Giussano.
La loro terra promessa, la loro Padania, è un America chiusa, bianca, autoreferenziale e felice di esserlo. Un pò quella del Midwest, fortemente repressa bigotta e puritana, lontana anni luce dall’elegante e sofisticata east coast. Il loro “celodurismo” lo testimoniano battendosi contro ogni forma di unione civile tra omosessuali. Nessuno di loro ha frequentato le migliori università dell’Ivy league (il notista dell’Ansa ha passioni “di classe” decisamente aristocatiche e guarda dunque con un po’ di saccente disprezzo questi parvenu della politica…)..
Sull’onda dell’entusiasmo e della mobilitazione, hanno trionfato alle ultime elezioni di medio-termine spedendo a Washington una pattuglia di parlamentari pronti a farsi sentire. Gli stessi che hanno silurato lo Speaker John Boehner e il suo piano per uscire dallo stallo sul debito. Il loro ‘senatur’, un leader unico carismatico che possa indicare la linea politica, ufficialmente ancora non c’è. Sicuramente considerano Sarah Palin e il suo clone Michelle Bachmann, due di loro. Ed è certo che dopo aver conquistato la ‘golden share” del Grand Old Party a Capitol Hill, faranno sentire la loro voce anche alle prossime primarie in vista delle presidenziali del 2012.
*****
tornando alle cose serie, ecco il terrore negli occhi della stampa padrnale.
da IlSole24Ore
Spaccatura insanabile tra leadership repubblicana e Tea Party
dal nostro corrispondente Mario Platero
NEW YORK – L’accordo è sfumato. Sfiduciato, stanco, sconfitto, John Boehner, l’ex uomo forte del partito repubblicano ha gettato la spugna: nella notte, pochi minuti prima di un voto che sembrava scontato alla Camera, ormai più vicini alla chiusura dell’epica battaglia sul bilancio, con un copione già scritto da qui a lunedì per evitare il default tecnico del governo americano, l’agenda è cambiata. Si è cominciato a votare sui nomi di nuovi uffici postali nell’Illinois.
In quel momento si è capito che la spaccatura fra leadership repubblicana e Tea Parties era insanabile. Si è capito che il Paese sarebbe di nuovo precipitato nell’incertezza. Che la parola data da Boehner ai grandi di Wall Street pochi giorni prima («Non ci sarà default»), che noi stessi abbiamo riferito, era priva di significato e che il «fallimento» tecnico degli Stati Uniti d’America tornava a essere possibile. I grandi finanzieri a New York si sono così trovati nella condizione che più li preoccupa, quella dell’incertezza, della mancanza di un punto di riferimento per capire lo sviluppo delle cose. Con Wall Street che attende con ansia l’apertura, fra poche ore, dopo che tutte le borse asiatiche hanno già reagito con movimenti al ribasso fra lo 0,50% e l’1%.
Il copione era complesso. Prevedeva il passaggio alla Camera di un piano mediocre che rispondeva alle preoccupazioni della destra conservatrice: tenere duro sul fronte delle concessioni. Il piano “salva faccia” della destra repubblicana sarebbe giunto al Senato per essere bocciato dalla maggioranza democratica.
Il Senato avrebbe rispolverato e approvato invece un piano “bipartisan” da inviare alla Camera che superava gli ostacoli politici, si accontentava di tagli più contenuti, ma innalzava il tetto sul debito per andare avanti fino a dopo le elezioni dell’anno prossimo. Ma gli irriducibili dei Tea Parties non ci sono stati. Non sono venuti a Washington per rifare i vecchi minuetti dei giochi delle parti. E mentre Boehner cercava di corrompere davanti a pizze fumanti ordinate in scatole di cartone consegnate nel suo ufficio alcuni irriducibili come Trent Franks e Jeff Flake, dell’Arizona, Chuck Fleischmann, del Tennessee, Randy Hultgren e Joe Walsh dell’Illinois, Mo Brooks dell’Alabama, Louie Gohmert del Texas o Tim Scott dell Carolina del Sud, il braccio armato di queste matricole del Tea Party, il movimento “Freedom Works” lanciava messaggi su Twitter: “voteremo no”. “Il mio voto? Resterà un “bloody”, un “maledetto” no, diceva Gohmert nel suo strascicato accento texano mentre usciva dall’ufficio di Boehner con il formaggio che ancora gli colava sull’angolo della bocca.
La palla ora passa forse al Senato. Si cercherà di tornare alla ragionevolezza. Di lavorare per un compromesso bipartisan che possa raccogliere anche i voti dei democratici alla Camera. Di certo non c’è più bussola a Washington. La Casa Bianca che si era tenuta ai margini in queste ore è sbigottita. Il Presidente Barack Obama impotente. Il Presidente della Camera impotente. E dire che i due appena un mese fa credevano di aver suggellato un accordo, un percorso politico, durante una partita a golf giocata in un sabato d’inizio estate a Washington, alla Edwards Air Force Base, come si faceva ai vecchi tempi. Poi il castello è crollato. E ora si attendono altri sviluppi. Si dice che il Downgrading del rischio America potrebbe venire già oggi, tanto per aggiungere un nuovo elemento storico – sarebbe la prima volta – a una battaglia caotica davvero senza precedenti. Che capiti proprio in quest’anno, in cui ci selebra il 150° anniversario dell’inizio dela Guerra Civile, è solo un altro aspetto evocativo di quanto marcata sia la svolta politica con cui si sta confrontando l’America del 2011.
*****
È figlia di Reagan quella voragine pari al 140% del Pil
di Marco Margiocco
Il debito pubblico americano, più che conseguenza della crisi finanziaria del 2008, è figlio primogenito dell’ottimismo reaganiano, e dei suoi eredi. È un problema serio da un quarto di secolo e drammatico da almeno due anni. Ben prima del duro scontro di questi giorni sull’innalzamento del tetto legale.
C’è una certa confusione e persino l’Economist può farla, parlando di un debito al 65% del Pil una volta (il 9 luglio 2011), del 92% un’altra (il 28 aprile). Per chiarezza è bene partire, arrotondando, dai 14.500 miliardi di dollari per il debito federale totale (Total public debt). Si passa a 17.500 aggiungendo il debito di Stati ed enti locali, e poi a 20.500 con tutte le garanzie non direttamente iscritte a bilancio che Washington con la crisi ha dovuto assicurare, essenzialmente al sistema della finanza immobiliare pubblica. Le percentuali dicono che il Total public debt sarà presto al 100% del Pil. Al 120 con Stati ed enti locali. Al 140% con la finanza immobiliare.
Il 65% dell’Economist, in realtà al momento più vicino al 67%, è la cosiddetta quota held by the public, una parte del Total public debt. Con held by the public si indicano tutti i detentori, residenti e non, persone fisiche e giuridiche, Federal Reserve compresa, ad eccezione del debito detenuto da enti dell’Esecutivo. Fino a non molto tempo fa era quella dello held by the public la cifra corrente. Ma è altamente riduttiva. Occorre sommare infatti per arrivare al Total public debt i 4.600 miliardi, pari a circa il 32% del Pil, di titoli non negoziabili del Tesoro detenuti da varie entità dell’Esecutivo. Oggi, come precisa il Gao (Government accountability office), si tratta di debiti del Tesoro che vanno conteggiati. Si arriva quindi a ridosso del 100 per cento.
Mancano poi i circa 3mila del debito statale e locale, 2.450 miliardi a gennaio, ma con diverse partite off balance. E mancano le garanzie per la finanza immobiliare pubblica, i giganti Fannie e Freddie soprattutto, ma non solo. Fannie e Freddie hanno collocato ai quattro venti obbligazioni per 1.700 miliardi e garantiscono i rendimenti per altri 5.500 miliardi di titoli cartolarizzati e in parte notevole venduti agli angoli della Terra. Washington deve garantire per quel 25% circa di mutuatari che non paga o non pagherà più. Da qui, pur tenendo conto che dietro c’è un quarto del patrimonio abitativo americano, circa 3 mila miliardi (1.700 di obbligazioni più 1.300) da accollare al debito pubblico, con un calcolo molto favorevole. E siamo ad altri 3mila miliardi che portano il totale a 20.500, cioè a poco meno del 140% del Pil.
Le tre presidenze più prodighe sono state quelle di Ronald Reagan, di George W. Bush e, suo malgrado, di Barack Obama, ma cruciale è la prima per l’origine del disastro. Reagan prometteva uno stato dimagrito, ma diminuivano solo le tasse, non le spese. «La rivoluzione reaganiana arrivava presto a essere un incauto esercizio di economia del pasto gratis. E presto, il gigantesco errore di politica fiscale che veniva scatenato a spese dell’economia nazionale e mondiale diventava insanabile», scriveva nel 1986, 25 anni fa cioè, David Stockman, fino a un anno prima ministro del Bilancio, e testimone diretto di un sistema che colmava i vuoti col debito. Reagan, che a differenza di Bush figlio le tasse le alzò anche, trovò un debito (Total public debt) al 32% del Pil e lo lasciò al 53%, Bush figlio partì dal 56% per arrivare all’82% con una media di oltre 500 miliardi l’anno. Obama, causa crisi e crollo del gettito soprattutto, ha triplicato la velocità, portandola a 1.500 miliardi di debito in più all’anno, grossomodo.
Stockman, a 65 anni, è tornato sulla scena come analista, e ha per uscire dalla crisi una ricetta chiara, ma dura: ritorno a un fisco pesante, imposta sulle transazioni, Iva, pensione e sanità inversamente proporzionali al reddito. Non c’è scampo, dice.
E Bill Clinton? Clinton è l’eccezione perché aiutato da un decennio felice ridusse il debito, dal 66 al 56%, con un taglio di quasi 1.500 miliardi. Ma c’è una postilla da fare. La riduzione del debito fu il capolavoro del ministro del Tesoro Robert Rubin, deciso a dimostrare che l’America sapeva governare la spesa e quindi Wall Street restava il cuore della finanza mondiale. Rubin veniva da Wall Street, dove sarebbe tornato, e oltre al risanamento del bilancio curò con particolare forza la deregulation e l’abbattimento delle regole finanziarie. Wall Street trionfava, guadagnava cifre mai viste, si suicidava. E il bilancio pubblico doveva alla fine raccogliere i cocci. Fanno 70mila dollari di debito pubblico a testa per ogni americano, quasi il doppio dei 39mila che pesano su ogni italiano. Che poi Reagan risulti nella maggior parte dei sondaggi il presidente più popolare dell’ultimo secolo è un altro elemento di riflessione.
*****
Wall Street: evitare il default
dal nostro inviato Marco Valsania
La Camera americana ieri notte si apprestava a votare il piano repubblicano sul debito messo a punto dallo speaker John Boehner, ma le possibilità di scongiurare un default degli Stati Uniti sono rimaste affidate anzitutto a negoziati dietro le quinte. I democratici hanno ribadito che l’ultima proposta dei repubblicani, anche se approvata dalla Camera, sarà bocciata dal Senato. Il ventaglio di ipotesi che i leader dei due partiti e la Casa Bianca esamineranno nelle prossime ore, secondo indiscrezioni, comprenderà modifiche o combinazioni del progetto Boehner e di quello del senatore democratico Harry Reid. Come più limitate misure di “stopgap”, provvedimenti provvisori che alzino il tetto del debito per il tempo indispensabile a completare un accordo.
L’urgenza, con il possibile default del 2 agosto alle porte, ha visto ieri la mobilitazione dell’alta finanza, che si è scagliata contro i politici e la Federal Reserve. Una lettera è stata spedita a Casa Bianca e Congresso a firma degli amministratori delegati dei colossi di Wall Street, da Lloyd Blankfein di Goldman Sachs a Jamie Dimon di Jp Morgan, da Brian Moynihan di Bank of America a Vikram Pandit di Citigroup. Un’intesa, hanno scritto, deve arrivare in settimana, perché «un default, o un declassamento del rating sul credito, rappresenterebbe un tremendo colpo alla fiducia di aziende e investitori, alzando i tassi di interesse per tutti, minando il dollaro e scuotendo mercati azionari e obbligazionari – peggiorando cioè drasticamente le già difficili circostanze economiche del Paese». Credit Suisse, da parte sua, ha definito un default improbabile ma ha ammonito che provocherebbe una contrazione del 5% nell’economia e crolli del 30% nelle azioni.
Le banche hanno anche premuto sulla Fed, accusata di troppa reticenza nel discutere con il settore privato le ripercussioni di scenari di default o riduzione del rating. In realtà la Banca centrale probabilmente teme di dare credibililtà a simili ipotesi, aumentando il nervosismo. Forse in risposta alle critiche, però, il Tesoro ha fatto sapere che rivelerà in questi giorni la strategia per i pagamenti federali – 100 milioni ogni mese – in caso di mancato superamento dell’impasse. E che la Fed si assumerebbe il compito di monitorare e calmare le piazze finanziarie, assicurando che la liquidità sui mercati non venga meno. Per evitare shock globali gli operatori prevedono che la priorità nei pagamenti verrà data agli interessi sul debito.
Il piano Boehner aumenterebbe in due tempi il tetto del debito, subito di 900 miliardi, fra sei mesi di altri 1.600 dietro un nuovo voto del Congresso. Le sue probabilità di passaggio erano aumentate dopo che lo speaker aveva rafforzato l’iniziale pacchetto di tagli alla spesa, salito a 915 da 850 miliardi in dieci anni. Altri 1.800 miliardi di tagli scatterebbero con il secondo voto sul tetto del debito. La maggioranza democratica al Senato ha replicato immediatamente sottoscrivendo un impegno a respingere oggi in aula la misura. Il piano alternativo preparato da Reid, però, non pare abbia maggiori chance: alzerebbe subito il tetto del debito di 2.400 miliardi, necessari ad arrivare fino al 2013 come chiede l’amministrazione di Barack Obama, in cambio di altrettanti tagli, per metà legati alla fine delle guerre in Afghanistan e Iraq. Ma rischia di non avere sufficienti consensi neppure tra i senatori, dove servono 60 voti su cento per portarlo in aula.
Un’archiviazione dei due progetti potrebbe tuttavia aprire la strada a ulteriori negoziati. «In Congresso a volte accadono magie», ha detto Reid. Di sicuro il leader democratico ha mantenuto canali di comunicazione con il collega repubblicano del Senato Mitch McConnell.
*****
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa