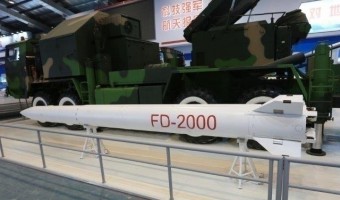Mentre si intensificano i raid turchi sul cantone, che piange già 180 vittime civili, Ankara strappa a Tillerson l’accordo: cacciare le forze curde dalle città del nord della Siria dove sono maggioranza della popolazione, stravolgendone la demografia.
Chiara Cruciati – il Manifesto
Roma, 17 febbraio 2018, Nena News – Mentre a Istanbul la magistratura post-epurazioni condannava al fine pena mai intellettuali e giornalisti, il segretario di Stato Usa Tillerson era ad Ankara per un incontro fiume con il presidente Erdogan e il ministro degli Esteri Cavusoglu: sul tavolo la questione curdo-siriana, Afrin, e la necessità di una exit strategy che salvi la faccia agli Stati uniti.
Un meeting affatto facile (così a porte chiuse che era Cavusoglu a fare da traduttore al presidente) da cui è trapelato ben poco, se non il comunicato finale ripulito della faida che caratterizza da mesi l’alleanza in bilico tra i due principali eserciti della Nato.
La fine era scontata: Washington molla i curdi (realtà già palese dal 20 gennaio, inizio dell’operazione turca sul cantone di Afrin) e accetta di «stabilire meccanismi» entro marzo per gestire il nord della Siria evitando lo scontro diretto.
Al centro del confronto diplomatico c’è Manbij, distretto di Aleppo, liberata nel 2016 dal giogo Isis da quello che era l’embrione delle Forze Democratiche Siriane (Sdf), combattenti di diverse etnie e confessioni guidati dalle Ypg/Ypj curde e simbolo della multiculturalità siriana.
Erdogan non ha mai nascosto di voler occupare Manbij, prossimo target dopo Afrin. È lì però che stazionano da mesi 2mila marines che non solo addestrano le Sdf ma che hanno preso parte più o meno direttamente alla liberazione di Raqqa.
A Tillerson Ankara avrebbe strappato l’impegno a far ritirare le forze curde da Manbij per stabilirsi a est dell’Eufrate, vecchia linea rossa tracciata unilateralmente dalla Turchia. A quel punto truppe statunitensi e turche sarebbero dispiegate nella zona.
Non solo Manbij, però: le Ypg/Ypj dovrebbe abbandonare anche Afrin, cantone nell’estremo ovest di Rojava, che però è curdo di suo. «Ritirarsi», vista la composizione della popolazione a stragrande maggioranza curda, significherebbe modificare la demografia locale e distruggere il progetto confederale democratico di Rojava, che escludente sul piano etnico-confessionale non lo è affatto. Difficile immaginare che i curdi si pieghino ai diktat di Erdogan.
Il cantone intanto resta sotto i pesanti bombardamenti turchi e i colpi di artiglieria dell’appendice di Ankara, unità dell’Esercito Libero e islamisti di varie formazioni anti-Assad attive ad Idlib. A 26 giorni dal lancio di «Ramo d’Ulivo» l’Information Center of Afrin Resistance calcola almeno 180 civili uccisi e 480 feriti in 668 raid aerei e 4.645 missili lanciati dall’artiglieria pesante.
Oltre 200 case sono state distrutte, insieme a 27 scuole, fattorie, ospedali, cimiteri, moschee, forni, siti di purificazione dell’acqua del villaggio di Metina e del distretto di Jinderese, una fabbrica di olio e (dopo il prezioso tempio di Ain Dara) altri siti archeologici, il tempio di Nebi Hori e il castello di Kalote. Colpita anche la sede della Mezzaluna di Afrin.
- da il manifesto del 18 febbraio 2018
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa