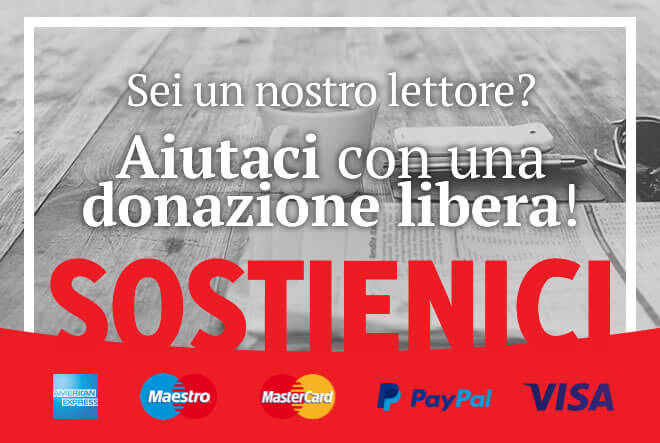Il 13 gennaio, i taiwanesi hanno eletto presidente Lai, ma in parlamento il suo partito – il Partito Democratico Progressista (DPP) – ha perso la maggioranza, ottenendo solo 51 seggi contro i 52 del Kuomintang (KMT), favorevole al rilancio degli scambi commerciali con la Cina.
Questa forma di difficile coabitazione è una delle contraddizioni particolari del complesso gioco politico tra Pechino e Taipei in un oscillazione del pendolo delle relazioni che vanno dalla “distensione” all’“inasprimento”.
Lo scopo del viaggio in Cina dell’ex presidente del KMT, Ma Ying-jeou, all’inizio di aprile, durante il quale è stato ricevuto da Xi Jinping, e poi, alla fine di aprile, da diciassette deputati del KMT, tra cui il loro capogruppo parlamentare, andava nella direzione della “distensione” e di una continuità di rapporti.
Questa divisione tra potere esecutivo e legislativo potrebbe rallentare i preparativi militari dell’isola, dato che il KMT ha tutte le possibilità di bloccare i bilanci della difesa per la modernizzazione dell’armamento, giudicandoli troppo provocatori nei confronti di Pechino.
Allo stesso tempo dà a Pechino un argomento per considerare che il percorso politico non è arrivato ad un binario morto e permette di indebolire l’oostile DPP e sognare che il KMT torni un giorno al potere.
Dall’altra parte però vi è l’atteggiamento dell’attuale esecutivo spalleggiato da Washington.
Le provocazioni del nuovo presidente di Taiwan
Il nuovo presidente di Taiwan, Lai Ching-te, durante il suo discorso di insediamento del 20 maggio, ha esortato la Cina la Cina a “fermare le sue intimidazioni politiche e militari” e ha ringraziato il popolo taiwanese per aver resistito all’influenza di “forze esterne“. “L’era gloriosa della democrazia taiwanese è arrivata“, ha dichiarato.
Lai Ching-te succede a Tsai Ing-wen, i cui otto anni di mandato sono stati segnati da un deterioramento costante delle relazioni con Pechino. Lai ha prestato giuramento nel palazzo presidenziale di Taipei, insieme al nuovo vicepresidente, Hsiao Bi-khim.
Membro del Partito Democratico Progressista (PDP), lo stesso movimento del suo predecessore, Lai si è descritto in passato come un “architetto pragmatico dell’indipendenza di Taiwan”.
Da allora ha attenuato la sua retorica, difendendo il mantenimento dello statu quo nello Stretto di Taiwan e affermando ora che un processo di indipendenza non sia necessario, poiché l’isola, secondo lui, ha uno status de facto.
La sua schiettezza e la sua posizione gli sono valse le ire di Pechino, che lo ha bollato come un “pericoloso separatista” che sta portando Taiwan sulla strada della “guerra e del declino“.
Tra le 51 delegazioni internazionali invitate alla cerimonia di investitura (tra cui Stati Uniti, Giappone e Canada), otto capi di Stato sono stati invitati a mostrare il loro sostegno alla democrazia taiwanese. Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, si è congratulato domenica sera con Lai Ching-te, affermando che il suo insediamento è segno di un “sistema democratico resistente”.
In una dichiarazione, Blinken ha poi affermato di sperare che Taipei e Washington possano rafforzare le loro relazioni e mantenere “pace e stabilità” nella regione dello Stretto di Taiwan. “Ci congratuliamo inoltre con il popolo taiwanese per aver dimostrato ancora una volta la forza del suo sistema democratico solido e resistente“, ha aggiunto.
Nonostante il sostegno degli Stati Uniti, Taiwan soffre della mancanza di riconoscimento diplomatico, con solo dodici alleati sulla scena internazionale. Un paria, insomma, ma che svolge la funzione di possibile perno degli interessi occidentali in quel quadrante.
Zugzwang nell’Indo-Pacifico?
I due mandati della presidente uscente di Taiwan, Tsai Ing-wen (2016-2024), sono stati piuttosto tesi con la Cina, ma non possono essere paragonati a quello che sta intraprendendo il suo successore, Lai Ching-te.
Dall’altra parte dello Stretto, il presidente cinese Xi Jinping ha promesso di collegare politicamente l’isola alla terraferma con mezzi pacifici se possibile, ma con la forza “se necessario”. Ripetuta costantemente, questa ambizione crea una sorta di obbligo ad agire.
Si potrebbe ricreare, nel contesto dell’Indo-Pacifico, quella situazione di Zugzwang – termine tedesco che significa “obbligato a muovere” – che abbiamo visto all’opera nel contesto medio-orientale. Negli scacchi, quest’espressione, si riferisce alla situazione in cui un giocatore, qualsiasi mossa faccia, si troverà in svantaggio nei confronti dell’avversario, e questo potrebbe essere vero sia per la Cina che per gli Stati Uniti.
Per la Cina, perché rappresenta una questione vitale di politica interna e il completamento di un riscatto plurisecolare; per gli Stati Uniti, non solo per questioni di politica esterna nell’Indo-Pacifico, ma di affidabilità complessiva di fronte ai proprii partner.
La questione di Taiwan risale ormai alla fine della guerra civile cinese, dopo la resistenza contro l’imperialismo nipponico culminata con la vittoria del PCC e la fondazione della Repubblica Popolare nel 1949.
La fuga dello sconfitto Chiang Kai-shek a Taiwan diede origine alla ‘coesistenza non pacificata’ di due entità che pretendevano di governare la Cina nel contesto della Guerra Fredda, inaugurata con il conflitto in Corea (1950-1953), dove si affrontarono direttamente volontari cinesi e truppe nordamericane.
Non si tratta quindi solo di una questione meramente geografica, ma anche storico-politica, in cui il Partito Comunista Cinese è per così dire costretto a chiudere il cerchio in qualche maniera.
Secondo Xi Jinping, questa missione storica “non può essere tramandata di generazione in generazione“. È un elemento centrale del grande “rinnovamento” cinese che ha giustificato la revoca del limite di due mandati presidenziali, nel 2018.
Si domanda Harold Thibault, corrispondente a Pechino per Le Monde: “Come può dunque un presidente onnipotente trascorrere tre, e probabilmente anche quattro, mandati al potere, cioè vent’anni, senza alcun risultato concreto sulla questione che viene presentata alla sua popolazione come la più decisiva? Questa è una constatazione preoccupante per i taiwanesi.”
In realtà si potrebbe riformulare la domanda in termini più corretti: “Come può la Cina permettere che le ingerenze statunitensi, e del blocco occidentale tutto, compresi attori politici che hanno condizionato negativamente la storia cinese – come Gran Bretagna e Giappone, tra gli altri – determinino una questione centrale di quella che è da sempre concepita come una questione di politica interna?”
Infatti, prima di lasciare il suo incarico nel 2021, il capo del Comando indo-pacifico degli Stati Uniti – Philip Davidson – ha dichiarato sostanzialmente al Congresso degli Stati Uniti che la “minaccia”, che già si era manifestata corso di questo decennio, diventerà reale nei prossimi sei anni, immaginando che la Cina volesse diventare militarmente in grado di invadere l’isola nel 2027.
Naturalmente essere in grado di fare una mossa del genere non vuol dire automaticamente metterla in atto, ma mutare i rapporti di forza per farli pesare sul piano politico.
Anche il suo successore al Comando ha ripetuto la stessa data. Ma secondo diversi media americani, tra cui la NBC, quando ha incontrato il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, a San Francisco nel novembre 2023, Xi Jinping ha detto che, pur avendo la Cina intenzione di riconquistare Taiwan, l'”opzione politica” era ancora preferita a quella militare e che i tempi non erano ancora stati decisi.
La questione dipende in larga misura dalla valutazione del rischio da parte di Xi e da chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca.
Xi ha incarnato una politica più assertiva nei confronti dell’Occidente e più risoluta nel sostenere il costo dei propri obiettivi politici, tutto questo assumendo un ruolo economico sempre più di rilievo: la quota della Cina nella produzione manifatturiera mondiale è passata dal 20% al 30% tra il 2012 e il 2021.
Il vero problema è che la strada politica preferita da Xi Jinping sembra essere chiusa in un contesto in cui la guerra è ridiventata strumento – non unilaterale – di risoluzione dei conflitti politici, e dove i capovolgimenti politici attraverso lo strumento militare si sono moltiplicati.
Tra lo scenario di una guerra guerreggiata e quello di un’inasprirsi costante della relazioni, ma senza giungere ad un “punto di rottura”, c’è un’intera gamma di gesti intermedi che potrebbero alzare la tensione senza necessariamente portare a una guerra totale.
Un esempio.
Nella piccola isola di Kinmen, che è sotto il controllo di Taiwan ma si trova a circa 4 chilometri dalla Cina continentale e a più di 130 chilometri dall’isola di Taiwan, la popolazione è molto favorevole al commercio con la Cina. Basterebbe un solo incidente e sarebbe da vedere se Taipei osasse mettere in campo tutte le sue forze per contendere un’isola così remota. Xi Jinping, invece, potrebbe già rivendicare una “svolta storica”.
Ma lo stesso si potrebbe dire rispetto alle continue provocazioni statunitensi al largo del Mar Cinese Orientale – tra cui l’invio di soldati proprio a Kinmen, con la qualifica di “istruttori” – che potrebbero portare a qualche incidente di rilevo in grado di alzare la temperatura politica oltre i livelli gestibili.
Le manovre militari cinesi
Dopo due giorni di tensione, questo fine settimana, la Cina ha annunciato la fine delle manovre militari su larga scala che stava conducendo intorno all’isola di Taiwan per dimostrare la sua opposizione ai progetti separatisti esposti dal nuovo presidente taiwanese, Lai Ching-te.
L’esercito cinese ha “completato con successo” le esercitazioni “United Glaive 2024A“, ha dichiarato un presentatore di CCTV-7, il canale televisivo statale cinese responsabile delle notizie militari, la sera di venerdì 24 maggio.
Navi da guerra, aerei, soldati e lanciamissili sono stati mobilitati per circondare Taiwan nell’ambito di queste manovre militari. Le esercitazioni hanno coinvolto le forze di terra, la marina, l’aeronautica e l’unità missilistica (responsabile dei missili strategici) e si sono svolte principalmente “nello Stretto di Taiwan, a nord, a sud e a est dell’isola di Taiwan“.
Sono avvenute anche nelle aree intorno alle isole di Kinmen, Matsu, Wuqiu e Dongyin, tutte nelle immediate vicinanze della costa orientale cinese.
La reazione – verbale – dell’esecutivo di Taiwan non si è fatta attendere.
Tali manovre sono una “flagrante provocazione all’ordine internazionale“, ha dichiarato sabato la portavoce della presidenza taiwanese. “La recente provocazione unilaterale della Cina non solo mina lo status quo della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan. È anche una palese provocazione dell’ordine internazionale, che solleva serie preoccupazioni e condanne da parte della comunità internazionale“, ha dichiarato Karen Kuo.
La Cina, come abbiamo ricordato, si è sentita particolarmente offesa da una delle dichiarazioni di Lai Ching-te, pronunciate lunedì durante il suo discorso di insediamento. Il presidente taiwanese ha affermato che “la Repubblica di Cina [Taiwan] e la Repubblica Popolare Cinese [la Cina continentale guidata dal Partito Comunista] non sono subordinate l’una all’altra“.
Pechino considera queste osservazioni come separatiste. “Da quando si è insediato, il leader della regione di Taiwan ha messo seriamente in discussione il principio di una sola Cina (…), il che sta spingendo i nostri compatrioti di Taiwan in una pericolosa situazione di guerra e pericolo“, ha dichiarato venerdì Wu Qian, portavoce del Ministero della Difesa. “Questo si chiama giocare con il fuoco, e coloro che giocano con il fuoco sono sicuri di bruciarsi“, ha avvertito.
“Ogni volta che [il movimento che promuove] l’indipendenza di Taiwan ci provoca, faremo un passo avanti con le nostre misure di ritorsione, fino alla completa riunificazione della madrepatria“, ha avvertito venerdì Wu Qian.
Bisogna ricordare che le precedenti manovre militari su larga scala della Cina intorno a Taiwan si erano svolte nell’agosto del 2023, dopo una visita negli Stati Uniti dell’allora vicepresidente Lai Ching-te. Pechino aveva effettuato esercitazioni di portata storica anche nell’agosto 2022, in seguito alla provocatoria visita sull’isola di Nancy Pelosi, allora presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.
Quella tra Cina e Taiwan si conferma una delle principali linee di faglia nello scontro tra blocchi geopolitici del mondo multipolare e potrebbe ulteriormente inasprirsi con l’arrivo di Trump alla Casa Bianca.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa