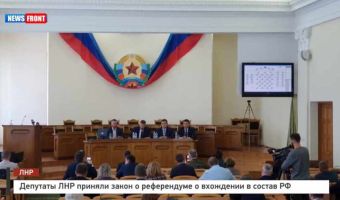Due analisi su temi molto diversi tra loro – gli squilibri Nord-Sud in Italia e la guerra dei dazi scatenata da Trump – affrontano esattamente lo stesso problema “sistemico”: le diseguaglianze di sviluppo territoriale (dunque anche sociale) sono alla base di problemi politici e geopolitici di prima grandezza.
Per quanto riguarda il nostro paese, Giuseppe Berta, sul confindustriale Sole24Ore, affronta e spiega le disuguaglianze elettorali con le relative differenze di modello produttivo.
Il Nord, in estrema sintesi, è agganciato strettamente alle economie (alle filiere produttive) dell’Europa tedesca, ma non è più differenziato al suo interno secondo le caratteristiche degli anni ‘90 (grandi imprese nell’Ovest, a partire dalla Fiat, e “piccolo è bello” nel Nordest). Anzi, la media impresa – o comunque impresa non egemone nel proprio comparto – è la norma, allargata ormai anche a parti consistenti dell’Emilia e del centro.
Il Sud, invece, ha perso o sta per finire di perdere anche quelle “cattedrali nel deserto” (è rimasta ormai soltanto l’Ilva di Taranto, oltre alla Fiat di Melfi) che avrebbero dovuto far da volano per un indotto mai nato davvero.
Ne conseguono due aspettative di sintesi politico-economica che non possono essere giustapposte (schematizzando molto: meno presenza dello Stato al Nord, più presenza nel Mezzogiorno), e che in buona misura spiegano le difficoltà a creare un governo comune Lega-Cinque Stelle. Le distanze si sono allargate a dismisura e nessuna visione unitaria del futuro è fin qui apparsa all’orizzonte. Anche lo strisciante trasferimento della “capitale di fatto” da Roma a Milano è allo stesso tempo un effetto di quelle disuguaglianze e un loro fattore di aggravamento, perché contribuisce a far piovere sempre più capitali da investimento nella parte del paese che già ne attira il 90%.
A questa dicotomia invalidante hanno dato un enorme contributo le politiche europee di austerità, che hanno favorito esattamente la stessa dinamica a livello continentale (con la Germania del ruolo del Nord e quasi tutto il resto d’Europa nella posizione del Mezzogiorno).
A bocce ferme – ossia secondo i trattati esistenti nella UE – questa polarizzazione è irrisolvibile perché utile a confermare il modello mercantilista tedesco (compressione salariale e del mercato interno per avere una capacità di esportazione più aggressiva).
Sul piano gobale, invece, Adriana Cerretelli minimizza – nei limiti del possibile – lo scontro Usa-UE sui dazi doganali, trovando un filo di interesse comune tra due sponde dell’Atlantico: il contrasto delle capacità egemoniche della Cina.
Se il discorso fosse limitabile al solo aspetto geopolitico – tra grandi potenze, nazionali o plurinazionali – filerebbe pure. Ma c’è un ma, grande quanto la crisi di egemonia Usa. La sola superpotenza rimasta dopo il crollo del Muro è infatti tutt’altro che nel pieno delle sue forze. Lo stesso ricorso al protezionismo più sgangherato (non solo su acciaio e alluminio, ma soprattutto sulle tecnologie informatiche) ha un carattere molto “difensivo” e tutt’altro che vincente.
Basta infatti ragionare sul fatto che i dazi sono un limite posto all’interscambio, dunque hanno effetti più o meno depressivi e comunque creano ostacoli sia sul piano dello sviluppo economico, sia su quello della “collaborazione” internazionale. E questo vale sa per gli Usa che per l’Unione Europea. Mentre al contrario la Cina è in grado di “allagare di liquidità da investimento” tutti quei paesi che vanno alla ricerca di relazioni internazionali meno improntate allo strozzinaggio.
Cosa lega le due dinamiche (quella nazionale e quella globale)? La fine del mito dei “ benefici illimitati del liberismo incontrollato”.
Non si tratta, nota giustamente Cerretelli, di una revisione “ideologica”, ma solo della presa d’atto che a via della “globalizzazione” ha prodotto alla lunga risultati inaccettabili per i paesi (le aree economiche) che ne erano stati i promotori. La delocalizzazione ha gonfiato i profitti delle multinazionali occidentali, ma ha svuotato di reddito disponibile le popolazioni (sempre occidentali); creando problemi enormi di gestione politica che hanno portato un Trump alla Casa Bianca e ventate “populiste” sempre meno arginabili senza cambiare indirizzo.
Quando le cose arrivano a questo punto (“Le cose si dissociano; il centro non può reggere”) nella Storia si danno poche alternative. L’emergere di una nuova visione più lungimirante, fondata su gambe robustissime (in pratica: un passaggio di ruolo egemonico da una potenza a un’altra), in grado di fare da “nuovo centro”. Oppure l’autonomizzazione delle parti, ovvero la competizione di tutti contro tutti (Usa, Unione Europea, Cina, Russia, in un vortice di alleanze che si fanno e si disfano continuamente).
Nelle parole del poeta (Yeats) questa situazione è descritta come “la pura anarchia si rovescia sul mondo”. Nella pratica del capitalismo reale, ahinoi, questa “anarchia” si presenta in genere come guerra.
*****
Risposte mirate per la nuova «Questione meridionale»
di Giuseppe Berta
La «questione meridionale» è tornata, dopo una lunga stasi, a sollecitare l’attenzione dei commentatori, a causa dei risultati elettorali che sembrano aver riportato al centro un carattere costitutivo della storia d’Italia. Si riaffaccia così l’immagine di un Paese che scorge nella polarizzazione fra Nord e Sud una sorta di costante della sua identità.
In realtà, una lettura di questo genere rischia di far da velo anche alla comprensione effettiva degli esiti delle elezioni politiche. Riscoprire la questione meridionale nei termini di un tempo rischia d’essere fuorviante.
Perché la base del dualismo italiano non assomiglia più per nulla a quella di un tempo, non solo nelle forme tratteggiate dal meridionalismo storico, ma nemmeno a quelle più recenti, che descrivevano un «miracolo economico» trainato dalle grandi imprese industriali del Nord cui affluivano gli imponenti flussi di forza-lavoro dal Mezzogiorno, tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta. Nel corso degli ultimi due decenni abbiamo invece assistito a una radicale mutazione che, in primo luogo, ha cambiato il profilo del Nord.
Anzitutto, quest’ultimo ha recuperato dei contorni più unitari, poiché è molto più vaga e incerta la distinzione fra le due macro aree del Nord Ovest e del Nord Est, che ha avuto grande successo, anche sul versante delle rappresentazioni politiche. Dov’è oggi, infatti, il Nord Ovest dominato dalla presenza delle grandi imprese di una volta? Da molte indagini, anche da quelle sulle economie regionali promosse dalla Banca d’Italia traspare il peso crescente delle imprese che hanno dimensioni intermedie, o che, se sono grandi per i criteri di classificazione, risultano invece occupare un ruolo intermedio nello spazio economico. D’altra parte, il Nord Est è adesso tutt’altro che il regno della piccola impresa, raccontato dalle cronache degli anni Ottanta ed esaltato dalle campagne politiche della Lega. Nord Est e Nord Ovest formano un invaso molto meno differenziato e dànno vita a una configurazione economica e imprenditoriale che trova alimento nell’Emilia e attraversa consistenti territori dell’Italia centrale. Se si vuole rintracciare un modello economico italiano valido per la nostra epoca, esso va rintracciato in una formazione economica e, in parte, sociale che si struttura nel nuovo blocco del Centro-Nord, in cui anche le appartenenze politiche tendono a essere molto meno nette del passato. Certo, il nuovo Nord ha un polo di convergenza riconoscibile in quella sorta di capitale di fatto che è Milano. La città pare ora voler sviluppare una funzione di leadership che in precedenza non ha cercato o voluto. Ma è chiaro che è il nuovo mix economico a dare risalto al suo ruolo, specie all’interno di un Paese smarrito com’è adesso il nostro.
A questa riconfigurazione del modello economico, e ancor più ai suoi processi di ricentraggio, il Mezzogiorno è rimasto estraneo. Con le conseguenze che ora possiamo osservare: nel suo complesso, l’economia italiana ne ricava un evidente effetto di debolezza, mentre la politica porta alla luce una domanda che è, al contempo, di cambiamento e di richiesta di intervento e di tutela. Quale può essere la reazione, nel Sud, alla notizia, riportata martedì scorso da questo giornale, che il 90% dei flussi d’investimento sollecitati da Industria 4.0 sono andati alle aree più forti del Paese? Ma sono i tanti segnali che fanno capire che i problemi vissuti dalla società meridionale sono affrontati con una logica differente da quella che s’impiega altrove: il caso dell’Ilva di Taranto, destinato presto a ritornare all’attenzione pubblica, ne è un esempio eloquente.
La governabilità dell’Italia non è soltanto messa a rischio da dinamiche della rappresentanza politica che stanno subendo un’accelerazione vertiginosa. Dipende in misura crescente dal venir meno dei legami d’integrazione tra la componente maggioritaria del Paese (che appunto sembra dar forma a un almeno embrionale “modello italiano”) e l’altra, quella meridionale e minoritaria, che sta diventando il luogo di massima condensazione dell’intero ventaglio delle nostre contraddizioni. L’esistenza di divari così gravi toglie ogni speranza che si possa arrivare a una sintesi politica. Non ci vuol molto a capire che essa non può venire dalla somma delle rivendicazioni politiche del Nord e del Sud. Forse solo Steve Bannon, l’ideologo della destra radicale di Trump che poco o nulla deve conoscere dell’Italia, può credere che la somma della “flat tax”, dall’abrogazione della legge pensionistica e del reddito di cittadinanza possa produrre quell’alleanza nazionalista in grado di abbattere Bruxelles e la moneta unica, com’è nei suoi auspici.
L’osservazione analitica della realtà italiana spinge invece in una direzione del tutto contraria, specie se si pensa che la deriva neo-nazionalista sia un pericolo. Occorre condurre una una rivisitazione delle politiche pubbliche, che vanno declinate in maniera diversa a seconda dei sistemi territoriali di riferimento. Il Paese ha sprecato un’occasione quando era di moda parlare di federalismo, un dibattito inconcludente che ha soltanto rimandato il momento di fare i conti con i problemi più urgenti. Se la politica vuole avere una chance di governare davvero l’Italia, per quella che essa è oggi, e di non disperdere tutte le proprie risorse alla ricerca di successi momentanei, è questa la via da perseguire.
******
In cerca di un nuovo ordine
di Adriana Cerretelli
Più crescita mondiale dice l’Ocse, 3,9% quest’anno e il prossimo, a patto che non esploda il protezionismo. Ma i venti di guerre commerciali e gli altolà agli investimenti cinesi in Occidente, la cronaca di questi giorni, sono solo protezionismo nudo e crudo o non invece il grimaldello di un sommovimento culturale?
Un sommovimento che fa i conti con il sistema del dopoguerra in frantumi e i contraccolpi della globalizzazione a ruota libera per ricostruire un nuovo ordine mondiale fatto di più equilibrio e meno Far West. L’interrogativo non ha una risposta immediata: arriverà solo quando la polvere delle attuali tensioni si sarà posata e se ne potranno misurare gli effetti concreti. Per ora colpisce un fatto paradossale: dietro i violenti scontri euro-americani si intravede una singolare ma sommersa unità di intenti. Che di fatto anima la comune politica di containment della Cina.
Tra Stati Uniti ed Europa oggi gli attriti appaiono insanabili. Impegnato nella campagna elettorale in Pennsylvania, Donald Trump sembra giocare a spararle sempre più grosse: non solo dazi imminenti sull’import di acciaio e alluminio da Ue, Canada e Giappone ma balzelli anche sulle auto tedesche, che pure sono ampiamente prodotte anche negli Stati Uniti.
L’Europa si prepara a rispondere prendendo in ostaggio quasi 3 miliardi di export Usa. Però prima di procedere aspetta le misure americane e continua a negoziare per ottenere sconti e ridurre i danni alla propria industria.
I segnali dalla Casa Bianca sono tanti e confusi: gli europei devono abbassare i dazi, agricoli in testa, aumentare i contributi alle spese militari in sede Nato, fare di più nei negoziati con la Cina per ridurne le enormi sovraccapacità produttive, prima di tutto nella siderurgia. Sono tutti i Leitmotiv dell’America First, dove però la supremazia suona più difensiva che offensiva, ansiosa di correzioni di squilibri mondiali consolidati più che di nuovi spazi di potenza da riempire. In fondo suona più europea che “gringa”.
Il parallelismo di interessi tra le sue sponde dell’Atlantico diventa più evidente se si guarda alle reazioni di Washington e Berlino di fronte alle scalate cinesi di imprese strategiche, il cui controllo rientra nella difesa della sicurezza nazionale.
Proprio perché avrebbe permesso alla Cina il sorpasso degli Stati Uniti nella tecnologia 5G, anticamera dell’intelligenza artificiale, Trump ha bloccato la scalata ostile di Broadcom al concorrente Qualcomm, n.2 americano nei semiconduttori, come aveva gia fatto nel 2017 con Lattice e prima di lui il presidente Barak Obama con Aixtron. Per le stesse ragioni il Congresso rafforzerà controlli e raggio di azione della potente commissione sugli investimenti esteri.
In Germania come in Europa le vulnerabilità sono maggiori perché le salvaguardie sono tradizionalmente minori. Anche se ora il modello americano sta diventando sempre più quello da imitare. Dopo aver digerito due anni fa lo shock della conquista di Kuka, il suo campione nella robotica, da parte della cinese Midea, Berlino ha subito in febbraio un colpo ancora più duro quando Geely è diventata con poco meno del 10% il maggior azionista di Daimler che controlla Mercedes-Benz, all’avanguardia nelle batterie per l’auto elettrica. Anche il n.1 nel capitale di Deutsche Bank è diventato cinese.
Per questo da liberista incrollabile la Germania ha cambiato verso: non solo si sta armando di difese più efficaci contro investimenti esteri ostili ma con Francia e Italia invoca una cintura di sicurezza anche europea. I timori dell’Unione vanno ormai oltre quelli della sistematica rapina delle sue supertecnologie destinate a foraggiare il Made in China 2025, il programma industriale per fare della Cina il numero 1 del mondo nel manifatturiero di punta. Passano per le intrusioni in casa propria che dividono e condizionano i partner Ue sommersi e comprati dagli investimenti a pioggia per costruire le infrastrutture della nuova Via della Seta, dai vertici annuali del gruppo 16+1 che lega a doppio filo Pechino con i paesi dell’Est e dei Balcani, di cui 11 Ue. Il tutto mentre da anni Bruxelles tenta invano di strappare a Pechino un accordo sugli investimenti che ne abbatta le troppe barriere.
Tutto protezionismo? Certo, la spirale di ritorsioni e contro-ritorsioni è dietro l’angolo. Per tutti. Ed è molto stretto e accidentato il sentiero per rifare un ordine mondiale più equo ed equilibrato per tutti. Ma è un rischio da correre. Se Stati Uniti ed Europa si stanno ricredendo sui benefici illimitati del liberismo incontrollato non è per sconfessione ideologica ma perché sono stufi di vederlo strumentalizzato da concorrenti spregiudicati che lo usano per giocare con le carte truccate.. Per ora commerciale, certo…
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa