Bisogna saper riconoscere i capolavori. E questo di Carlo De Benedetti, padrone del gruppo L’Espresso e quindi di Repubblica, tessera numero uno del Pd e affossatore dell’Olivetti che aveva preso in mano quando era ancora una delle quattro big dell’informatica globale (insieme a Ibm, Honeywell e Bull), è un capolavoro.
A sua insaputa, naturalmente.
In un paio di paginette, pubblicate nel suo blog sull’Huffington Post italiano. De Benedetti concentra tutti i luoghi comuni dell’ideologia neoliberista e, contemporaneamente, il proprio terrore per le logiche conseguenze di questi topoi quando scendono dal cielo dell’ideologia per diventare prassi. O meglio: quando “la concorrenza”, osannata finché sei il più forte o quasi in un certo mercato, non ti presenta davanti qualcuno enormemente più concorrenziale di te.
Sia chiaro: le paure di De Benedetti davanti all’avanzare inarrestabile di Google come soggetto editoriale globale, capace di stroncare qualsiasi altro soggetto creatore di contenuti pur non creandone alcuno in proprio è reale e condivisibile da qualsiasi individuo sano di mente. L’assurdità – dal punto di vista di un cantore e beneficiario delle “virtù” del capitalismo privo di vincoli – è che sia sia lui a esprimerla con tanta forza. Abbassando un po’ il livello, è come se Ichino o Sacconi o Poletti si lamentassero di esser stati assunti con contratti a termine e pagati 500 euro al mese…
Detto questo, il percorso logico di De Benedetti è tragicomico. Parte col peana a Dopfner, giovane e rampantissimo dirigente editoriale tedesco, capace di issarsi a meno di 40 anni al vertice di un colosso come Springer. Per descriverlo, subito dopo , come un “davide” davanti al golia Google… Lo stesso Dopfner è prigioniero dell’identica sindrome, perché nella sua lettera che “lancia l’allarme” è costretto a dichiarare la sua “ammirazione” per il gruppo di Mountain View. Capitalisticamente parlando non può fare altro che riconoscere l’immensa capacità di Schmidt e Brin di “creare valore per gli azionisti” (unico obiettivo obbligatorio riconosciuto all’impresa negli ultimi trenta anni). Salvo poi lamentarsi del fatto che questa straordinaria abilità significa una riduzione drastica della propria capacità di “creare valore per gli azionisti” quando ci si trova a “competere” con Google nello stesso settore. O, come dice De Benedetti, “se non lavori con loro, in alcuni casi non lavori affatto”.
Un dato interessante, citato en passant, è la sproporzione assoluta – esistente ormai in determinati comparti hitech – tra fatturato e occupazione (50.000 dipendenti contro 60 miliardi di dollari). Il che dovrebbe allarmare tutti quegli aspiranti “consiglieri del principe” che teorizzano la possibilità di “uscire dalla crisi” con una limitata iniezione di investimenti (pubblici, dato che di privati “nazionali”, a partire da De Benedetti, non se ne vedono). L’innovazione tecnologica – o l’aumento della composizione organica del capitale – è arrivata al punto che per creare un posto di lavoro capitalisticamente “vero” occorre investire una massa di capitale fisso enormemente superiore a quella di poche decine di anni fa. Le uniche eccezioni alla regola vengono appunto da ex start up di successo, come Google, che prevalgono nella competizione in un settore per alcuni anni “vergine” come l’informatica. Il segreto del successo nell’informatica sta nella possibilità di “vendere” un prodotto (dal costo di produzione in fondo abbastanza basso) in un numero pressoché illimitato di copie (il “modello Microsoft, per molti anni, che imponeva contrattualmente ai produttori di hardware l’installazione del proprio sistema operativo); oppure nella gestione-controllo delle connessioni dati di tutto il mondo o quasi (il modello Google, appunto, con tutto il monopolio della pubblicità che si porta dietro). Qui c’è la similitudine più forte con il business editoriale, dove un determinato prodotto – un giornale o un libro – ha le potenzialità per essere replicato su qualsiasi scala dimensionale con un investimento relativamente basso (il costo di produzione di un libro, per esempio, a differenza da quello di un’automobile, diminuisce molto rapidamente quante più copie ne vengono ordinate).
Ma torniamo alle paure del povero imprenditore De Benedetti: “il monopolio privato dell’accesso digitale alla conoscenza è uno strumento di omologazione senza precedenti nella storia”.
Qui, probabilmente senza accorgersi dell’enormità che va sollevando, il patron di Repubblica tocca il sistema nervoso centrale del modo di produzione capitalistico. Ovvero la contraddizione tra il “miserabile fine dell’appropriazione privatistica” (il profitto, banalmente) e la socialità universale del bene privatizzato. Questo vale per ogni bene prodotto capitalisticamente, ma è chiaro che la conoscenza ha un quid decisamente superiore agli altri. Qui, insomma, si rivela con molta maggiore chiarezza l’incompatibilità del capitalismo con lo sviluppo umano ulteriore. O, in altre parole, prende corpo fisico la previsione teorica del fatto che il modo di produzione (l’appropriazione privata) diventa ad un certo punto un limite allo sviluppo stesso.
Uno dei limiti, non l’unico (gli altri due sono: la resistenza dei lavoratori costretti ad assicurarsi almeno le condizioni della riproduzione e la limitatezza insuperabile delle risorse naturali non riproducibili, ecosistema compreso). Ma è un limite che esplode in faccia a De Benedetti e tutti gli altri imprenditori che si vedono sul punto di essere asserviti da Google.
Peggio che comica è infatti la considerazione “geostrategica” sull’uso che Google fa dei dati archiviati: “gli operatori digitali globali immagazzinano dati personali raccolti fuori da qualsiasi controllo, che ci riducono in balìa di chi ne fa illegittimo uso come le agenzie di sicurezza americane (e se fossero quelle di Putin o di qualche regime prossimo venturo?)”. Come se la minaccia alle libertà fondamentali – a partire dall’accesso alla conoscenza – fosse più o meno grave a seconda dell’identità ideologica del monopolista.
Sta di fatto, però, che anche questo pessimo campione del liberismo “democratico” sia costretto a registrare il passaggio – in realtà già avvenuto – a un regime oligarchico su scala globale.
Come se ne esce? La “regolazione europea” di cui parlano sia Dopfner che De Benedetti richiederebbe – per essere efficace – quasi una dichiarazione di guerra agli Stati Uniti (il primo governo ad essere completamente identificato con le “proprie” multinazionali). Un “riequilibrio” in questo settore strategico implica infatti una rottura sostanziale di un monopolio. È quello che stanno cercando di realizzare Cina e Russia, senza fare grandi annunci pubblici. Ma è un passo che andrebbe nella direzione di un “multipolarismo” sostitutivo dell’egemonia statunitense sul mondo. L’equivalente, in campo digitale, della rottura dell’egemonia del dollaro in campo monetario. De Benedetti sta su questo versante “putiniano”? C’è da dubitarne.
Ma una “regolazione globale” è al di là del pensabile, perché gli Stati Uniti dovrebbero unilateralmente rinunciare a proprio vantaggio strategico.
E quindi le “cinque proposte” di Dopfner-De Benedetti si restringono a una difesa del “diritto d’autore” e dei contenuti editoriali che potrà essere forse fatta valere verso i “piccoli” – come il sottoscritto, che qui critica un articolo riprendendolo da altra fonte, senza aver dovuto pagare per leggerlo – ma che sarà come oggi assolutamente inefficace verso blob onnivori come Google.
Una conclusione misera dopo aver sollevato un problema enorme. L’imprenditoria italiana sembra condannata da sempre a questo destino.
*****
Come Dopfner perché ho paura di Google
Andrea De Benedetti
Mathias Dopfner è un eccellente giornalista e un precoce quanto capace dirigente editoriale. A nemmeno vent’anni critico musicale e poi corrispondente da Bruxelles del più compassato quotidiano tedesco, la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), a 32 anni direttore del settimanale berlinese Wochenpost, a 34 dell’Hamburger Morgenpost, a 36 della Die Welt, autorevole testata del gruppo Axel Springer, del quale è diventato amministratore delegato prima ancora di compiere 39 anni.
Lo conosco da allora e lo considero il più innovatore e coraggioso editore europeo avendo egli trasformato in pochi anni un’azienda in difficoltà nella più efficiente macchina editoriale d’Europa e, nel suo genere, del mondo. Non mi sono dunque stupito quando due settimane fa la FAZ ha pubblicato la clamorosa lettera aperta di Dopfner a Eric Schmidt, ex CEO e ora presidente esecutivo di Google. Lo dico subito: sono al suo fianco quando scrive “di Google ho paura”, espone con chiarezza le molte complesse motivazioni di questa affermazione, denuncia la natura obbligata dei rapporti con il motore di ricerca di Page, Brin e Schmidt “con il quale il mio gruppo è costretto a fare affari perché siamo Golia Google e David Axel Springer”. Potremmo dire lo stesso noi del Gruppo Espresso: se non lavori con loro, in alcuni casi non lavori affatto.
Eppure, ammette Dopfner, “sono un grande ammiratore di Google, che in pochi anni è cresciuta fino a dare lavoro a quasi 50mila persone e fatturare 60 miliardi di dollari, con una capitalizzazione di oltre 350. Con i suoi 14 miliardi, l’utile annuale di Google è circa venti volte quello di Axel Springer”. Io stesso alcuni mesi fa ho scritto nel mio blog sull’Huffington Post Italia che vanno riconosciuti a Google entusiasmo, creatività e capacità di costruire valore senza pari. Tuttavia, come Dopfner, ne ho timore: da cittadino italiano ed europeo, anzitutto, perché il monopolio privato dell’accesso digitale alla conoscenza è uno strumento di omologazione senza precedenti nella storia.
Perché, poi, le cronache registrano che – da anni! – gli operatori digitali globali immagazzinano dati personali raccolti fuori da qualsiasi controllo, che ci riducono in balìa di chi ne fa illegittimo uso come le agenzie di sicurezza americane (e se fossero quelle di Putin o di qualche regime prossimo venturo?). Perché l’incapacità da parte dei regolatori di mettere potenziali concorrenti globali e locali su uno stesso piano favorisce la concentrazione di ricchezza e potere nelle mani di pochi, con rischi per la natura stessa del capitalismo di mercato. Perché chi dovrebbe definire a livelli mondiale, comunitario e nazionale il perimetro del campo e le regole del gioco non è più in grado di fare il proprio mestiere: di fatto, non sapendo come intervenire, non interviene per niente. Perché, alla resa dei conti, assistiamo impotenti alla sostituzione di un’imperfetta democrazia analogica con una perfetta oligarchia digitale.
Dopfner non solo illustra tutto questo con esempi: ne porta le prove, come si direbbe in un tribunale. È da lì, dalla sua lettera, che possiamo cominciare a elaborare una strategia europea che punti a ripristinare l’equilibrio in un ecosistema che l’ha perso. Saremo con lui.
Dobbiamo dunque fare la nostra parte sia nel consesso europeo sia in quello nazionale. Per quest’ultimo propongo di partire dall’obiettivo condiviso – il minimo comune denominatore – di focalizzare sul digitale l’investimento del sistema paese. Faccio un esempio senza uscire dal mio settore di competenza, l’editoria, dov’è da tempo un dato di fatto che per valorizzare i contenuti informativi, culturali ed educativi servono regole che impediscano agli operatori globali di farne strumenti con i quali razziare ulteriori risorse locali. Tre anni fa l’Antitrust italiano ne prendeva atto e segnalava al legislatore che “i contenuti editoriali online, accessibili e facilmente riproducibili nella loro forma digitale, sono utilizzati su Internet da una molteplicità di soggetti terzi − aggregatori, motori di ricerca, ecc. − che riproducono ed elaborano in vario modo i contenuti stessi, anche per fini di lucro. Le attuali norme sul diritto di autore non appaiono tener conto delle peculiarità tecnologiche ed economiche di Internet e non disciplinano un sistema di diritti di proprietà intellettuale”.
L’Autorità auspicava che la legge imponesse un rapporto corretto tra i titolari di diritti di esclusiva sui contenuti editoriali e i fornitori di servizi come Google. Sulla stessa lunghezza d’onda era l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Prendendo le mosse da queste considerazioni il governo Letta presentava un disegno di legge per emendare l’attuale norma al fine di consentire solo il riutilizzo autorizzato dei contenuti editoriali da parte dei cosiddetti Over The Top (OTT). Ovviamente non se n’è fatto nulla per la cronica carenza di volontà politica mentre nel frattempo in Germania il Bundestag approvava una legge molto simile alla proposta italiana. Perché l’esecutivo Renzi, che con tanta attenzione guarda a quanto si muove nei paesi a noi più vicini, non recupera e rilancia quella proposta?
Quel che più mi preme è proprio il livello europeo. Grazie al semestre italiano di presidenza e al prossimo cambio di guardia all’Europarlamento e alla Commissione, possiamo essere noi a tentare di trasformare in strategia industriale condivisa le analisi e le “prove di Dopfner”. Provo a indicare cinque ambiti sui quali lavorare insieme.
1. Del diritto d’autore, che pure non coincide perfettamente con il copyright anglosassone, ho già detto per quel che concerne l’Italia. È tuttavia evidente che non è più rinviabile un intervento armonizzatore da parte della UE oppure in sinergia tra i principali paesi dell’area.
2. Governo dei dati degli utenti. Non c’è un contesto normativo sovranazionale che fissi alcune punti-chiave sulla privacy digitale e sull’uso di dati raccolti dagli OTT in ambiti diversi da quelli propri. Inoltre, si dovrà tenere conto della necessità di adeguare costantemente le regole allo sviluppo tecnologico.
3. La tassazione nell’ecosistema digitale non può più essere come quella dei tempi dei commerci di beni solo fisici. La situazione attuale di difformi tassazioni per OTT e operatori nazionali ha già creato posizioni di preminenza competitiva non più recuperabili.
4. Il futuro della net neutrality (la garanzia per tutti di accesso e stessa “velocità” in rete) è il tema che sta dividendo in questi giorni i grandi operatori e i regolatori negli USA, mentre Bruxelles lo studia da tempo senza risultati concreti. È necessaria un’accelerazione.
5. La vicenda Almunia vs. Google ha messo in evidenza come l’Europa non riesca più a produrre iniziative antitrust efficaci come negli anni di Monti vs. Microsoft. Tornare a intervenire, a livello europeo, contro gli abusi di posizione dominante dovrà essere la priorità della Commissione che si insedierà in autunno.
Mi rendo conto che è un’agenda fitta. Tuttavia, solo un dibattito ampio e alto e una definizione rapida di soluzioni consentirà all’Europa di uscire dalle secche in cui s’è incagliata per i propri ritardi e ritardi e per la volontà neocolonialistica dei Nuovi Grandi Fratelli.
da blog Tempo Reale
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa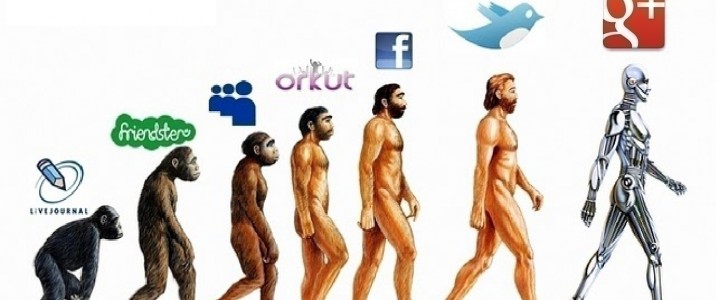





Antonietta
Si tratta di CARLO De Benedetti, non Andrea.