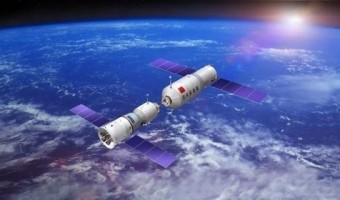Le regole interne non si sfidano, come invece aveva tentato di fare l’ingombrante Bo. Conviene ancora oggi convivere, concertare e non sbranarsi
La clemenza della Corte si è infine abbattuta su Gu Kailai con un verdetto di condanna a morte «sospesa», che chiude a doppia mandata il processo-simbolo della nuova Cina. La sentenza comminata ieri alla moglie di Bo Xilai, ex astro nascente della politica cinese caduto in disgrazia, prevede due anni di sospensione dell’esecuzione, per consentire il ravvedimento del condannato, che passa poi di solito al carcere a vita. La formula, contemplata solo dal codice penale cinese, è un retaggio dell’impero mantenuto da Mao che credeva, in determinati casi, nel recupero del reprobo.
Si può sin d’ora affermare che Gu Kailai si è già guadagnata quella vita lasciata in sospeso. L’imputata perfetta di una ben congegnata rappresentazione, apparsa in aula sconfitta e dimessa, sformata dai farmaci, ombra irriconoscibile della donna che era una volta un abile avvocato e una potente first lady, ha accettato senza opporsi il ruolo di rea confessa dell’efferato omicidio dell’uomo d’affari inglese Neil Heywood assegnatole dalle versioni ufficiali e dalla vulgata popolare. A farle perdere la testa e spingerla al crimine, secondo quanto da lei ammesso in tribunale secondo le cronache ufficiali, le minacce di vendicarsi su suo figlio, Bo Guagua, per un affare immobiliare fallito proferite dall’uomo, figura ambigua di faccendiere sospettato di un passato da spia.
Il delitto è avvenuto e la donna ne è stata di sicuro una protagonista, ma la ricostruzione ufficiale dei fatti, l’impalcatura dell’accusa, le modalità del processo lasciano più di un dubbio, soprattutto sul non detto. Ad esempio, neppure l’ombra è comparsa dell’uomo che ha scatenato la tempesta perfetta: l’ex capo della polizia di Chongqing, Wang Lijun, che con la sua fuga nell’ambasciata Usa di Chengdu ha dato fuoco alle polveri. Eppure chi più di lui era al corrente dei fatti? E ancora, durante tutto il procedimento è rimasto innominato anche Bo Xilai, il marito, destituito da tutte le cariche del Partito per gravi violazioni della disciplina interna, cioè aver coperto il delitto della moglie, e oggi in attesa di giudizio in uno dei luoghi misteriosi dove l’apparato disciplinare trattiene e interroga i caduti in disgrazia, in uno stato di detenzione che stranisce e svuota. Del tutto rimosso il contenzioso fra la potente coppia e Heywood, affiorato all’inizio del caso, cioè l’esportazione di capitali neri all’estero, per la quale il businessman aveva chiesto un prezzo troppo elevato, finendo poi per ricattare i Bo. Gu Kailai ha tuttavia accettato di buon grado tutto questo. In cambio ha avuto, in qualche modo, salva la vita, assicurata l’incolumità del figlio e la possibilità che la rovina del marito sia meno devastante. E comunque, per due anni sarà un ostaggio, un deterrente per eventuali «ripensamenti».
La sentenza chiude in modo conseguente un processo dal quale con chirurgica precisione è stato rimosso ogni elemento che collegasse il fatto criminale a un qualunque aspetto politico, dopo un iniziale periodo in cui era impossibile capire dove finisse l’uno e cominciasse l’altro. Ma il vuoto della rimozione finisce per esaltare questa parte oscura che tra un processo e l’altro (si avvicina quello a Wang Lijun, mentre si attende il verdetto del Partito su Bo Xilai) verrà a galla frammentata e distorta, forse destinata a non ricomporsi mai in un’unica verità.
Sconcertante, per un affaire di cui si afferma che sarà ricordato come un punto di svolta per il futuro della Cina. Al pari, secondo alcuni, del processo alla «banda dei quattro» che liquidò a suo tempo una parte del maoismo. Paragone in realtà improprio: allora la resa dei conti politica fu chiara a tutti, oggi regna l’oscurità e il segreto. Segno dei tempi.
Ma sulla valenza politica dello scandalo di oggi nessuno ha mai avuto dubbi, anche perché in una Cina infestata dalla corruzione viene a galla solo quel che, per convenienza, i più forti decidono di eliminare. Dunque, su questo aspetto conviene tornare.
La gestione, anche giudiziaria, del caso induce a ipotizzare un’esitazione dell’apparato del Pcc a spingere fino in fondo il tasto ideologico nella resa dei conti politica. La sfida lanciata a marzo da Wen Jiabao alla fine dell’Assemblea nazionale del popolo, quando il premier aveva resuscitato i fantasmi della Rivoluzione culturale e ammonito il governo di Chongqing, non è stata al dunque raccolta dagli altri leader. Eppure la rimozione di Bo Xilai dalla guida del partito nella municipalità a statuto speciale del Sichuan, avvenuta il giorno dopo l’anatema di Wen e ad esso collegata, aveva fatto profilare uno scontro politico radicale, quello tra sinistra e riformisti liberal, in vista del cambio di leadership di autunno. Era seguita una settimana al cardiopalma, con la sinistra più radicale all’attacco e immediatamente imbavagliata, e le voci più incontrollabili che rimbalzavano sul web, tra cui quella di un tentato golpe a Pechino.
Ma il caso riesplode ad aprile inoltrato, come un fattaccio di cronaca nera, con Gu Kailai accusata dell’omicidio di Heywood e, separatamente, Bo Xilai privato di tutte le cariche di partito e messo sotto inchiesta interna.
Da quel momento sparisce ogni attacco ideologico, come se i vertici avessero infine deciso di trattare il caso Bo in termini esclusivamente giudiziari, secondo le modalità di altri scandali eccellenti, disattivandone la carica politica e accontentandosi dell’epurazione e dell’inevitabile castigo dello scomodo personaggio. Forse perché gli alleati di Bo, pur accettando la caduta in disgrazia dello scomodo «principe rosso», non avrebbero mai accettato lo sterminio politico o peggio il discredito delle idee di sinistra che quello aveva finito, nel bene e nel male, per incarnare anche agli occhi di una larga base popolare che indubbiamente si era costituito, e non solo a Chongqing. La stessa che oggi grida al complotto. Andare allo scontro aperto avrebbe potuto essere devastante per l’andamento pacifico della transizione e la coesione del Pcc. Di qui, anche, i numerosi commenti che ad aprile dal Quotidiano del popolo invitavano all’unità del Partito.
In una fase di cruciale transizione nella quale mancano leader così forti e autorevoli da poter imporre decisioni e soluzioni, l’affaire Bo si è rivelato una sorta di test, utile a far emergere due fondamentali punti di compromesso. Da una parte, che le regole interne per definire gli equilibri di potere non si sfidano, come invece aveva tentato di fare l’ingombrante ed eclatante Bo, che ambiva a entrare nel Comitato Permanente del Politburo. Dall’altra, che conviene ancora oggi convivere, concertare e non sbranarsi, anche se il comune denominatore si va riducendo sempre. Passato il terremoto, gli equilibri si sono presumibilmente ricomposti, e non è detto che siano gli stessi di prima.
In questo senso, nota Joseph Fewsmith (China Leadership Monitor on line n.38), è necessario aggiornare i termini con cui solitamente si descrive l’articolazione delle alleanze e dei raggruppamenti all’interno del Pcc, poiché, come dimostra anche in questo il caso Bo, la divisione schematica tra «principini» (i figli delle grandi famiglie rosse di cui Bo Xilai faceva parte) e «tuanpai» (coloro che aderiscono alla Lega della gioventù comunista del presidente Hu Jintao) non regge più, di fronte alla ricomposizione in nuove coalizioni di interessi e poteri personali. E comunque sotto questo aspetto il Pcc dovrà prima o poi uscire dall’ambiguità che nasconde con la retorica del «socialismo con caratteristiche cinesi» e tagliare il nodo più spinoso per la sua sopravvivenza se, come affermava giustamente Mao, «per avere ordine nell’organizzazione, bisogna averne nell’ideologia».
A questo proposito, la sinistra cinese, rimasta vittima della purga di Chongqing, ha letto giustamente nella deflagrazione del caso Bo il tentativo di dare una spallata agli attuali equilibri di politica economica per dare il via a nuove riforme economiche in senso neoliberista (vedi Wang Hui, «Le stanze segrete del potere», pubblicato su Alias il 28/04/2012). Più di una dichiarazione e decisione indicava che la strada era stata imboccata. Ma, anche qui, la crisi economica globale arrivata a mordere pure la Cina sembra aver imposto una frenata. La seconda economia del mondo, dopo aver tenuto testa al primo tsunami economico del 2008, si trova oggi a fronteggiare un notevole rallentamento della crescita di cui non si riescono a prevedere né l’ampiezza, né la durata. E tutto ciò mentre ancora non ha risolto i profondi problemi strutturali che mettono a rischio la sua tenuta futura: il cambiamento dell’asse portante del suo sviluppo, i gravi problemi ambientali e sociali, le mutazioni demografiche che ne stanno modificando il profilo sociale ed economico. Un’eredità pesante, che la Quarta generazione di leader lascia alla Quinta, entità ancora indefinita e oggetto di febbrili contrattazioni proprio in questi giorni d’estate.
L’incertezza domina sovrana, e certo consiglia prudenza nello squadernare i dissensi interni. Non è questo il momento di imboccare strade senza ritorno. D’altra parte ormai Bo Xilai è finito, la sua famiglia distrutta. La lezione è stata impartita.
Si può sin d’ora affermare che Gu Kailai si è già guadagnata quella vita lasciata in sospeso. L’imputata perfetta di una ben congegnata rappresentazione, apparsa in aula sconfitta e dimessa, sformata dai farmaci, ombra irriconoscibile della donna che era una volta un abile avvocato e una potente first lady, ha accettato senza opporsi il ruolo di rea confessa dell’efferato omicidio dell’uomo d’affari inglese Neil Heywood assegnatole dalle versioni ufficiali e dalla vulgata popolare. A farle perdere la testa e spingerla al crimine, secondo quanto da lei ammesso in tribunale secondo le cronache ufficiali, le minacce di vendicarsi su suo figlio, Bo Guagua, per un affare immobiliare fallito proferite dall’uomo, figura ambigua di faccendiere sospettato di un passato da spia.
Il delitto è avvenuto e la donna ne è stata di sicuro una protagonista, ma la ricostruzione ufficiale dei fatti, l’impalcatura dell’accusa, le modalità del processo lasciano più di un dubbio, soprattutto sul non detto. Ad esempio, neppure l’ombra è comparsa dell’uomo che ha scatenato la tempesta perfetta: l’ex capo della polizia di Chongqing, Wang Lijun, che con la sua fuga nell’ambasciata Usa di Chengdu ha dato fuoco alle polveri. Eppure chi più di lui era al corrente dei fatti? E ancora, durante tutto il procedimento è rimasto innominato anche Bo Xilai, il marito, destituito da tutte le cariche del Partito per gravi violazioni della disciplina interna, cioè aver coperto il delitto della moglie, e oggi in attesa di giudizio in uno dei luoghi misteriosi dove l’apparato disciplinare trattiene e interroga i caduti in disgrazia, in uno stato di detenzione che stranisce e svuota. Del tutto rimosso il contenzioso fra la potente coppia e Heywood, affiorato all’inizio del caso, cioè l’esportazione di capitali neri all’estero, per la quale il businessman aveva chiesto un prezzo troppo elevato, finendo poi per ricattare i Bo. Gu Kailai ha tuttavia accettato di buon grado tutto questo. In cambio ha avuto, in qualche modo, salva la vita, assicurata l’incolumità del figlio e la possibilità che la rovina del marito sia meno devastante. E comunque, per due anni sarà un ostaggio, un deterrente per eventuali «ripensamenti».
La sentenza chiude in modo conseguente un processo dal quale con chirurgica precisione è stato rimosso ogni elemento che collegasse il fatto criminale a un qualunque aspetto politico, dopo un iniziale periodo in cui era impossibile capire dove finisse l’uno e cominciasse l’altro. Ma il vuoto della rimozione finisce per esaltare questa parte oscura che tra un processo e l’altro (si avvicina quello a Wang Lijun, mentre si attende il verdetto del Partito su Bo Xilai) verrà a galla frammentata e distorta, forse destinata a non ricomporsi mai in un’unica verità.
Sconcertante, per un affaire di cui si afferma che sarà ricordato come un punto di svolta per il futuro della Cina. Al pari, secondo alcuni, del processo alla «banda dei quattro» che liquidò a suo tempo una parte del maoismo. Paragone in realtà improprio: allora la resa dei conti politica fu chiara a tutti, oggi regna l’oscurità e il segreto. Segno dei tempi.
Ma sulla valenza politica dello scandalo di oggi nessuno ha mai avuto dubbi, anche perché in una Cina infestata dalla corruzione viene a galla solo quel che, per convenienza, i più forti decidono di eliminare. Dunque, su questo aspetto conviene tornare.
La gestione, anche giudiziaria, del caso induce a ipotizzare un’esitazione dell’apparato del Pcc a spingere fino in fondo il tasto ideologico nella resa dei conti politica. La sfida lanciata a marzo da Wen Jiabao alla fine dell’Assemblea nazionale del popolo, quando il premier aveva resuscitato i fantasmi della Rivoluzione culturale e ammonito il governo di Chongqing, non è stata al dunque raccolta dagli altri leader. Eppure la rimozione di Bo Xilai dalla guida del partito nella municipalità a statuto speciale del Sichuan, avvenuta il giorno dopo l’anatema di Wen e ad esso collegata, aveva fatto profilare uno scontro politico radicale, quello tra sinistra e riformisti liberal, in vista del cambio di leadership di autunno. Era seguita una settimana al cardiopalma, con la sinistra più radicale all’attacco e immediatamente imbavagliata, e le voci più incontrollabili che rimbalzavano sul web, tra cui quella di un tentato golpe a Pechino.
Ma il caso riesplode ad aprile inoltrato, come un fattaccio di cronaca nera, con Gu Kailai accusata dell’omicidio di Heywood e, separatamente, Bo Xilai privato di tutte le cariche di partito e messo sotto inchiesta interna.
Da quel momento sparisce ogni attacco ideologico, come se i vertici avessero infine deciso di trattare il caso Bo in termini esclusivamente giudiziari, secondo le modalità di altri scandali eccellenti, disattivandone la carica politica e accontentandosi dell’epurazione e dell’inevitabile castigo dello scomodo personaggio. Forse perché gli alleati di Bo, pur accettando la caduta in disgrazia dello scomodo «principe rosso», non avrebbero mai accettato lo sterminio politico o peggio il discredito delle idee di sinistra che quello aveva finito, nel bene e nel male, per incarnare anche agli occhi di una larga base popolare che indubbiamente si era costituito, e non solo a Chongqing. La stessa che oggi grida al complotto. Andare allo scontro aperto avrebbe potuto essere devastante per l’andamento pacifico della transizione e la coesione del Pcc. Di qui, anche, i numerosi commenti che ad aprile dal Quotidiano del popolo invitavano all’unità del Partito.
In una fase di cruciale transizione nella quale mancano leader così forti e autorevoli da poter imporre decisioni e soluzioni, l’affaire Bo si è rivelato una sorta di test, utile a far emergere due fondamentali punti di compromesso. Da una parte, che le regole interne per definire gli equilibri di potere non si sfidano, come invece aveva tentato di fare l’ingombrante ed eclatante Bo, che ambiva a entrare nel Comitato Permanente del Politburo. Dall’altra, che conviene ancora oggi convivere, concertare e non sbranarsi, anche se il comune denominatore si va riducendo sempre. Passato il terremoto, gli equilibri si sono presumibilmente ricomposti, e non è detto che siano gli stessi di prima.
In questo senso, nota Joseph Fewsmith (China Leadership Monitor on line n.38), è necessario aggiornare i termini con cui solitamente si descrive l’articolazione delle alleanze e dei raggruppamenti all’interno del Pcc, poiché, come dimostra anche in questo il caso Bo, la divisione schematica tra «principini» (i figli delle grandi famiglie rosse di cui Bo Xilai faceva parte) e «tuanpai» (coloro che aderiscono alla Lega della gioventù comunista del presidente Hu Jintao) non regge più, di fronte alla ricomposizione in nuove coalizioni di interessi e poteri personali. E comunque sotto questo aspetto il Pcc dovrà prima o poi uscire dall’ambiguità che nasconde con la retorica del «socialismo con caratteristiche cinesi» e tagliare il nodo più spinoso per la sua sopravvivenza se, come affermava giustamente Mao, «per avere ordine nell’organizzazione, bisogna averne nell’ideologia».
A questo proposito, la sinistra cinese, rimasta vittima della purga di Chongqing, ha letto giustamente nella deflagrazione del caso Bo il tentativo di dare una spallata agli attuali equilibri di politica economica per dare il via a nuove riforme economiche in senso neoliberista (vedi Wang Hui, «Le stanze segrete del potere», pubblicato su Alias il 28/04/2012). Più di una dichiarazione e decisione indicava che la strada era stata imboccata. Ma, anche qui, la crisi economica globale arrivata a mordere pure la Cina sembra aver imposto una frenata. La seconda economia del mondo, dopo aver tenuto testa al primo tsunami economico del 2008, si trova oggi a fronteggiare un notevole rallentamento della crescita di cui non si riescono a prevedere né l’ampiezza, né la durata. E tutto ciò mentre ancora non ha risolto i profondi problemi strutturali che mettono a rischio la sua tenuta futura: il cambiamento dell’asse portante del suo sviluppo, i gravi problemi ambientali e sociali, le mutazioni demografiche che ne stanno modificando il profilo sociale ed economico. Un’eredità pesante, che la Quarta generazione di leader lascia alla Quinta, entità ancora indefinita e oggetto di febbrili contrattazioni proprio in questi giorni d’estate.
L’incertezza domina sovrana, e certo consiglia prudenza nello squadernare i dissensi interni. Non è questo il momento di imboccare strade senza ritorno. D’altra parte ormai Bo Xilai è finito, la sua famiglia distrutta. La lezione è stata impartita.
Il leader della quinta generazione dopo Mao
Xi Jinping (1953) Uno dei «principi rossi» (la corrente dei «taizi», i discendenti dei primi rivoluzionari di cui faceva parte anche il deposto Bo Xilai), è considerato il «delfino» di Hu Jintao e almeno finora è il candidato più accreditato a diventare il prossimo capo dello stato e forse anche segretario generale del partito comunista.
Li Kejiang (1955) Dal 2002 è vicepremier esecutivo ed è tra i nomi più accreditati per la carica di premier al posto di Wen Jiabao. Nel ’98 è diventato il più giovane governatore di una provincia cinese (lo Henan). Fa parte della coalizione dei «tuanpai», l’ala più liberista del partito comunista. Il suo vero debutto internazionale è avvenuto a Davos, nel 2010.
Zhang Dejang (1946) È l’uomo dal polso di ferro chiamato a sostituire Bo Xilai alla guida della provincia del Chongqing dopo la sua rimozione del marzo scorso. È in pista – come voleva fare Bo – per entrare nel Comitato permanente del Politburo, il massimo organo decisionale della Cina. Attualmente è il responsabile energia, Tlc e trasporti.
Xi Jinping (1953) Uno dei «principi rossi» (la corrente dei «taizi», i discendenti dei primi rivoluzionari di cui faceva parte anche il deposto Bo Xilai), è considerato il «delfino» di Hu Jintao e almeno finora è il candidato più accreditato a diventare il prossimo capo dello stato e forse anche segretario generale del partito comunista.
Li Kejiang (1955) Dal 2002 è vicepremier esecutivo ed è tra i nomi più accreditati per la carica di premier al posto di Wen Jiabao. Nel ’98 è diventato il più giovane governatore di una provincia cinese (lo Henan). Fa parte della coalizione dei «tuanpai», l’ala più liberista del partito comunista. Il suo vero debutto internazionale è avvenuto a Davos, nel 2010.
Zhang Dejang (1946) È l’uomo dal polso di ferro chiamato a sostituire Bo Xilai alla guida della provincia del Chongqing dopo la sua rimozione del marzo scorso. È in pista – come voleva fare Bo – per entrare nel Comitato permanente del Politburo, il massimo organo decisionale della Cina. Attualmente è il responsabile energia, Tlc e trasporti.
da “il manifesto”
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa