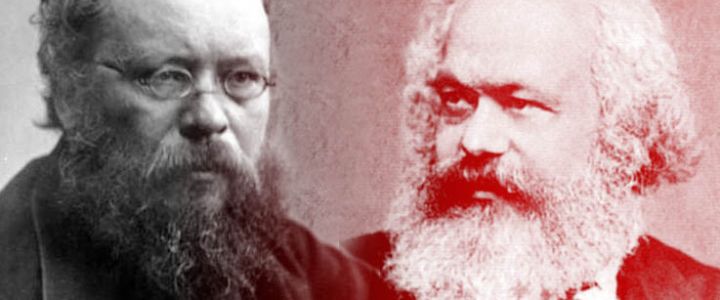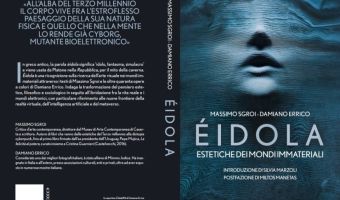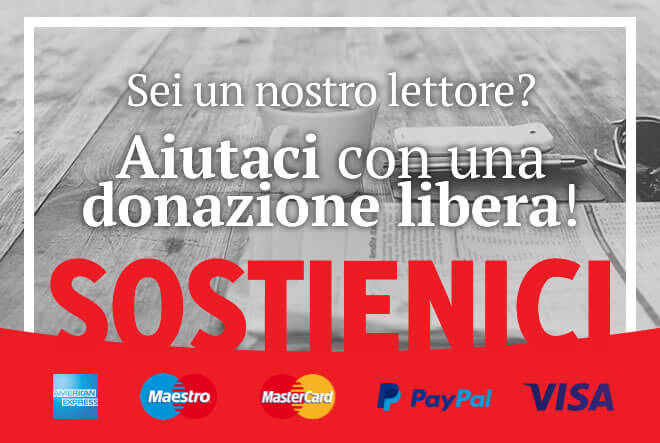Il divario delle retribuzioni dei lavoratori italiani rispetto a quelle dei lavoratori degli altri Paesi europei si è allargato: mentre i salari tedeschi sono cresciuti quelli italiani sono diminuiti. E non è che in Italia si guadagni meno perché si lavori meno, al contrario.
“L’Italia è diventata il fanalino di coda dell’Unione Europea, precipitata com’è in fondo alle statistiche per quanto riguarda la precarietà del lavoro, l’età del pensionamento e il basso importo delle pensioni, ma anche per i tagli allo Stato sociale a cominciare dalle prestazioni sanitarie diventate irraggiungibili a causa delle lunghe liste di attesa, l’abolizione del reddito di cittadinanza e la mancanza di un salario minimo adeguato al costo della vita”, osserva l’economista Luciano Vasapollo, docente alla Sapienza, che in un’intervista a Faro di Roma definisce “davvero attuale la critica espressa da Marx riguardo alla mercificazione del lavoro, una visione (che piace a Confindustria) per la quale è il valore della merce prodotta che determina il compenso del lavoratore, considerando la quantità di lavoro necessario per la sua produzione e detraendo gli altri costi sostenuti, nonchè il margine di guadagno del padrone, oggi diremmo dell’azienda o dell’imprenditore”.
“Marx nel 1859 con la critica dell’economia politica, mette in evidenza – sottolinea Vasapollo – un fatto fondamentale, cioè che se il valore di scambio di un prodotto è uguale a quello del tempo di lavoro, allora il valore di scambio di una giornata di lavoro deve necessariamente essere uguale a quella del relativo prodotto della giornata di lavoro, cioè il salario deve essere uguale al prodotto del lavoro.
Invece quello che avviene nella realtà è esattamente il contrario, come ci evidenzia bene Engels nella sua prefazione alla prima edizione tedesca dell’opera ‘Miseria della filosofia’ che confuta le teorie del socialismo riformista di Proudhon.
Proprio ‘Miseria della filosofia’ mette ben in evidenza gli aspetti che Marx poteva trarre dalle conclusioni di David Ricardo, l’economista inglese per il quale ‘il prodotto della terra, tutto quanto si ricava dalla sua superficie grazie all’impiego combinato di lavoro, macchine e capitale, viene ripartito fra le tre classi della collettività, vale a dire tra il proprietario del terreno, il proprietario delle scorte o capitali necessari per coltivarlo e i lavoratori, che con l’opera loro lo coltivano’. Ovvero accetta le categorie economiche di lavoro, di capitale, di valore. Al contrario di Marx che critica il contenuto stesso di questi concetti”.
Ma a più di un secolo dalla morte di Marx, siamo sempre al conflitto capitale-lavoro?
In realtà il socialismo ha molto ammorbidito le sue posizioni mentre il capitalismo è diventato se possibile più spietato. Si parte dalla teoria di Ricardo che assegna in pratica ai lavoratori la totalità della produzione sociale, cioè il totale del loro prodotto che appartiene loro perché sono i soli produttori. Questo porterebbe ad un’idea forte di socialismo. Però Marx ci dice che c’è un qualcosa di falso, perché contraddice le leggi dell’economia borghese che proclama di voler accettare, nell’ottica, diremmo oggi, di un capitalismo avanzato, secondo le quali la maggior parte del prodotto non deve appartenere ai lavoratori che l’hanno creato. Quindi si entra con i socialisti utopisti in una sorta di ‘predica dell’ingiustizia’.
Secondo Marx, invece, il problema morale deve essere superato da quella che è la ‘scienza dell’economia’ e le rivendicazioni che porta avanti, ovvero dall’analisi del sistema produttivo capitalistico e da quella che può essere appunto la sua configurazione, diciamo così, in termini di crollo ineluttabile di questo sistema produttivo. Quindi supera la questione, per così dire morale, della teoria ricardiana che parte dall’assunto che il mondo è ingiusto. Che il mondo è fatto male. Questo modo di vedere le cose fa comodo anche, ovviamente, alla borghesia, perché si ferma a un senso generale morale di giustizia, cioè alla ricerca di una giustizia ed uguaglianza dei diritti, ma diritti che sono basati sul superamento (peraltro parziale) dei privilegi feudali, e non invece su un metodo scientifico che determina i fondamenti su cui è stata edificata l’ideologia borghese; e quindi non indica quali debbano essere poi le maniere per abbatterla.
Dunque la visione del socialismo riformista spinge a una sorta di compromesso, gratificando a parole i lavoratori ma lasciandoli esposti allo sfruttamento?
E’ così. In altri termini, la legge della produzione delle merci non porta con sé la soppressione della condizione di sperequazione che rende valida questa legge, e quindi tutte le leggi della produzione delle merci. Sono leggi della produzione capitalistica che, in quanto tali, devono essere, ovviamente, superate. L’elemento specifico della visione marxista sta nel fatto che si vogliano eliminare le storture del capitalismo, le crisi industriali, e commerciali, servendosi semplicemente di un processo utopistico, cioè di un processo che abbia in sé fortemente soltanto il senso morale della giustizia.
Il problema serio è che bisogna porsi la domanda: in che modo la produzione dei singoli produttori corrisponde al fabbisogno sociale? Al di fuori di tale ottica, ogni processo utopico non porta ad alcun tipo di risposta.
Si finisce infatti con l’accettare che il lavoro e il suo sfruttamento alla fine debbano in qualche modo sussistere.
La visione di Marx quindi rifiuta il compromesso che ritiene il capitalismo (più o meno riformista) l’unico modo possibile per far progredire la società?
Marx risponde non solo a Proudhon, ma a tutti coloro che hanno un approccio utopista, un approccio cioè che porta all’auto-mortificazione dell’uomo, alla cosiddetta “religione dell’amore”, eccetera. E invita praticamente già dal 1846 ad una discussione su questioni non umanistiche o moralistiche, ma su questioni scientifiche, cioè vuole fornire un panorama critico su basi scientifiche, per cercare di trovare forme di metodo che mettano in discussione l’economia politica, che la rovescino. E con l’economia politica creino una teoria della proprietà contro la proprietà. Quindi Marx dice subito: “dobbiamo bruciare la società della proprietà privata”. E certo non darle una nuova forza attraverso una visione riformista che sfoci in un neocapitalismo.
Storicamente, Marx non aveva nessuna intenzione all’inizio di attaccare l’opera di Proudhon, però quando inizia a vedere il dibattito che si sviluppa intorno a questa opera, comprende quanto sia necessario fare una confutazione e quindi attaccare la debole e cattiva filosofia che invece di identificare limiti e rischi del capitalismo pensa di poterlo purificare.
“Miseria della filosofia” del 1847 non è però soltanto uno scritto contro Proudhon ma è l’opera nella quale Marx indica “i punti decisivi” della concezione materialistica della storia…
“Il signor Proudhon – scrive Marx nella sua prefazione – ha la sventura di essere misconosciuto in Europa in un modo singolare. In Francia egli ha il diritto di essere un cattivo economista perché passa per un buon filosofo tedesco. In Germania ha il diritto di essere un cattivo filosofo, perché passa per uno dei migliori economisti francesi. Noi, nella nostra duplice qualità di tedeschi e di economisti, abbiamo voluto protestare contro questo duplice errore.
Il lettore comprenderà come, in tale opera ingrata, siamo stati spesso costretti ad abbandonare la critica di Proudhon per fare quella della filosofia tedesca, e a permetterci alcune osservazioni sull’economia politica in generale”.
Insomma la prefazione di Karl Marx indica fin da subito, in maniera molto chiara, che Proudhon promuove una falsa critica dell’economia politica e la sua filosofia è ridicola, perché non comprende lo Stato sociale, e indica come ideale di liberazione il far parte dell’ingranaggio stesso dell’economia. La confusione, secondo Marx, sta nel fatto che Proudhon, pur vedendo nella storia una serie determinata di sviluppi sociali, non si accorge che gli uomini praticamente procedono in maniera indipendente dal loro sviluppo individuale.
Quindi Marx supera Proudhon nella concezione del divenire storico, cioè dello sviluppo storico dell’umanità e risponde in maniera chiara alle analisi di Proudhon dicendo che la società è il prodotto dell’azione reciproca per gli uomini, quindi la base primaria è quella di un determinato stadio di sviluppo delle capacità produttive degli uomini. Pertanto Marx propone immediatamente il discorso dell’economia in quanto elimina l’impalcatura metafisica di Proudhon puntando sulle facoltà che costituiscono il movimento storico.
Far questo mette in evidenza l’errore di Proudhon circa il principio della proprietà che è quello di di rimanere legato all’esistente, cioè di non comprendere minimamente il carattere storico e transitorio delle forme di produzione. Marx dice che in pratica è come se Proudhon si muovesse in un presunto piano segreto voluto da Dio, mentre in dall’inizio parla della questione del conflitto fra forze produttive e i rapporti sociali e quindi e. E la questione centrale per Marx, quella del movimento storico. Dal movimento storico, dal divenire storico, scaturisce il conflitto fra forze produttive già acquisite dagli uomini e i rapporti sociali che non corrispondono più alle forze produttive. Quando questa conciliazione non è più data, ecco lì che si propone la fase del cambiamento, della trasformazione, del rovesciamento della società esistente, in base alle sue contraddizioni, ai suoi equilibri.
Quindi la critica di Marx è triplice, da una parte riguarda le facoltà creative degli individui, che rappresentano nel rapporto con la base materiale, il movimento delle forze. Ma il campo della storia va oltre il rapporto tra società e Stato, perché bisogna comprendere gli effetti sociali indotti dal movimento delle capacità creative individuali. Dopodiché la trasformazione, il cambiamento per il futuro non può essere affidata a un progetto, a una, diciamo così, inconscia tensione verso la giustizia, verso l’uguaglianza, ma si può proporre attraverso solo il conflitto di classe, l’antagonismo di classe, una capacità della classe di diventare forza politica.
Il tentativo è quello di rispondere al problema del rapporto tra la tesi ricardiana, per cui i costi di produzione sono la base del processo produttivo, considerato come creatore dei valori di scambio, e la questione della concorrenza che sottopone al proprio i costi di produzione a modificazioni, rendendo i prezzi indipendenti dai valori e in questa maniera si espone una sorta di scontro tra il valore d’uso e il valore di scambio.
Il primo è il valore d’uso, sinonimo di abbondanza, il secondo di rarità, ma Marx contrappone a questo modello soggettivista una versione quasi ortodossa delle tesi ricardiane, perché la critica che Marx riserva a Ricardo sia una critica completa. Una critica di carattere generale.
Dunque il socialismo riformista non sta in piedi da un punto di vista logico?
Proudhon, dice Marx, confonde il valore delle merci determinato dalla quantità di lavoro impiegato, con il valore delle merci misurato invece in base al valore del lavoro. Marx usa questa espressione, valore del lavoro, che poi dirà lui stesso che è irrazionale, perché non è il lavoro che ha un valore, ma è l’energia che sprigiona, cioè la forza lavoro che ha un valore che può essere venduta dall’operaio. Non è un errore concettuale, perché già dall’inizio Marx intende che il lavoro inglobato non è un’equivalente della retribuzione del lavoratore e che invece si confondono le spese di produzione e i salari.
In sostanza la società utopista di Proudhon è un’associazione di salariati e quindi quello che si cerca è la equità di una proporzione. Il salario inteso in maniera tale che i lavoratori partecipino alla loro produzione, una sorta di proporzionalità della ricchezza prodotta. Marx invece non esclude assolutamente il fatto che si debba capovolgere tutto lo sviluppo della storia perché la società è fondata sulla miseria e i prodotti più miserabili hanno la fatale e prerogativa di servire all’uso della maggioranza. Marx non esclude assolutamente il fatto che si debba pensare e lavorare per una società futura, ma bisogna avere una prassi, una prassi del conflitto per arrivarci e quindi la teoria deve operare un distacco dall’esistente invece di appiattirsi sull’esistente, invece di accettare le regole della società.
Quindi quelli indicati da Proudhon sono passi all’indietro, perché?
Intanto la proprietà non è attaccata frontalmente. E questo aspetto sconcerta Marx che, nel capitolo della metafisica dell’economia politica, lo evidenzia con delle osservazioni nelle quali coinvolge Hegel e il merito di fronte agli economisti di avere spiegato il movimento, il divenire storico che genera le categorie economiche. Proudhon tiene invece ferme le categorie economiche e pretende che tra di essi si determini un rapporto centrale, monitorabile. Per Marx, anche dal punto di vista dell’analisi hegeliana è quella di dire. Di porre, diciamo così, le basi per la critica. Dell’economia, la critica dell’economia politica, perché, perché? Infatti Marx pensa che non si può assolutamente prescindere da Hegel, perché la dialettica di Hegel era fondamentale in quanto evidenziava il sistema delle contraddizioni e quelli di Proudhon sono disperati tentativi di porsi al livello dell’analisi del sistema delle contraddizioni, ma Marx dice che non è minimamente capace e resta prigioniero proprio di quel lato speculativo della dialettica hegeliana. Marx dice: non prescindiamo da Hegel, ma la dialettica di Hegel deve essere liberata dall’aspetto mistico speculativo. Da Hegel non si deve prescindere perché era il filosofo che aveva scoperto il travaglio della contraddizione del negativo, cioè l’antagonismo della realtà.
La propria negazione quindi è la negazione della negazione. E la contraddizione della contraddizione: ci dice Marx che la dialettica è scandalo e orrore per la borghesia e per i suoi corifei dottrinali. Perché? Perché nella sua comprensione positiva dello Stato di cose esistenti include simultaneamente la comprensione della negazione, della contraddizione, la comprensione del suo superamento, e soprattutto la contemporanea presenza di un lato buono e di un lato cattivo. Quindi il suo problema è conservare il lato buono eliminando quello cattivo. Il suo approccio quindi è etico. Ma il lato cattivo, e cioè proprio la parte cattiva, quella che non conviene alla società produrre, rappresenta il movimento che invece fa la storia, che determina la lotta di classe, che alla fine ottiene il sopravvento e il superamento della società borghese.
In pratica stiamo parlando di una dialettica che include la lotta di classe?
Una classe è oppressa quando non riesce a esprimere se stessa, o la esprime nell’antagonismo, nel conflitto di classe. La liberazione della classe oppressa porta necessariamente alla creazione di una nuova società. E quando avviene questa nuova società? Quando le forze produttive già acquisite e i rapporti sociali di produzione esistenti non possono più coesistere, quindi nel suo movimento la borghesia spezza le vecchie forme espressione della vecchia società. E quindi praticamente questo è il metodo del superamento che costituisce il movimento dialettico. Proprio questo. Così la borghesia, man mano che si sviluppa questo approccio, sviluppa all’interno di se stessa una nuova classe, il proletariato, un proletariato moderno. Ma Proudhon, dice Marx, non vede in questa classe, nel proletariato, altro che miseria. Gli sfugge invece il carattere rivoluzionario della miseria che si deve organizzare in classe per il superamento del modo di produzione capitalistico. Proudhon non avverte che con il prodursi di una situazione di interessi comuni, questa massa diventa già classe nei confronti del capitale, anche se non è ancora una classe per sé stessa, cioè gli sfugge che è nella lotta di classe che la massa, che il proletariato si riunisce e si costituisce in classe. Si eleva a coscienza di se stessa e gli interessi che difendono diventano interessi di classe. E la lotta di classe è ovviamente una lotta tutta politica.
Professore, ma il conflitto di classe in questa visione non ha alternative?
Il rischio della socialdemocrazia è che ci si lasci abbagliare da quelli che sembrano i lati positivi della borghesia e quindi si finisca soltanto con il simpatizzare con le miserie del popolo senza metterle in contraddizione ed antagonismo. Il che significa non riconoscere l’esistenza della lotta di classe.
Pertanto il dottrinario Proudhon elabora un principio seguendo il quale non si riesce ad andare al di là dell’ideale piccolo borghese: non ha altro che da proporre davanti alla questione della miseria, che un ritorno al “maestro artigiano” del Medioevo, alle coalizioni operaie, agli scioperi che però non devono provocare un aumento dei salari perché altrimenti l’aumento dei salari porta a un rincaro generale e quindi a nuove sperequazioni.
Il confronto scontro di Marx con Proudhon mostra che è possibile separare la scienza del movimento storico e sociale dai valori, chiamiamoli immaginari utopistici, che vogliono invece sovrapporsi a questo movimento e per sovrapporsi poi lo vanno a fermare. E questo è quello che fanno nella società attuale i cosiddetti socialdemocratici, detti sempre più spesso social-liberisti. Il concetto quindi di socialismo scientifico è legato al movimento delle classi, all’organizzazione della classe, all’organizzazione nell’antagonismo, allo sciopero.
Sì dunque alle coalizioni, al sindacato, ma che tutto questo abbia esiti politici che assumano quindi il momento della costituzione di una nuova classe. Confondere quindi valori e dialettica significa non capire che serve stabilire un nesso tra una prassi reale e l’interpretazione scientifica della prassi. Marx non vuole togliere il male dal mondo, ma vuole costruire una scienza della pratica che rafforzi la consapevolezza teorica delle radici che stanno a combattere, diciamo così, lo stato presente delle cose per superarlo. Nell’interesse della classe, attraverso l’antagonismo di classe e attraverso, ovviamente, il superamento di ogni concezione, chiamiamola così, prettamente idealista.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa