Il modo di produzione capitalistico è incentrato su una intensificazione sempre più alta dello sfruttamento dei lavoratori tramite l’estorsione diversificata del plusvalore, assoluto e relativo, riportando in auge la questione trattata da Marx in Miseria della filosofia e in Salario, prezzo e profitto e Lavoro salariato e Capitale Nella società capitalista, il lavoratore è obbligato a vendere la propria forza lavoro, un concetto che Marx definisce come schiavitù del lavoro salariato. Questo fenomeno rappresenta una nuova forma di schiavitù, questa volta basata sulla questione di classe. La forza lavoro stessa diventa una merce, separata dalla sua attività lavorativa, che diventa un mero strumento per sopravvivere.
In questa dinamica, si perde la connessione con la creatività e il prodotto del proprio lavoro.
L’attualità della filosofia di Marx in “Miseria della filosofia” dimostra quali siano le leggi dello sfruttamento del capitalismo anche odierno e spiega il perché della richiesta del salario minimo, della riduzione dell’orario di lavoro oppure della necessità di una legge che disciplini fino in fondo quelli che vengono chiamati incidenti sul lavoro e che sono veri e propri omicidi sul e per il lavoro.
In Salario, prezzo e profitto, l’argomento centrale riguarda il sostegno all’idea che l’aumento dei salari è la causa non dell’incremento dei prezzi, bensì della diminuzione del saggio di profitto, sottolineando che il livello salariale è una questione politica più che economica. Nel capitolo dedicato al capitale, Marx esplora la natura e le contraddizioni del sistema economico capitalistico. Il capitale non è semplicemente considerato come una forma di ricchezza, ma come un rapporto sociale basato sull’accumulazione e lo sfruttamento.
Nel rispondere al cittadino Weston sulla questione dei salari nominali, Marx contrasta l’opinione di coloro, come i socialisti utopisti, che sostenevano che un aumento salariale sarebbe stato assorbito dall’incremento dei prezzi.
Marx, al contrario, collega l’aumento dei salari nominali al saggio del profitto: un incremento nei salari genera un aumento nella domanda di beni di prima necessità. I capitalisti che producono tali beni, per compensare la riduzione del saggio di profitto dovuta all’aumento dei salari, temporaneamente aumentano i prezzi di mercato.
In un sistema ipoteticamente basato sulla libera concorrenza, secondo Marx (benché egli sottolinei che tale sistema non esista), il capitale e il lavoro si spostano da settori meno redditizi a quelli più redditizi. Egli evidenzia le contraddizioni nelle argomentazioni di Weston, enfatizzando che il valore di una merce è determinato dal valore del lavoro, rilevando una tautologia nella quale il valore è determinato dal valore stesso. I prezzi di produzione delle merci, sono quindi solo una forma fenomenica poiché proprio il fenomeno della quantità di lavoro medio sociale incorporato nella produzione di ciascuna merce deve comprendere la determinazione della forza lavoro.
Non si può capire Marx e non si può capire Salario, prezzo e profitto e la questione del lavoro in generale, se non si affronta il concetto di alienazione. Questo concetto è fondamentale perché rimanda ad una condizione in cui l’essere umano si trova distante o, come dice la parola stessa estraneo, da sé stesso, dal proprio lavoro, dai prodotti di quest’ultimo all’interno di una società capitalistica. Questa situazione è intrinseca al sistema economico e sociale e si manifesta in diversi aspetti : evidenzia un senso di perdita di controllo, di connessione con la propria umanità.
Il lavoro non solo crea beni, ma riproduce anche se stesso, trasformando il lavoratore in una merce.L’oggetto del lavoro, frutto dell’impegno lavorativo, si presenta al lavoratore come un ente estraneo, una forza indipendente al suo controllo. Questo processo, chiamato oggettivazione, si evolve poi in alienazione, generando una profonda estraneità rispetto a ciò che è stato creato. Questa alienazione si estende anche alle relazioni sociali, dove le connessioni umane si trasformano in transazioni commerciali.
David Ricardo, uno dei principali economisti classici, ha formulato la teoria del valore-lavoro, secondo la quale il valore di una merce è determinato dalla quantità di lavoro necessario per produrla. Questa teoria rappresenta una pietra miliare nell’economia politica, fornendo una base per comprendere come il valore è generato nel processo produttivo. Le posizioni di Ricardo sviluppate agli inizi dell’Ottocento nei Principi ponevano al centro due fattori fondamentali:
a. Il primo era che il valore di ogni merce fosse determinato solo dalla quantità di lavoro necessario per la sua produzione;
b. Il secondo prevedeva che il prodotto del lavoro sociale fosse ripartito nelle tre classi: dei proprietari terrieri la rendita, dei capitalisti il profitto e dei lavoratori il salario.
Questo faceva sì che con le ipotesi di Ricardo nascessero le prime proposte socialiste come per esempio quelle di Robertus nel 1842, in cui si metteva in evidenza un passo avanti rispetto alle teorie economiche precedenti.
Robertus è il fondatore del socialismo tedesco e come tale è stato riconosciuto. Egli sottolineava come il lavoro fosse la fonte di tutto il valore e criticava il sistema capitalistico per la sua ingiusta distribuzione della ricchezza. Robertus ha evidenziato come il capitalismo conducesse a una distribuzione della ricchezza estremamente diseguale, con la maggior parte dei profitti accumulati dai capitalisti a spese dei lavoratori. Proponeva quindi riforme significative per migliorare le condizioni dei lavoratori, come la regolamentazione dei salari e la riduzione dell’orario di lavoro. Queste proposte erano viste come un passo verso una società più giusta.
Quale è la critica che si può fare a questa posizione? Marx nel 1859 con “Per la critica dell’economia politica” mette in evidenza un fatto fondamentale: se il valore di scambio di un prodotto è uguale a quello del tempo di lavoro allora il valore di scambio di una giornata di lavoro deve necessariamente essere uguale a quella del relativo prodotto della giornata di lavoro, pertanto il salario deve essere uguale al prodotto del lavoro.
Quello che avviene nella realtà invece è esattamente il contrario come evidenzia bene Engels nella sua prefazione alla prima edizione tedesca dell’opera “Miseria della filosofia”. Quest’opera mette ben in evidenza gli aspetti che Marx poteva trarre dalle conclusioni di Ricardo oltre ad essere l’opera che ha portato a giudizi sulla questione del plusvalore, arrivando poi ad una nuova teoria del plusvalore che supererà le posizioni di Ricardo. La teoria del valore-lavoro di Ricardo, nelle mani di Marx, diventa uno strumento per rivelare lo sfruttamento intrinseco del capitalismo necessitando di una sua abolizione totale. Ricardo accetta le categorie economiche di lavoro, di capitale, di valore in una maniera che non si limita all’apparenza e al contenuto.
L’opera “Miseria della filosofia” di Marx viene composta tra il 1846-1847 ovvero quando aveva conosciuto l’opera di Proudhon “Il sistema delle contraddizioni economiche” o “La Filosofia della Miseria” che conteneva la proposta di scambiare le merci secondo il cosiddetto “valore costituito” ovvero il valore del lavoro in esse contenuto.
In questo modo il lavoro sarebbe stato equamente retribuito e si sarebbe realizzata l’eguaglianza tra gli uomini. Nell’opera inoltre Proudhon si scaglia contro le prospettive rivoluzionarie e comuniste e sostiene l’inutilità, anzi, la dannosità delle lotte per il miglioramento dei salari dei lavoratori . Questa fornisce una riflessione per Marx per studiare i principi delle idee che hanno avuto seguito nello sviluppo del pensiero dei socialisti francesi. Proudhon aveva discusso molte volte con Marx sui problemi dell’economia e la sua opera aveva già da subito suscitato l’interesse del pensatore tedesco che formulò una risposta per rompere con una logica che poteva essere sicuramente distorsiva per la classe operaia.
Proudhon e Marx sono un binomio che, nel tempo, continua a suscitare entusiasmi ma anche aspre critiche. Il francese, nella sua dedizione al pensiero utopico, è considerato, non senza laceranti contrasti, un riformatore genuino ed un autentico rivoluzionario. Karl Marx, difatti, nelle sue opere giovanili, con grande entusiasmo, dichiara che il concetto di “proprietà” di Proudhon è il manifesto del pensiero filosofico-politico del proletariato moderno ed è una dichiarazione di guerra al sistema capitalistico. In seguito, quando il suo pragmatismo si è perfezionato, uscendo dalle nebulose spirali dell’utopia, egli rompe con Proudhon.
L’opera “La Miseria della filosofia” è la risposta del filosofo tedesco a tale rottura. In esso Marx analizza la filosofia proudhoniana e la ricondurrà ad una semplice espressione del pensiero piccolo-borghese.
Vi era una netta contrapposizione filosofica tra i due, apparivano due diverse metodologie per affrontare la questione sociale che a quel tempo s’imponeva come complessità di pensiero e per la drammaticità delle condizioni di vita dei lavoratori. Marx pensa in maniera chiara che l’approccio di Proudhon sia un approccio social-democratico e della sinistra borghese, e per tale ragione non ha mai goduto di simpatie particolari per la sua opera; in realtà il vero motivo era legato al fatto di mettere in evidenza gli aspetti fondamentali del socialismo moderno. Il socialismo moderno e quello di Proudhon erano parte dell’economia politica borghese e si richiamavano alla teoria del valore di Ricardo.
Questo tema ritorna fortemente nei Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica che era il testo preparatorio di Per la Critica dell’economia politica, che viene pubblicato per la prima volta nel 1859. Gli appunti, concepiti senza una struttura specifica per la pubblicazione, presentano un approccio libero focalizzato su due concetti principali: il denaro e il capitale. Marx analizza il denaro non solo come mezzo di scambio, ma soprattutto come una forma di potere che agisce come intermediario nelle relazioni tra individui, influenzando la vita economica e sociale.
Marx è stato il primo ad usare questo metodo, che nelle Tesi di Feuerbach del 1845 dice «i filosofi avevano solo interpretato il mondo, ora è tempo di cambiarlo», ponendosi il problema del metodo scientifico nel marxismo e il nostro compito è quello di attualizzare le questioni che Marx descriveva in Salario, prezzo, profitto e in Lavoro salariato e capitale, e in Per la critica dell’economia politica, nei Grundrisse e nel Capitale. Bisogna fare un’ulteriore precisazione: Marx, e a questo si deve la sua profonda attualità nel nostro tempo, non descrive la società a lui contemporanea, non enuncia concetti, ma li deduce. Marx attraverso un’analisi di comprensione non si sofferma al solo fenomeno nell’apparenza, ma arriva al cuore del problema.
La condizione del lavoratore si deteriora proporzionalmente all’aumento della ricchezza che contribuisce a produrre. La dignità del lavoratore si erode con l’aumento della quantità di merci generate. Questo declino dell’umanità è in parallelo con l’incremento del valore del mondo materiale.
Il lavoratore deve essere portato a capire che le leggi dell’economia, per poter cambiare lo Stato presente delle cose, si deve partire dallo sfruttamento del lavoratore e dalla sua oppressione e pertanto, bisogna capire le analisi reali, non quella intuitiva dei rapporti capitalistici.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa




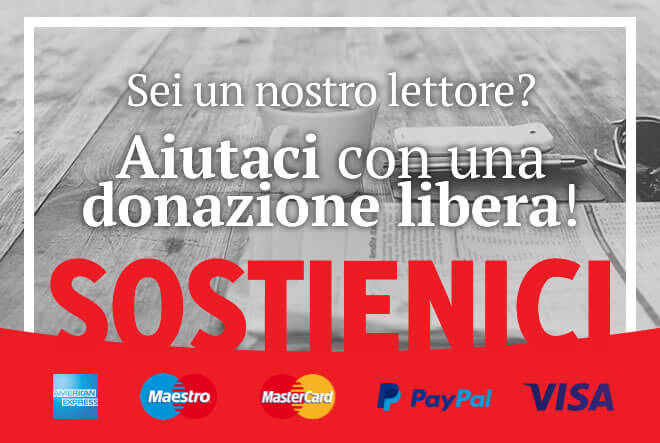
Cesare
Chiedo scusa, ma credo che, data la situazione tragica nella quale versa la sinistra marxista oggi in Italia, sia tempo sprecato occupare spazio con queste ottime (sia chiaro!) analisi; le teste migliori dovrebbero inderogabilmente sforzarsi di pensare un’uscita da questa empasse, fosse quella che fosse.