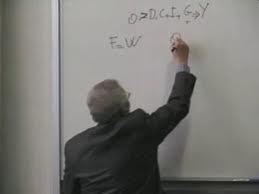1. Lo scambio capitalistico D–M–D’ (con D’>D) può presentarsi in tre modi: come capitale commerciale con cui si comperano merci a buon mercato per rivenderle più care giusto uno scambio a valori non equivalenti (quello che uno guadagna, l’altro lo perde): D<M<D’; come capitale industriale con cui si comperano mezzi di produzione e forza-lavoro per produrre merci poi vendute ad un valore superiore del valore anticipato per l’aggiunta del plusvalore ottenuto mediante lo sfruttamento del lavoro salariato: D=M…Produzione…M’=D’; infine come capitale finanziario, con cui si prestano denari per riceverli alla scadenza, senza nemmeno bisogno di transitare per le merci, maggiorati dell’interesse, così che lo scambio è di nuovo a valori non equivalenti: D<D’. Come si vede è soltanto il capitale industriale a rispettare la regola dell’equivalenza degli scambi, il che vuol dire che entrambe le parti implicate ci guadagnano perchè nuova ricchezza è creata, mentre nel capitale commerciale e finanziario ci scambi appena la ricchezza esistente.
Ora il grande storico economico Fernando Braudel ha notato che quando una nazione capitalistica egemone arriva a farsi dominare dalla dimensione finanziaria, essa ha raggiunto la propria maturità e si prepara ad entrare nella stagione dell’autunno. Ciò è successo al capitalismo olandese all’inizio del Settecento, al capitalismo britannico tra Otto e Novecento e adesso a quello americano. A proseguire il discorso è intervenuto Giovanni Arrighi con il suo Lungo XX secolo (Milano, 1999) introducendo l’idea del ciclo sistemico d’accumulazione vissuto dal “centro” capitalistico egemone che si compone one di una fase di espansione produttiva e poi di una fase di espansione finanziaria. Una nazione arriva a porsi come luogo capitalistico centrale quando è in grado di concentrare su di sé una potenza economica e militare sufficiente a coinvolgere il resto del mondo (la “periferia”) in una strategia di sviluppo basata su di una divisione del lavoro condivisa. Durante questa fase di espansione produttiva il “centro” crea manufatti che esporta verso la periferia, che in cambio cede materie prime. L’espansione finanziaria subentra invece quando al “centro” l’investimento dei capitali si sposta dalla produzione industriale all’attività speculativa, ossia alla compravendita di titoli e quant’altro allo scopo di guadagnare, in Borsa e non più in fabbrica, invece del profitto le più comode rendite finanziarie. Questo era già stato riconosciuto da Marx: «con l’accrescimento della ricchezza materiale si accresce la classe dei capitalisti monetari, aumenta da un lato il numero e la ricchezza dei capitalisti che si ritirano, dei rentiers, e in secondo luogo viene stimolato lo sviluppo del sistema creditizio e si accresce quindi il numero dei banchieri, di coloro che danno il denaro a prestito, dei finanzieri ecc.» (Il capitale. Libro terzo, Roma, 1965, p. 599).
Nel concreto, per Arrighi il passaggio dalla produzione del profitto al guadagno dell’interesse è indicato da una crisi-spia (avvenuta nel 1870-73 per la Gran Bretagna, nel 1971-73 per gli Stati Uniti) che «segna un punto di svolta, un momento cruciale di scelta, in cui l’agente dominante dei processi sistemici di accumulazione del capitale palesa, mediante lo spostamento, un giudizio negativo sulla possibilità di continuare a trarre profitto dal reinvestimento dei capitali eccedenti nell’espansione materiale dell’economia-mondo e, insieme, un giudizio positivo sulla possibilità di prolungare nel tempo e nello spazio la sua leadership/dominio grazie ad una maggiore specializzazione nell’alta finanza» (Il lungo XX secolo, cit., p. 283). Ma perchè c’è convenienza allo spostamento? Dipende dal confronto tra il profitto del produrre e il guadagno della finanza: quando il secondo supera il primo perchè i profitti sono caduti (ad es. per la pressione salariale dei lavoratori) oppure perchè l’interesse è aumentato (per es. per decisione dell’autorità monetaria), allora «un numero crescente di organizzazioni capitalistiche si asterrà dal reinvestire i profitti nell’ulteriore espansione dello scambio di merci e le loro eccedenze monetarie saranno dirottate dalle transazioni in merci a quelle monetarie» (idem, p. 302). Ne risulta che a guadagnarci non sono più tanto i capitani d’industria, ma quella «aristocrazia finanziaria» già descritta da Lenin nell’Imperialismo come fase suprema del capitalismo che finisce per dividere il mondo «in un piccolo gruppo di Stati usurai e in una immensa massa di Stati debitori».
E’ovvio che col passaggio al capitalismo finanziario ci siano ancora occasioni di guadagno. Eppure questo è il segnale del tramonto dell’egemonia di quel “centro” capitalistico, perché l’espansione finanziaria non è mai «l’espressione di una soluzione durevole della crisi sistemica sottostante. Al contrario, essa è sempre stata il preludio ad un aggravamento della crisi e alla definitiva sostituzione del regime di accumulazione ancora dominante con uno nuovo» (idem, p. 283). A decidere il trapasso definitivo occorre però una crisi terminale che traslochi geograficamente il “centro” capitalistico in altro luogo, come è accaduto durante la Grande Crisi del 1929-33 con il trasferimento dell’egemonia da Lombard Street (Londra) a Wall Street (New York). Così per Arrighi, se è «cruciale l’idea di Braudel dell’“autunno” come fase conclusiva di un processo di direzione nell’accumulazione, da quella materiale a quella finanziaria fino all’emergenza di un’altra guida, lo è pure l’idea di Marx che l’autunno di uno stato che sperimenta l’espansione finanziaria è anche la primavera di un altro luogo: i surplus che si accumulano a Venezia vanno in Olanda; quelli che si accumulano in Olanda vanno in Gran Bretagna; e quelli che si accumulano in Gran Bretagna vanno negli Stati Uniti. In tal modo Marx completa ciò che è insito nell’idea di autunno di Braudel: l’autunno diventa primavera in qualche altro luogo» (G. Arrighi, The winding paths of capital, “New Left Review”, 2009).
2. Con la sconfitta definitiva di Napoleone a Waterloo si sono poste le condizioni per l’affermazione della egemonia del capitalismo britannico sul pianeta. Essa è stata però materialmente sostenuta dalle due innovazioni della rivoluzione industriale e del mercato mondiale. Con la prima si tagliavano radicalmente i costi di produzione delle merci mediante sostituzione della fatica dell’uomo (e degli animali) con il “lavoro” delle macchine; con il secondo il mondo è stato ridotto ad unità degli scambi con Londra che diventata non solo la capitale della “fabbrica del mondo”, ma anche il luogo di coniazione della moneta universale: la sterlina a contenuto aureo. Di tanto doppio risultato è stato consapevole Karl Marx che nel 1858 segnalava come «il compito proprio della società borghese è quello di creare il mercato mondiale, almeno nelle sue grandi linee, e una produzione basata sulle sue fondamenta» (India Cina Russia, Milano, 1960, p. 413), mentre Frederick Engels ex post ha dettagliato: «questo mercato mondiale consisteva allora di una serie di paesi ancora prevalentemente o esclusivamente agricoli, raggruppati intorno ad un grande centro industriale: l’Inghilterra. Quest’ultima consumava la maggior parte dei loro prodotti greggi eccedenti e in cambio provvedeva alla maggior parte del loro fabbisogno in prodotti industriali. Nessuna meraviglia, quindi, se il progresso industriale dell’Inghilterra fu grandioso ed eccezionale» (Prefazione 1892 a La situazione della classe operaia in Inghilterra, Roma, 1992, pp. 28-29).
La “crisi-spia” del 1873 doveva però spingere l’accumulazione del capitale britannico verso l’investimento finanziario, convertendo gli industriali a quel gioco di Borsa in cui «i borghesi non sfruttano gli operai, ma si sfruttano fra di loro» (F. Engels, in K. Marx, F. Engels. Lettere gennaio 1893-luglio 1895, vol. 50, Roma, 1977, p. 17). Così la Gran Bretagna entrava nella sua stagione dell’autunno, come spiegava Engels nel 1894 nelle Considerazioni supplementari al terzo libro del Capitale: «dopo la crisi del 1866 l’accumulazione si è sviluppata con una rapidità sempre crescente, ed in modo tale che in nessun paese industriale, ed in Inghilterra meno che altrove, l’ampliamento della produzione ha potuto seguire quello che dell’accumulazione… Si è così accresciuto il numero dei rentiers, della gente che era sazia della continua tensione degli affari, che non desiderava dunque che divertirsi od occupare dei posti poco faticosi di direttori o di membri dei consiglio di amministrazione di società» (F. Engels in K. Marx, Il capitale. Libro terzo, pp. 48-49). Ma se la Gran Bretagna si “finanziarizzava”, già premevano sulla scena del mondo altri pretendenti come «la Francia, la Germania e soprattutto l’America che… spezzano progressivamente il monopolio industriale dell’Inghilterra. La loro industria è giovane rispetto a quella inglese, ma cresce con una rapidità maggiore di quella» (F. Engels, Prefazione 1892, cit., p. 31). Così quando Engels visitò gli Stati Uniti nel 1888, non ci mise molto a capire che lì sarebbe finito il “centro” del capitale: gli USA sarebbero diventati «il più grande stato del XX secolo» e New York la futura «metropoli della produzione capitalistica» (cit. in G. Mayer, Friedrich Engels. La vita e l’opera, Torino, 1969, p. 289). Sarebbe stata «una svolta che stupirà il mondo intero. Se gli americani incominciano, lo faranno con un’energia e una violenza a paragone delle quali noi in Europa saremo come bambini» (in K. Marx, F. Engels, Lettere gennaio 1891-dicembre 1892, vol. 49, Roma, 1982, p. 325).
3. Ha sintetizzato Peter Taylor (Forum on Hegemony and social change, “Mershon International Studies Review”, 1994, n. 38, p. 364) che «i britannici hanno creato il primo stato industriale come officina del mondo. Il primo motore è stata la produzione e l’esportazione nel mercato mondiale e, per competere, altri stati hanno dovuto industrializzarsi. Gli americani hanno creato il primo stato delle grandi imprese basato sulla società affluente: il primo motore è stata una combinazione di produzione e consumo e, per competere, altri stati hanno dovuto muoversi verso il consumo di massa». Vero: è stata proprio la società dei consumi sulla base della produzione fordista a costituire la “cifra” della egemonia capitalistica americana sul mondo nel Novecento.
E dire che gli Stati Uniti avevano cominciato come un classico paese di “periferia” che esportava materie prime ed importava manufatti. Solo a seguito della Grande Guerra, in cui non furono direttamente coinvolti, sono riusciti a mutare la loro posizione mettendosi ad esportare manufatti per i paesi belligeranti che pagavano con moneta aurea, così che al termine del conflitto si sono ritrovati possessori di consistenti riserve di oro. La seconda guerra mondiale ha ripetuto il processo e quando nel 1944 la Gran Bretagna, economicamente esaurita, ha dovuto cedere la supremazia monetaria internazionale, è stato il dollaro, convertibile in oro a cambio fisso, a sostituirsi alla sterlina quale moneta universale (con grande disappunto di John Maynard Keynes che ne morì). Ma c’era pure da ricostruire l’Europa e quale migliore occasione di servirsi proprio dei dollari, generosamente concessi dal Piano Marshall, per indurre gli europei in miseria ad acquistare le merci americane esuberanti? D’altra parte la presenza, dietro la “cortina di ferro”, di un antagonista sistemico come l’Unione Sovietica li costringeva ad abbandonare le rivalità imperialistiche che avevano insanguinato la prima metà del Novecento ed a ripararsi sotto l’unico ombrello (anche atomico) americano, assegnando così agli Stati Uniti quella posizione di superimperialismo che Kautsky aveva ritenuto possibile e Lenin no (ma Lenin aveva scritto prima della nascita dell’URSS).
Giovanni Arrighi conclude il suo Lungo XX secolo con la descrizione del ciclo di vita del capitalismo americano. Esso è stato inaugurato con l’imposizione a tutto il “mondo libero” (come si autodefiniva) di un modello di “New Deal planetario” che apriva le porte alla piena occupazione e al consumo di massa, in alternativa vincente verso quei movimenti politico-sociali che si richiamavano invece al comunismo. La liquidità monetaria necessaria ai maggiori scambi internazionali era peraltro assicurata dalle esigenze militari americane e, siccome il governo di Washington «operava come banca centrale mondiale estremamente permissiva, l’espansione del commercio e della produzione mondiali avvenne a ritmi senza precedenti» (idem, p. 388). E’ solo con la prolungata e costosa guerra del Vietnam che si è rotto il meccanismo: quando i dollari emessi per finanziarla hanno preso a superare di gran lunga le riserve auree poste a garanzia, di fronte al rischio di insolvenza non c’è stato altro rimedi (nel 1971) che togliere quella convertibilità dei dollari in oro decisa a Bretton Woods. Ma a far data sulla crisi-spia dell’egemonia americana vale anche la quasi contemporanea decisione di passare dal cambio fisso tra le monete al regime dei cambi flessibili, così che «da quel momento in poi è stato il mercato ad assumere il controllo del processo che fissava i prezzi delle monete nazionali l’una rispetto all’altra e rispetto all’oro» (idem, p. 392). Si inaugurava in questa maniera il grande gioco della speculazione finanziaria attorno al valore, sia pure virtuale, del dollaro rispetto ad ogni altra moneta e che continua tuttora con la sola differenza che l’euro ha preso il posto del marco e lo yuan si sta affacciando sulla scena.
Ma come rendere appetibile una moneta di carta senza più un contenuto metallico alle spalle? E’ stato questo il “miracolo” della reaganomics con la sua politica degli alti tassi d’interesse, così che i dollari che si guadagnavano ad esportare manufatti negli USA (come avevano preso fare l’Europa e l’Estremo Oriente) venivano prontamente restituiti al governo di Washington in cambio dei suoi più che redditizi Buoni del Tesoro. Così facendo gli Stati Uniti si sono trasformati nel paese più indebitato del mondo e questa trasformazione è stata giudicata da Kevin Phillips fin dal 1993 come il segnale più evidente della senilità dell’impero americano perchè «l’eccessiva attenzione verso la finanza e la tolleranza nei confronti del debito sono tipiche delle grandi potenze economiche nel corso delle ultime fasi del loro dominio. Esse ne preannunciano il declino economico». Siccome «solo un piccolo gruppo di popolazione nazionale può ripartirsi i profitti della borsa e dell’intermediazione finanziaria», è storicamente accertato che «la finanza non può alimentare una vasta classe media» e per questo col passaggio alla finanza «le società con ampi ceti medi perdono qualcosa di vitale e di unico. Proprio ciò che alcuni temono si stia nuovamente verificando negli Stati Uniti alla fine del XX secolo» (cit. in Arrighi, p. 411).
4. Ma qui necessita un approfondimento. Ciò che di vitale e dinamico si perde col passaggio alla finanza è, per usare una immagine ad effetto, la “pancia” della composizione di classe. La quale nel Novecento non aveva più quella forma a piramide con poca alta borghesia al vertice, la piccola borghesia nel mezzo e tanto proletariato sul fondo che era stata propria del capitalismo britannico. Invece il capitalismo fordista (o “americano” che dir si voglia) l’ha trasformata in una trottola (geometricamente: due piramidi unite per la base) con al centro una nuova e consistente “classe media” fatta di lavoratori autonomi e liberi professionisti, tecnici, impiegati e burocrati che si sono resi necessari per assicurare il consumo di massa adeguato ad una produzione diventata anch’essa di massa. E’ stata questa la realtà (e non soltanto il mito) che ha permesso l’esportabilità planetaria dell’american way of life: la casa di proprietà con giardino prospiciente, l’automobile in garage, gli elettrodomestici in ogni stanza, i figli all’università, le vacanze al mare o in montagna e la pensione al termine dell’età lavorativa. Con una ricaduta anche politica, perché «il ruolo politico della middle class, con il dispiegarsi del progresso materiale, è stato soprattutto quello di contenere la spinta sovversiva della classe operaia» (M. Gaggi e E. Narduzzi, La fine del ceto medio, Torino, 2006, p. 8), così che la “conquista dei ceti medi” era diventata la parola d’ordine della stabilità politica.
Poi è arrivata la globalizzazione dei mercati e la rivoluzione dei trasporti che hanno consentito di delocalizzare le produzioni in “periferia” per aggirare il maggior costo della manodopera al “centro”, mentre i capitali in esubero si sono indirizzati verso la speculazione finanziaria che paga bene i propri dipendenti, che però sono pochi. E così, mentre c’era chi teorizzava l’ingresso in uno stadio superiore del capitalismo che abbandonava la fatica “sporca” del proletariato per sostituirlo con il lavoro immateriale di un improbabile cognitariato, una piccola parte del ceto medio (funzionari di banca e della politica, dell’informazione e dell’intrattenimento) è stata promossa ad “aristocrazia stipendiale” al servizio di una classe di superricchi che nel mondo sarebbero appena 6000 (giusti i calcoli di D. Rothkopf, Superclass. La nuova élite globale e il mondo che sta realizzando, Milano, 2008). E tutto il resto? Per l’introdotta (ed in corso di generalizzazione) precarietà d’occupazione sta precipitando verso il basso, verso una condizione di basse retribuzioni che riporta alla luce «un modello sociale ferocemente classista e profondamente gerarchico. La disuguaglianza, prima proposta come conseguenza spiacevole ma inevitabile della selezione meritocratica del mercato, si rovescia in valore auspicabile in sé, per il quale gli uomini si dividono naturalmente in classi e devono essere distinti tra ricchi e potenti e poveri e ininfluenti, in quanto sarebbe contro natura il contrario» (A. Giannuli, 2012: la grande crisi, Milano, 2010, p. 191).
La nuova forma che la composizione di classe sta assumendo con questo strangolamento economico dei ceti medi è quindi “a clessidra” (geometricamente: due piramidi unite per la punta) o piuttosto a caciocavallo con al vertice quei superricchi con il loro codazzo di clientes, in mezzo i ceti medi superstiti che si stanno “snellendo” sempre più e sul fondo una nuova ampia base di lavoratori “usa e getta” (ma se si dice “flessibili” sembra quasi un vanto). Però tutto questo avviene solo al “centro” del sistema capitalistico, perchè nella “periferia”, dove adesso si producono i manufatti che si consumano al “centro”, gli operai e le fabbriche crescono col risultato (mai da dimenticare!) che «la produzione materiale è ben lontana dall’essere diventata una irrilevante appendice finale del processo produttivo,… anche se le fabbriche non sono più a cinquecento metri da casa, ma a migliaia di chilometri, in Cina, India o Brasile» (A. Giannuli, op. cit., p. 183). Quindi resta un proletariato mondiale ed una produzione che non è mai stata di massa come adesso e che si riversa al centro per incontrare l’equivalente consumo di massa. Ma come si può garantire una domanda monetaria adeguata se quei ceti medi in caduta verso il basso della composizione di classe vedono decurtati i loro redditi? La soluzione trovata è stata quello del credito indiscriminato al consumo da parte di banche ed istituzioni finanziari compiacenti, che però si è subito infranto precipitando la forma americana del capitalismo verso quella che, per dirla con Arrighi, è la sua crisi terminale. Che è quella che stiamo vivendo e che merita di essere seguita (ed interpretata) con più attenzione.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa