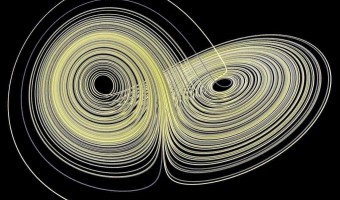E’ stato proprio al riguardo della vicenda della siderurgia, però, che il capitalismo italiano ha dimostrato tutta la sua grettezza, la sua incapacità d’innovazione, la sua pervicace volontà di sfruttamento intensivo e senza scrupoli non solo dei lavoratori della fabbrica ma anche dei cittadini e dello stesso territorio.
Sparisce la siderurgia da Piombino, si conclude una storia di 150 anni di lavoro operaio; a Taranto è esploso, invece, nello stesso settore produttivo il più grande conflitto tra la produzione e la salute che mai si sia verificato nella, tormentatissima (sotto quest’aspetto) storia dell’industria italiana :da Seveso all’ACNA, da Cornigliano alla Farmoplant, tanto per fare esempi del passato; mentre nel presente a Taranto si può affiancare la vicenda della centrale Tirreno Power a Vado Ligure.
E’ stato proprio al riguardo della vicenda della siderurgia, però, che il capitalismo italiano ha dimostrato tutta la sua grettezza, la sua incapacità d’innovazione, la sua pervicace volontà di sfruttamento intensivo e senza scrupoli non solo dei lavoratori della fabbrica ma anche dei cittadini e dello stesso territorio.
In un settore nevralgico per qualsiasi paese industriale (come del resto lo sono la chimica e l’energia) in un quadro di concorrenza globale, al riguardo della quale la stessa appartenenza all’Unione Europea non ha certo assunto una funzione positiva (pensiamo ad esempio alle delocalizzazioni attuate per ricercare ancor più intensivi meccanismi di sfruttamento), il disastro della siderurgia italiana deve essere attribuito a cause ben precise: la prima e la principale delle quali deve essere considerata quella relativa allo smantellamento delle Partecipazioni Statali e dell’IRI avvenuta a cavallo degli anni’80-’90 del secolo scorso, con conseguenti privatizzazioni selvagge.
Profittatori di lungo corso si gettarono sull’osso, Riva, Lucchini, semplicemente per spolparlo (come De Benedetti nell’energia, del resto) e i risultati sono questi che vediamo, drammaticamente, sotto gli occhi: migliaia di disoccupati, l’accumulo di un ritardo tecnologico enorme, danni irreversibili all’ambiente.
Tutto questo senza suscitare un moto di coscienza in chi, governando la politica e l’economia, ha causato questi danni enormi.
Poche righe credo sia sufficienti per descrivere efficacemente questa situazione: si tratta di un’enorme questione morale che investe assieme i governanti e gli speculatori.
A quando una ribellione vera per contrastare un’ulteriore deriva verso l’abisso? A quando un’espressione di riflessione e iniziativa politica adeguata alla qualità di questo stato di cose e non rivolta, esaustivamente, alla ricerca dell’interesse di bottega se non addirittura personale?
All’inizio degli anni’60 si aprì, nella sinistra italiana, un’intensa discussione sulla natura del capitalismo nostrano: un “capitalismo straccione” che era, tutto sommato, da sostenere abbassando il tiro delle rivendicazioni operaie, oppure un capitalismo capace di fortissima innovazione cui contrapporre un’alternativa di sistema anche attraverso proposte dirette di politica industriale?
L’esito di quel dibattito fu comunque quella di una crescita della forza operaia, della capacità di rivendicazione e di contrattazione, di passaggio dal sindacato delle commissioni interne e della scissione degli anni’50, al sindacato dei consigli e dell’idea –forza dell’unità sindacale, lanciata a cavallo della grande stagione del 68-69 con la saldatura delle lotte studentesche con quelle operaie.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa