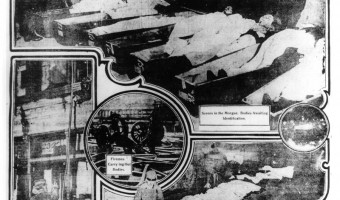A pagare di più, nonostante la retorica di imprese e governo, nonostante una serie di «riforme» che dovrebbero facilitarne l’occupazione in cambio di salari bassi e contratti precari, sono ancora una volta i giovani tra i 15 e i 24 anni. Per loro (e senza nemmeno calcolare i coetanei che frequentano scuola o università) il tasso di disoccupazione, a maggio, è arrivato al 29,6% (era al 28,8 un anno prima). Peggio accade solo per le donne meridionali, che sono costrette a restare inattive (o meglio: senza salario) per il 46,1%.
Il quadro dettagliato è però assai differenziato. Per esempio, risulta in calo il numero degli occupati «indigeni», ovvero italiani (-160.000 unità), mentre aumenta l’occupazione straniera (+276.000), in generale più ricattabile, debole, quindi obiettivamente «incentivata» a lavorare di più per meno soldi, meno sindacalizzata e priva di livelli di welfare familiare. Conferme indirette arrivano dalla dinamica occupazionale dell’industria, in lieve ripresa (+1,5%) dopo tre anni di calo rapido, così come il settore dei servizi (+0,9). Ma la nuova occupazione è spesso registrata nelle forme «autonome». Tra i dipendenti, invece, calano ancora quelli con contratto a tempo indeterminato (-0,1%), mentre le «assunzioni» crescono solo se si accetta il «part time involontario» (+2,3), oppure un contratto a termine (+4,1).
Di conseguenza, cresce anche la popolazione inattiva, ormai al 37,8% (+0,2) rispetto al 2010). Fenomeno, anche questo, fondamentalmente giovanile; al punto da far parlare ormai di una «generazione né né» (non studia e non trova lavoro).
Ma anche se si voleva vedere il «bicchiere mezzo pieno» – il calo del tasso di disoccupazione – diventa difficile ignorare il crollo dell’attività manifatturiera registrato nel mese di giugno. Una contrazione in parte attesa, ma che mette fine a 18 mesi di crescita continua, pur se del tutto insufficiente a recuperare i livelli produttivi pre-crisi (siamo ancora sotto del 5% circa rispetto al 2007. Soprattutto – fa notare l’indagine Markit Economics – l’indice Pmi (che misura l’attività produttiva e le attese relative) è sceso dai 52,8 punti di maggio ai 49,9 di giugno. Un calo drastico e preoccupante, anche perché «quota 50» è convenzionalmente citata come il discrimina tra l’espansione economica e la contrazione.
È il punto più basso fatto segnare dall’ormai «lontano» ottobre 2009, a un anno di distanza dal croci di Lehmann Brothers che aveva innescato un blocco dell’attività economica globale. Per quanto riguarda lo specifico italiano, inoltre, la responsabilità principale di questo calo viene addebiatat alla «debolezza della domanda interna». In altre parole: la popolazione consuma meno, compra meno merci, le imprese vendono meno e tagliano sia la produzione che l’occupazione (questi fenomeni non avvengono contemporaneamente, ma con un timing abbastanza studiato da risultare «scientifico»). Il problema è che tutte le ricette o «riforme» economiche – consigliate dalla Ue e creativamente adattate dal governo – prevedono ulteriori riduzioni di reddito disponibile. Ancora meno consumi, dunque; e quindi nuovo calo di produzione e occupazione.
da “il manifesto” del 2 luglio 2011
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa