Un modello produttivo che giunge alla fine – come ogni altra cosa – costringe a prendere decisioni apertamente contrastanti con il business as usual. O almeno dovrebbe farlo.
Ma la classe dirigente italiana – gli imprenditori e quella feccia che ancora chiamiamo “classe politica” – non è assolutamente in condizioni neanche di prendere atto che quel ciclo è finito.
I primi perché continuano a prosperare, individualmente e come insieme, grazie alla passiva prosecuzione delle vecchie abitudini (a alla svalutazione totale del lavoro, che consente loro di incamerare profitti crescenti anche a parità di fatturato). La secondo per un orribile deficit cognitivo e di autonomia strategica.
Il modello che sta tirando le cuoia è quello che ha trasformato l’industria italiana in subfornitrice di quella tedesca. La spiegazione fornita da Guido Salerno Aletta nel suo editoriale su TeleBorsa è su questo tema illuminante:
“ci troviamo di fronte ad una relazione tra industria italiana ed industria tedesca che è stata strutturalmente squilibrata a nostro detrimento, visto che le industrie del Nord dell’Italia lavorano a rimorchio delle commesse tedesche, dando occupazione e prosperando dal punto di vista degli utili, ma ad un prezzo che poi viene pagato dall’intera collettività nazionale che importa le merci dalla Germania ad un prezzo che incorpora il valore aggiunto prodotto dalle industrie italiane cui viene aggiunto un consistente margine di profitto.”
Tra prosperità di imprese “subordinate” e declino del Paese non c’è contraddizione, ma consente di constatare la falsità dell’approccio trickle down, quella narrazione secondo cui “solo le imprese creano lavoro” e quindi “bisogna evitare di infastidirle”, perché prima o poi qualche briciola “sgocciolerà” dalla loro tavola imbandita verso le bocche affamate del popolo che lavora.
Ma consente anche di vede come si sia creata una vera contraddizione tra un’economia integrata con le filiere del valore tedesche mentre “la politica” va aumentando costantemente la propria subordinazione agli Stati Uniti. Una scelta molto simile a quella dei paesi dell’Est, e che incentiva probabilmente anche soluzioni reazionarie sempre più chiare, vista l’impossibilità di dare risposta ai bisogni sociali (la politica economica dipende dalla Ue, quella estera dagli Usa; ossia la paralisi).
In ogni caso, dicevamo, questo modello sta tirando le cuoia. Ma non solo non ce n’è un altro sostitutivo (specie da rendere operativo in tempi brevi), ma manca persino la consapevolezza di doverselo inventare.
Il “driver” di questo possibile “rinnovamento”, in altri tempi, sarebbe passato per l’intervento pubblico sulla struttura produttiva, con la la creazione di imprese produttive, non solo infrastrutture e “incentivi fiscali” (che oltretutto riducono grandemente le entrate per lo Stato).
Ma, avverte anche Salerno Aletta, così non può essere questa volta perché il “patto di stabilità europeo” vincola le mosse possibili per qualsiasi esecutivo. E in quello spazio sempre più stretto il deficit pubblico finisce pressoché interamente nel pagamento degli interessi sul debito pubblico.
Come se ne esce? Un’indicazione indiretta viene proprio dalle cause della fine del vecchio modello (integrazione con le filiere tedesche): se la prosperità delle imprese è andata in contraddizione totale con lo sviluppo equilibrato del Paese, sarà il caso di pensare e lavorare ad un modello che le subordina in modo anche radicale ai bisogni collettivi.
Che non sono soltanto quelli della “equa redistribuzione della ricchezza” (secondo una visione ingenua e pauperistica della politica economica), ma anche la realizzazione di uno sviluppo vero, complessivo, pensato e voluto. Insomma: programmato e pianificato.
Per cambiare modello, insomma, occorre saper cambiare sistema. Altrimenti affondiamo nel fango mentre pochi squali prendono il largo su yacht sempre più lussuosi…
Buona lettura.
*****
Italia-Germania: verso il Decoupling?
Guido Salerno Aletta – Agenzia Teleborsa
Troppi elementi di disturbo, negli scorsi anni, hanno fatto perdere la traccia profonda dei processi di crescita economica all’interno di un quadro sostenibile dei conti pubblici e dell’equilibrio dei saldi con l’estero.
Partiamo da questi ultimi, condizionati come sono sia dalla adesione all’euro, che non consente svalutazioni competitive all’interno della Eurozona, che dalle relazioni industriali e commerciali dell’Italia che sono strutturalmente deficitarie nei confronti della Germania.
Dal punto di vista dell’export siamo subfornitori delle industrie tedesche, essendo pienamente integrati nella loro catena del valore al pari di tutti i Paesi dell’Est, contribuendo così a tenere bassi i loro costi di produzione ed alti i loro profitti, mentre dal punto di vista dell’import paghiamo le merci tedesche a prezzo pieno.
Nel 2020, a fronte di un saldo complessivamente passivo dell’Italia nei confronti della Eurozona pari ad appena 169 milioni di euro, quello nei confronti della Germania era stato di 5 miliardi e 221 milioni di euro.
Nel 2021, il saldo infra Eurozona dell’Italia era passivo per 5 miliardi e 230 milioni, mentre quello con la Germania era stato passivo per 9 miliardi e 540 milioni di euro.
Nel 2022, il saldo infra Eurozona era stato passivo per 13 miliardi e 930 milioni di euro, mentre quello con la Germania era stato passivo per 13 miliardi e 458 milioni di euro.
In pratica, ci troviamo di fronte ad una relazione tra industria italiana ed industria tedesca che è stata strutturalmente squilibrata a nostro detrimento, visto che le industrie del Nord dell’Italia lavorano a rimorchio delle commesse tedesche, dando occupazione e prosperando dal punto di vista degli utili, ma ad un prezzo che poi viene pagato dall’intera collettività nazionale che importa le merci dalla Germania ad un prezzo che incorpora il valore aggiunto prodotto dalle industrie italiane cui viene aggiunto un consistente margine di profitto.
Questa solida integrazione produttiva realizzata tra il Nord industriale dell’Italia con la Germania, e soprattutto con l’area renana e bavarese, è derivata soprattutto dalla dismissione da parte dell’Italia dei grandi insediamenti produttivi, dal settore metallurgico e quello automobilistico, fino alla chimica.
Ma ora questa sinergia è messa in discussione dalla transizione energetica, con l’abbandono forzato delle automobili con motori a combustione interna e dalla rinuncia al gas russo a costi convenienti anche da parte della Germania.
Occorre dunque guardare con particolare attenzione i dati destagionalizzati relativi alla produzione industriale italiana, senza fermarsi a quelli che riguardano i beni di consumo, durevoli e non durevoli, che pure segnano un andamento al ribasso: a marzo scorso, l’indice destagionalizzato e corretto per gli effetti del calendario relativo a questa categoria di beni (2015=100) è stato pari a 111,1 con una variazione negativa di -4,7 punti rispetto al marzo 2022.
Lo stesso è accaduto con i prodotti intermedi, con l’indice destagionalizzato che a marzo scorso ha toccato appena quota 98,4. Non solo questo valore è più basso di quello di ben otto anni fa, il 2015=100, ma è più basso di tutti quelli rilevati nel biennio 2021-2022, visto che il livello più alto era stato raggiunto nel luglio 2021 con 106,9.
Anche i corretti con gli effetti del calendario mostrano un andamento analogo: a marzo scorso l’indice è stato pari a 110,4 mentre era stato di 117,4 a marzo 2022.
Bisogna guardare all’economia reale, alla produzione industriale, visto che poi tutto si riflette a livello macroeconomico sulla crescita del PIL: sulla base del DEF 2023, quest’anno il PIL reale dovrebbe crescere solo dell’1%, mentre quello nominale del 5,8% visto che il deflatore del PIL (l’indicatore che misura l’inflazione complessiva, non solo quella dei prezzi al consumo) è previsto in crescita del 4,8%.
La crescita reale dell’1% nel 2023 verrebbe conseguita a fronte di un indebitamento netto del bilancio delle PA pari al 4,5% del PIL: ma, in pratica, la gran parte del deficit serve a pagare gli interessi passivi sul debito pubblico, con una spesa che è pari al 3,7% del PIL. All’economia reale andrà dunque solo un deficit netto pari allo 0,8% del PIL: una inezia, che infatti determinerebbe una crescita reale dell’1%.
Occorre una riflessione sulle strategie di sviluppo economico sul piano internazionale che l’Italia deve intraprendere nei prossimi anni, visto che sembra essersi esaurito il paradigma che nello scorso ventennio ha visto l’industria tedesca in grado di trainare l’intera economia europea, assorbendo buona parte della produzione industriale del Nord dell’Italia, rimasta in posizione gregaria come subfornitrice e con un saldo commerciale alla fine strutturalmente negativo.
C’è un intero mondo che cresce, e che ha bisogno di un sostegno allo sviluppo proprio nei settori tradizionali in cui l’industria italiana può integrarsi e farsi trainante.
E’ pericoloso affidarsi alla speranza che la crescita economica sarà trainata dalla transizione energetica e dalla decarbonizzazione della produzione, che aumenterà solo i costi per le imprese e per i cittadini.
Ed è un errore pensare che il deficit pubblico sarà il driver: non solo oggi, ma ancor più nel futuro, l’aumento dei tassi di interesse lo assorbirà sempre di più. Il DEF prevede che già nel 2024 l’indebitamento netto (il deficit) sarà pari al 3,7% del PIL, mentre l’onere per gli interessi sul debito sarà pari al 4,1% del PIL: in pratica, tutto il deficit non basterà neppure a pagare l’intera spesa per gli interessi.
Ci sarà dunque un impatto deflattivo sulla economia reale, a cui si aggiungerà quello già indotto dalle politiche monetarie restrittive.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa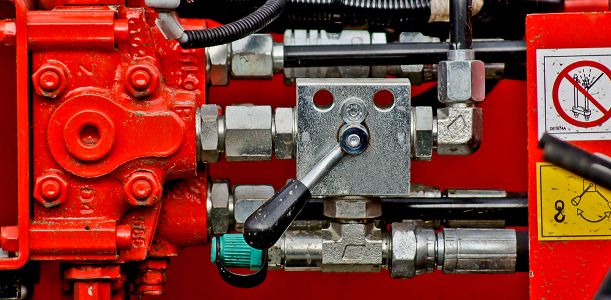




Stefano
Nella forma, trovo l’articolo uno sterile esercizio propagandistico, una sorta di spot pubblicitario infarcito di luoghi comuni finalizzati a suscitare, nel lettore piegato dalle proprie difficoltà economiche, sentimenti reazionari e persino autarchici, laddove il nemico sono i Paesi le cui economie più forti condizionano la nostra (più debole), e la colpa è loro, oltre che di una classe industriale tout-court inadeguata e poco lungimirante, abbinata ad una classe politica che è “feccia” del Paese (salvo essere l’espressione del popolo che la vota, ma questo è un dettaglio). Nel merito: parlare di “sviluppo” in questa condizione, laddove anche chi non si intende di macroeconomia intuisce che esiste un limite alla crescita della ricchezza globale e che questo limite è stato raggiunto da diversi lustri, solo che lo si è maldestramente nadcosto spostando il termine di riferimento dal valore del lavoro a quello dell’economia finanziaria, e che è proprio la sperequazione di questa ricchezza a stimolare la domanda di nuova ed ulteriore crescita, significa eludere il problema, e dunque non iniziare mai il cammino, lungo e doloroso, per risolverlo.
Redazione Contropiano
Buttarla in ideologia è un modo semplice di risolvere i problemi. Ma anche il più inutile.
“Sviluppo” e “crescita” sono da sempre due concetti molto diversi, anche se la retorica imprenditoriale pretende di usarli come sinonimi, per di più misurati unicamente sull’andamento del Pil.
E se la “crescita” incontra sicuramente limiti oggettivi che stanno dimostrandosi insuperabili (viviamo in un ecosistema “limitato”, se non altro), lo “sviluppo” è comunque un obiettivo necessario di ogni società umana, almeno per far stare in auspicabile equilibrio possibilità di sopravvivenza e condizioni di vita decenti per tutti.
Prendersela con chi parla di “sviluppo”, insomma, è un modo per rendere meno comprensibili problemi e obiettivi di trasformazione. Magari involontario, ma non meno dannoso.
Gino
articolo colmo di ideologie e rancori di conseguenza la vista è annebbiata e non aiuta a risolvere problemi che ci portiamo da oltre 50anni.
se pensiamo che le aziende funzionino mettendole in mano pubblica, allora possiamo dire con certezza che non c’è fine al peggio e di fronte abbiamo solo il baratro
Redazione Roma
I fatti dimostrano il contrario di quanto lei afferma