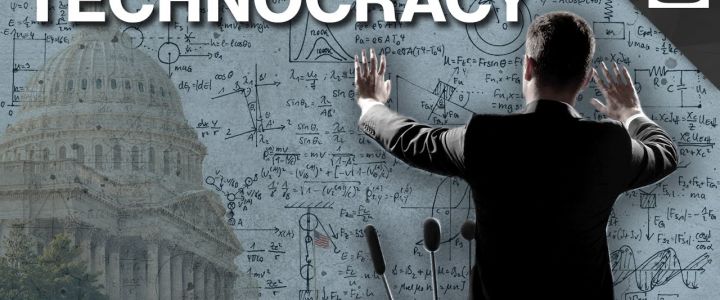Nei giorni scorsi, complice la crisi del governo Conte-bis, si è tornati a parlare dell’eventualità di un governo tecnico. L’ipotesi è circolata non solo nelle parole degli opinionisti e degli editorialisti, ma anche in quelle di vari esponenti politici. Per la guida dell’ipotetico governo tecnico, è stato spesso fatto il nome dell’ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi come, ad esempio, da Salvini e da Renzi.
Ma cosa si intende quando si parla di governo tecnico? Si parla di un esecutivo composto esclusivamente o prevalentemente da personalità non appartenenti a partiti politici o, comunque, non presenti in Parlamento sotto il simbolo di partiti politici.
Il governo tecnico, come ogni governo, deve avere la fiducia delle Camere, ma tale sostegno si configura come un semplice appoggio esterno: normalmente, nessuna delle forze politiche che sostiene il governo ha suoi rappresentanti tra i ministri, sebbene ci sia la possibilità di ibridi a prevalenza di tecnici, ma con qualche casella occupata da esponenti politici.
Di fronte ad una crisi di governo insanabile e all’impossibilità di trovare una nuova maggioranza, il governo tecnico rappresenterebbe una soluzione per evitare nuove elezioni.
Proprio pochi giorni fa, all’esito (negativo) delle consultazioni del Presidente della Camera Fico, Mattarella ha elencato le ragioni per non andare a votare: la pandemia, la necessità di ottenere i fondi europei, i lunghi tempi per la formazione delle nuove Camere e di un nuovo Governo. Tra queste, però, si staglia una ragione particolarmente inquietante: la scadenza, a breve, del blocco dei licenziamenti. Una evidente minaccia, volta a spaventare i lavoratori (ahinoi, non senza credibilità e potenti sponsor) e a giustificare un possibile esecutivo tecnico, o prevalentemente tecnico.
Al momento sembrerebbe esclusa la possibilità di un Governo prettamente politico, tanto che il presidente della Repubblica ha invitato le forze politiche ad appoggiare un “governo di alto profilo”, espressione che fa rima con governo tecnico. Che dovrebbe essere presieduto, manco a dirlo, da Mario Draghi, convocato per l’appunto al Quirinale.
D’altronde, da più parti si auspicava una soluzione del genere, presentata come unica via d’uscita dal guado della crisi politica in grado di “ristabilire la fiducia” dei mercati e delle istituzioni europee nei confronti dell’Italia. Una soluzione che, sicuramente, ha la sua presa anche nell’opinione pubblica.
Ma è davvero così? Un “governo tecnico” offre davvero, in questa fase, più garanzie per il nostro benessere e per il nostro sistema economico? Sarebbe davvero una buona notizia se i componenti del prossimo governo fossero “tecnici” e non “politici”?
Come vedremo a breve, non è così. L’espressione “governo tecnico” si contrappone a quella di un “governo politico”, è vero, ma solo nella misura in cui si considera come “politica” l’asfittico recinto delle formazioni partitiche.
Il governo tecnico è tutt’altro che “apolitico”, spesso rappresenta l’espressione più bassa della classe dominante. Infatti, vi è una posizione politica molto netta: occorre ridurre sempre di più il ruolo dello Stato nell’economia, praticando l’austerità e portando avanti le riforme del mercato del lavoro. A dimostrarlo è la storia recente del nostro Paese. Mala tempora currunt!
Ad oggi, in Italia ci sono stati due governi che si possono definire “tecnici” a tutti gli effetti: il governo Dini (17 gennaio 1995 – 18 maggio 1996) e il governo Monti (16 novembre 2011 – 28 aprile 2013). Entrambi, come vedremo, portatori di una ben precisa identità politica, quella che si riconosce nelle ragioni dell’austerità, della riduzione della spesa pubblica, dell’affievolimento dei diritti dei lavoratori e dei pensionati.
Il governo Dini nasce dopo la caduta di quello che fu il primo governo Berlusconi, nel quale lo stesso Dini aveva ricoperto l’incarico di ministro del Tesoro. Il “lascito” più importante di questo esecutivo è senz’altro la riforma delle pensioni che porta il nome del suo Presidente del Consiglio, la cosiddetta riforma Dini. Si trattò della più profonda riforma previdenziale degli ultimi decenni, che introdusse di fatto il sistema contributivo nell’ordinamento italiano.
Fino ad allora, infatti, il sistema di calcolo della pensione era essenzialmente retributivo. L’assegno pensionistico era calcolato sulla base delle ultime retribuzioni del soggetto che andava in pensione. Con il sistema contributivo, invece, la pensione si calcola sul cosiddetto montante contributivo dell’intera vita lavorativa del soggetto.
La riforma Dini non cancellò totalmente il retributivo, ma mise in piedi un sistema ibrido. In estrema sintesi, chi aveva 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 avrebbe continuato a vedere la sua pensione calcolata con il sistema retributivo. Chi aveva meno di 18 anni di contributi alla stessa data, avrebbe visto la sua pensione calcolata in parte con il sistema contributivo e in parte con quello retributivo (il cosiddetto sistema misto).
Per chi al 31 dicembre 1995 non aveva mai versato contributi, la pensione sarebbe stata totalmente contributiva. Un sistema destinato a penalizzare mediamente gli importi pensionistici, in particolare per chi, come abbiamo detto, al 31 dicembre 1995 non aveva ancora versato contributi ma anche per chi aveva meno di 18 anni di contributi. Una riforma che ebbe il palese obiettivo di ridurre la spesa pensionistica.
Tale riduzione non fu un accidente, ma una scelta deliberata atta a facilitare il raggiungimento degli stringenti vincoli alla spesa pubblica imposto dal trattato di Maastricht del 1992. Una giustificazione che, negli anni successivi, sarebbe stata chiamata più volte in causa per demolire, pezzo per pezzo, lo stato sociale e ammorbidire, a favore del capitale, le garanzie per i lavoratori.
Garanzie che avrebbero costituito l’oggetto delle attenzioni del cosiddetto “pacchetto Treu”, una delle principali tappe del processo di precarizzazione delle condizioni di lavoro. Un pacchetto approvato dal primo governo Prodi, con Treu ministro del lavoro e della previdenza sociale, ma che era già nei progetti di Treu quando ricopriva la medesima carica nel governo immediatamente precedente: il governo Dini.
Come in un giallo di infimo ordine, a questo punto il lettore è già in grado di intuire quale governo si sia poi occupato di dare un altro colpo al sistema pensionistico italiano… Nel 2011, molti lo ricorderanno, il quarto governo Berlusconi finì, sotto i colpi della speculazione sul debito pubblico, dell’Unione europea a guida franco-tedesca e dell’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. A succedergli fu il governo di Mario Monti, all’uopo nominato, pochi giorni prima, senatore a vita.
Il governo Monti è stato il governo dei tagli per eccellenza, la manifestazione plastica dell’austerità. E, ovviamente, il governo della riforma Fornero. E cosa prevedeva questa riforma?
È presto detto: l’aumento dei requisiti per la pensione anzianità (che diventava “anticipata”), l’aumento graduale dell’età pensionabile per le dipendenti private, l’aumento della frequenza dell’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita (da triennale, come introdotto dalla riforma Sacconi, a biennale), ma, soprattutto, l’estensione del sistema di calcolo contributivo, per i periodi contributivi a decorrere dal 1° gennaio 2012, per tutti, anche per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi che, come abbiamo ricordato sopra, avrebbero avuto precedentemente diritto a una pensione totalmente retributiva.
Un nuovo, poderoso attacco alle pensioni e ai diritti dei lavoratori, giustificato dalla necessità di ingraziarsi i mercati e annacquato nelle lacrime dell’allora ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero.
Se la storia insegna qualcosa, dunque, si illude chi auspica che un eventuale governo tecnico possa costituire una svolta positiva. Il governo tecnico, come dicevamo, è un governo massimamente politico, con un’ideologia ben precisa. Un tipo di esecutivo che, grazie all’ampio consenso tra le forze parlamentari e all’appello alle ragioni dell’emergenza, può portare questa ideologia alle sue più estreme conseguenze.
Non c’è soltanto la storia a ricordarci quali pericoli si annidano dentro un governo tecnico. Possiamo guardare più semplicemente alla stringente attualità. La crisi di governo si è palesata, o semplicemente acuita, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dell’ultima versione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, sebbene presentasse una sostanziale continuità con l’austerità fiscale degli ultimi anni, ha scatenato reazioni piccate da parte delle istituzioni europee.
Infatti, l’accesso al Recovery Fund è condizionato alle riforme in materia di fiscalità e lavoro che l’Unione Europea raccomanda (richiede) ai singoli paesi membri. L’occasione è ghiotta (e non può essere sprecata) e l’eventuale nomina di Mario Draghi sarebbe una garanzia in tal senso.
Assisteremo quindi a nuovi attacchi allo stato sociale (come abbiamo visto, la storia ci insegna che al centro del bersaglio rischiano di esserci soprattutto le pensioni), al settore pubblico, agli elementi della legislazione del lavoro sopravvissuti alle riforme degli ultimi decenni.
Davanti a questa nuova minaccia, incarnata da uno dei più celebri rappresentanti delle Istituzioni europee, occorre tenere la guardia più che mai alta, con la consapevolezza che per i lavoratori e per i cittadini che più hanno bisogno del sostegno dello Stato, stanno per venire tempi durissimi.
* Coniare Rivolta è un collettivo di economisti – https://coniarerivolta.org/
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa