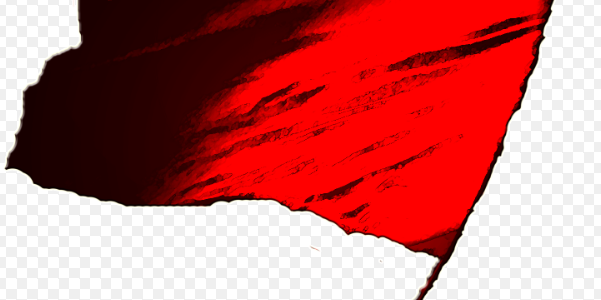Roma 18 Giugno, seminario nazionale promosso dalla Rete dei Comunisti
Dalle ore 10.00 alle 17.00 – Via Galilei 53
Dal “Corriere della Sera” del 9 Marzo 2008 uno scritto, del 2004, del filosofo francese non certo marxista Jacques Derrida:Avrei voluto proporre un argomento analogo a quello del CHE FARE? di Lenin, scritto nel 1901-1902, ma il tempo manca. Ricordiamo ciò che in quel testo, come nel testo di Kant, oggi non risulta invecchiato: la condanna dell’ “abbassamento del livello teorico” nell’azione politica, l’idea che qualsiasi “concessione” teorica, secondo il termine di Marx, sia nefasta per la politica; la condanna dell’opportunismo (bisogna pensare ed agire controcorrente), la condanna dello spontaneismo, dell’economicismo e dello sciovinismo nazionale (il che non sospende i doveri nazionali), la condanna della “mancanza dello spirito d’iniziativa dei dirigenti” politici cioè rivoluzionari, che dovrebbero saper rischiare e rompere con le facilità del consenso e delle idee preconcette (è quanti propone Alain Minc in un libro in fondo molto leninista). E ancor meno invecchiata è l’analisi di ciò che lega l’internazionalizzazione, la mondializzazione del mercato, come della politica, alla scienza ed alla tecnica. Tutto questo si legge nel CHE FARE? di Lenin.
PREMESSA
Viviamo un periodo di crisi generale e di crisi dell’egemonia dominante. Non è una crisi congiunturale ma di sistema che si presenta in passaggi storici che aprono una fase imperscrutabile nelle sue evoluzioni concrete. Per avere una lettura valida di questi passaggi bisogna partire da quello che è stato definito Modo di Produzione Capitalista e non semplicemente capitalismo, perché se analizziamo le tendenze di fondo, e non solo le sue forme concrete e storiche, riusciamo a comprendere meglio la dinamica degli eventi passati ma che agisce tuttora.
L’antagonismo di classe e le possibilità di una società alternativa sono state e sono strettamente collegate alla relazione tra sviluppo delle Forze Produttive e Rapporti di Produzione,dalla quale può generarsi la vera contraddizione dell’attuale modo di produzione di cui il conflitto capitale-lavoro rappresenta l’esito inevitabile. Lo scenario storico in cui si sono mossi i partiti operai, è stato caratterizzato da questa dinamica e per capire la loro nascita, sviluppo, crisi e possibilità di ripresa è a questa che dobbiamo fare riferimento anche oggi.
Sicuramente l’800 è stato il secolo in cui la corrispondenza tra forze produttive e rapporti di produzione fu completa, un periodo nel quale la crescita del capitalismo rispondeva ad un bisogno generale di emancipazione dalla miseria e dall’ignoranza. Se la prima parte è stata caratterizzata dall’assenza della lotta di classe organizzata, anche se ne erano presenti tutti i prodromi sociali e politici, la seconda parte del secolo ha segnato finalmente la nascita dei grandi partiti operai, a cominciare da quello della Germania, sorti sulla scia del potente pensiero marxista. Evoluzione che manifesta i primi sintomi della crisi di egemonia verso la quale si muoveva il capitalismo.
A cavallo del secolo c’è stato il passaggio dal capitalismo concorrenziale al monopolio ed all’imperialismo, analizzati da Lenin, che ha segnato la fine di una lunghissima fase di crescita, la fine della corrispondenza tra forze produttive e rapporti di produzione e conseguentemente della sua capacità egemonica. La manifestazione concreta di questo limite è stato il periodo bellico andato dal 1914 al 1945 con il corredo di crisi economiche, finanziarie, sociali, politiche ben visibili nella storia dei paesi a capitalismo avanzato in Europa ed in America. È stata anche l’epoca in cui le rotture rivoluzionarie, vittoriose o meno, si sono moltiplicate e dove il campo imperialista si è diviso drammaticamente, facendo emergere la necessità e la possibilità di una società alternativa. Va ricordato, però, che la capacità di egemonia borghese, per quanto rimessa in discussione, ha comunque tenuto nei punti alti dello sviluppo capitalista manifestando i momenti più acuti della propria crisi nella periferia, negli anelli deboli, a cominciare dalla rivoluzione del 1917. Nei paesi imperialisti, infatti, di fronte al pericolo delle rotture rivoluzionarie si è messa in moto la lotta di classe “dall’alto”, prima sul piano produttivo e sociale – minando la potenziale unità tra operai e contadini – e poi, nel 1914, spaccando il movimento operaio europeo di fronte all’esplodere della guerra imperialista.
La fine della seconda guerra mondiale vede uno scenario completamente diverso e potenzialità di crescita sia per il campo socialista, che si era allargato ad ovest ma soprattutto ad est con la Cina, sia per il campo imperialista anche se in modo meno evidente data la modifica internazionale dei rapporti di forza politici e militari. Comunque la distruzione bellica restituisce al capitalismo, unificato sotto il comando “imperiale” statunitense, la possibilità di crescita ed il superamento della contraddizione generata dallo sviluppo delle forze produttive. Contraddizione che si ripresenta al compimento del ciclo con la crisi di sovrapproduzione degli anni ’70, che segna una nuova tappa che non sbocca, per motivi strutturali legati ai rapporti di forza tra le classi interni ed internazionali, in una nuova guerra ma in un salto scientifico e tecnologico e di riorganizzazione produttiva e finanziaria che recupera nuovamente le potenzialità di crescita, riversando le contraddizioni nel campo avverso dei paesi socialisti.
Questo “doppio passo” del capitalismo alla fine del ‘900 è stato inversamente speculare alle capacità di tenuta dei paesi socialisti ma, più significativamente, dell’intero movimento operaio ed antimperialista che a livello mondiale segna l’arretramento a noi tutti noto nei modi e nelle forme. L’egemonia piena persa nel 1917 e non recuperata fino agli anni ’70 va di nuovo ad appannaggio del campo imperialista per la ritrovata sintonia tra sviluppo delle forze produttive e rapporti di produzione che sembra ridare fiato ad una fase di sviluppo di lungo periodo grazie anche alla scomparsa dell’URSS, del campo socialista nei paesi dell’Europa dell’est ed alla apertura ai mercati della Cina e dell’India.
Nel Modo di Produzione Capitalista la crescita quantitativa ha però il risultato di dilazionare nel tempo, anche se in tempi non necessariamente brevi come ben sappiamo, il manifestarsi della contraddizione e dunque quello che sembrava ormai acquisito negli anni ’90 dalla crisi finanziaria del 2007 viene rimesso in discussione non direttamente dal conflitto di classe – apparentemente l’egemonia del capitale non è stata mai cosi forte ed estesa – ma dalla dinamica sua propria. La crisi finanziaria, quella energetica, quella ambientale, la competizione globale ed interimperialistica, le tendenze alla guerra e la crisi sociale mondiale costituiscono un nuovo passaggio storico che va interpretato perché una ripresa della soggettività antagonista e di classe è con questi elementi di fondo che dovrà fare i conti se vuole ipotizzare, in tempi e modi oggi non prevedibili, un nuovo progetto di trasformazione sociale.
I processi storici possono essere letti da molteplici punti di vista ma questo aspetto della crisi di egemonia ha una valenza politica diretta, in quanto appare sempre più evidente che questo sistema si è cacciato in un vicolo cieco e che la via d’uscita rischia di essere traumatica per tutta l’umanità. È questo il punto da cui riemerge la necessità dell’alternativa di sistema sociale e dunque si ripropone la necessità di capire, date tali condizioni, il ruolo dei comunisti, se c’è e quale possa essere. C’è storicamente un nesso tra i cicli storici nel capitalismo e le possibilità di affermazione per le forze di classe antagoniste ad esso.
Qui si pongono problemi teorici da sempre presenti nel movimento comunista ma non si può nemmeno esulare dal contesto concreto in cui esso agisce: per noi è oggi l’Italia inserita nel contesto dell’Unione Europea, ovvero in uno dei poli imperialisti predominanti a livello mondiale. Siamo, dunque, dentro una “cittadella” imperialista che agisce ideologicamente e strutturalmente su tutti i piani della società: sul piano ideologico supportando tutti i valori etici e politici borghesi e fornendo una visione ribaltata della realtà; parliamo dello Stato, inteso come sostegno al privato, parliamo dei diritti umani contro i diritti sociali e delle guerre “umanitarie”, parliamo delle religioni intese come arma identitaria e politica, dell’ambiente come volano “verde” dell’economia capitalista, della politica del terrore che pervade i mezzi di comunicazione inducendo un senso di insicurezza diffuso. Insomma l’ideologia delle classi dominanti è oggi lo strumento più pervasivo che viene utilizzato per dare stabilità politica ad un sistema che comincia a mostrare chiaramente i suoi limiti.
La stabilità politica però non è solo “eterodiretta” ideologicamente ma viene garantita anche da una serie di processi istituzionali, a livello nazionale ed europeo, che limitano le forme democratiche nate dalla lotta contro i fascismi europei nella seconda guerra mondiale e che centralizzano sempre più le decisioni strategiche. Si delegano nei fatti gli eurocrati a prendere decisioni che devono tenere conto solo dei parametri economici e finanziari nella competizione globale. I vari trattati economici fatti in Europa e la sorte che è stata brutalmente riservata al popolo greco stanno a testimoniarlo.
Ma questi due processi di gestione autoritaria della società non sarebbero stati possibili se non si fossero basati sulla disgregazione produttiva e sociale prodotta in questi decenni con ristrutturazioni che, tra l’altro, oggi stanno minando esse stesse la stabilità economica mondiale. La complessità della nostra società non è un dato nuovo ed è in aumento fin dagli anni ’60, gli altri paesi imperialisti ci hanno preceduto ed hanno indicato la strada. Se in Cina, India, Sud Africa, Brasile ed altri paesi si addensano ancora masse di operai nelle grandi fabbriche caratterizzate prevalentemente dalla produzione fordista, nei centri imperialisti la condizione della forza lavoro è diversa. Essa è, infatti, caratterizzata dalla disgregazione sociale, dalla parcellizzazione delle mansioni produttive e dalla differenziazione delle condizioni giuridiche del lavoro, dal passaggio dal lavoro manuale a quello intellettuale. Questa è la condizione obiettiva in cui i comunisti sono chiamati ad operare dovendo storicizzare anche la concezione della classe operaia della grande fabbrica del ‘900.
La discontinuità odierna è legata al fatto che, fino alla fase precedente, l’aumento della produzione della grande fabbrica, cioè il cuore del capitalismo, procedeva di pari passo all’aumento ed alla concentrazione della classe operaia, cioè del soggetto di classe direttamente antagonista al capitale. Un andamento nato già con la formazione delle manifatture nell’800 e proceduto sia con la grande fabbrica dell’operaio professionale sia con l’avvio della produzione fordista. Questo ha anche caratterizzato il periodo post bellico in cui la produzione in linea, che permetteva la massima produttività all’epoca, procedeva parallelamente alla crescita quantitativa e alla concentrazione nei paesi sviluppati della classe operaia. Tale condizione aumentava il potere contrattuale e politico della forza lavoro e rendeva necessaria la mediazione sociale dello Stato con la nascita del Welfare.
Qui è utile rimandare ad un interessante scritto non del Togliatti del secondo dopoguerra e del successivo boom economico, ma di quello della clandestinità del PCI degli anni Venti (lo scritto apparve sulla rivista «Stato Operaio» del gennaio/febbraio 1928 e fu ripubblicato in P. Togliatti, Il Partito, Editori Riuniti 1972), in cui egli afferma: «Il Fascismo cerca di polverizzare, di “atomizzare” le classi lavoratrici. Ciò vuol dire che il Fascismo conduce una politica di disorganizzazione delle masse. Ma il processo di polverizzazione è stato condotto più innanzi. Nelle grandi città italiane le sezioni di Polizia rionale fanno fermare ed arrestare, dopo le 20, tutti gli “stranieri”, cioè gli operai abitanti in altri rioni […] Sono stati fissati dei confini, dunque, anche all’interno delle città, tra rione e rione! […] Gli operai si sono ancora trovati assieme nelle fabbriche. Ma, ahi, anche qui è stato applicato il regime delle frontiere. Tra reparto e reparto è proibito comunicare. In ogni reparto poi sorvegliano le spie.
“Restare a tutti i costi nella fabbrica! La crisi industriale e la disoccupazione e la “razionalizzazione” e la reazione di polizia tendono a gettarci fuori dalle fabbriche. Noi dobbiamo abbarbicarci alla fabbrica. Se cacciati vi ritorneremo. Se indeboliti, vi ci rafforzeremo. Nella fabbriche ritroviamo la classe operaia. Non è possibile “polverizzare” la classe operaia nella fabbrica, perché non è possibile spezzare la fabbrica. La fabbrica è il capitalismo.»
La concretezza di questo scritto ci dà l’idea di quali scelte erano chiamati a fare all’epoca i comunisti, ma ci dice anche che quella condizione dove “la fabbrica è il capitalismo” oggi è stato possibile superarla grazie alla moderna produzione capitalista. Non serve più la divisione “formale” della classe operaia come nel fascismo per indebolire lo scontro di classe, in quanto l’intero assetto produttivo è stato rivoluzionato dall’applicazione nella produzione della scienza e della tecnologia superando quel legame, all’epoca indissolubile, tra concentrazione di capitale e di forza lavoro in funzione della produttività.
L’avvio della produzione flessibile fa saltare questa accoppiata e separa le sorti dell’operaio di fabbrica dal punto più avanzato del processo produttivo. La nascita delle filiere produttive dislocate sulla dimensione internazionale permette di ripristinare lo sfruttamento e l’estrazione di plusvalore in un punto lontano dai centri strategici, progettuali e finanziari, rimasti nei centri storici del capitalismo. Ciò non rappresenta solo una constatazione “tecnica” poiché essa modifica la condizione materiale e politica della classe operaia, riduce il suo potere contrattuale e, separandola strategicamente dai punti sviluppati della produzione, fabbriche automatizzate, bio e nano tecnologie, industria militare moderna, etc., la riduce a soggetto sociale al pari degli altri che compongono il proletariato. Viene meno, così, quella “particolarità” storica di essere avanguardia politica della classe fin dall’inizio della grande impresa capitalista in quanto, sia per la funzione produttiva che per la mobilità geografica delle filiere, non costituisce più quello snodo ineludibile con il quale la produzione di valore doveva per forza fare i conti.
Naturalmente nei paesi imperialisti rimangono ancora nuclei consistenti di classe operaia di fabbrica legati alle produzioni avanzate, ma questi non rappresentano più la tendenza generale del proletariato in quei paesi come avveniva nel ‘900 quando essa si moltiplicava e concentrava attorno alle grandi fabbriche da Torino a Detroit e nel resto del mondo “sviluppato”. La realizzazione delprofitto nei centri imperiali oggi viene dalla circolazioneinternazionale del capitale e non dalla dimensione nazionale della produzione e del mercato come precedentemente; il nesso sempre più stretto tra multinazionali e logistica ci segnala questa modalità diversa di realizzazione del valore che vede, non solo in Italia, un consistente uso di forza lavoro immigrata come ulteriore elemento di segmentazione della classe lavoratrice.
Quella che si apre è perciò una fase inedita e soggetta ad ulteriori sviluppi e non si può pensare che si possano ripetere le dinamiche del ‘900 sulla base di un determinismo del tutto soggettivo; ciò significa che non sappiamo ancora gli sviluppi concreti futuri che bisognerà analizzare ed elaborare per individuare una funzione reale. Per quanto ci riguarda come RdC negli anni ’90, partendo dal testo sull’imperialismo di Lenin, abbiamo cercato di leggere nella realtà che si sviluppava, dopo la fine dell’URSS, quali dinamiche avrebbero preso il sopravvento ed individuammo nella costruzione dell’Unione Europea i segni di una ripresa della competizione interimperialista come sintomo di una tendenza storica del capitalismo sulla base della sua composizione organica.
Nell’analisi della fase che si apriva in quegli anni non siamo partiti dalla verifica empirica dei processi legati alla ripresa della competizione interimperialistica, verifica sempre inquinata e resa problematica dalla rappresentazione politica egemone, ma dall’uso di categorie quali la legge del valore come dato immanente al modo di produzione capitalista, la caduta tendenziale del saggio di profitto come processo storico dell’aumentata composizione del capitale fino all’analisi leninista che individuava i caratteri di una tendenza imperialista che ci sembra abbiano ancora tutta la loro vigenza. In altre parole abbiamo ritenuto necessario avere una linea di ricerca che fosse organica ed in coerenza con gli strumenti del marxismo rifuggendo dall’analisi contingente dei fenomeni che spesso si mostra miope e di corto respiro.
Naturalmente era all’epoca, per noi, una possibilità e non ancora una realtà; negli anni successivi l’approfondimento di un lavoro analitico sistematico e la verifica che mano mano veniva dalla realtà ci ha permesso di confermare l’ipotesi che era alla base del nostro progetto. Quella che si apre oggi è una fase uguale a quella precedente per importanza ma di segno opposto e che ne rappresenta anche il superamento. Di questo superamento bisogna avere coscienza in quanto ci obbliga a riprendere un lavoro di elaborazione ed a maneggiare “l’arma” della teoria cominciando a riflettere sulle nuove condizioni ma sapendo che questa è un’arma a doppio taglio che se non maneggiata con cura potrebbe ritorcersi contro di noi. Per essere più espliciti potremmo dire che la fase attuale può essere ben rappresentata dall’affermazione fatta da Gramsci durante il Fascismo: “il vecchio muore ma il nuovo non può nascere”. Ciò fu detto dentro un periodo di crisi profonda iniziato con la prima guerra mondiale e risoltosi solo dopo il 1945, dove è poi effettivamente sorto il “nuovo”. Bisogna perciò mettere mano all’analisi ed alle ipotesi che possono essere fatte sugli sviluppi futuri sapendo che le risposte non sono affatto scontate né possono essere predeterminate. Dunque la RdC intende promuovere nella seconda parte dell’anno un nuovo incontro aperto a tutti i contributi per avviare un impegno analitico fondamentale per il futuro del nostro agire politico.
Il seminario che intendiamo svolgere per il mese di Giugno vuole riprendere l’analisi ed il confronto sull’altro corno della questione che è quello della soggettività, della soggettività organizzata dei comunisti,della loro funzione strategica e della soggettività della classe.
LE RAGIONI DEI COMUNISTI
Parlare di Partito Comunista qui ed ora non è certo cosa facile e dà l’idea di parlare di un altro mondo e di un’altra epoca tanto è stata devastante la storia delle organizzazioni comuniste di questi ultimi decenni in Italia, ma anche nel resto dell’Europa. Questa constatazione e lo stato d’animo che ne deriva, che ha spinto molti militanti a rivolgersi verso altri orizzonti anch’essi bruciati in tempi molto rapidi, ci deve invece spingere ad operare un salto di qualità teorico nell’affrontare la questione del partito che in realtà è la questione di come le classi subalterne resistono e reagiscono allo stato attuale delle cose. Parlare di partito significa dunque parlare della classe con cui abbiamo a che fare, reale e non mitologica, ma significa avere anche una idea dei processi generali e di quelli storici che stanno modellando il mondo attuale.
Se abbiamo dato una lettura dei processi storici legata al rapporto contraddittorio tra sviluppo delle forze produttive e rapporti sociali di produzione individuando fasi egemoniche e fasi di crisi non possiamo non leggere sotto questa luce anche la storia delle organizzazioni del movimento operaio. Il succedersi di periodi “rivoluzionari” e regressivi della borghesia hanno determinato anche i caratteri dei partiti operai e dei partiti comunisti i quali hanno dovuto fare i conti con gli sviluppi prodotti dalle classi dominanti modificandosi, evolvendo o cambiando natura. Processi questi che negli ultimi trent’anni abbiamo visto materializzarsi fornendoci una esperienza diretta, forse storicamente unica, di come la dialettica della realtà costringe a fare i conti con se stessi.
Per essere più concreti nell’analisi riportiamo una parte dello scritto di Giorgio Gattei, prodotto in occasione di un nostro seminario tenuto nel 1999, riportato sul quaderno “Partito e Teoria” che fornisce un’utilissima chiave di lettura non solo storica ma anche funzionale alle questioni che abbiamo oggi sul nodo strategico dell’organizzazione dei comunisti: “Ma allora per comprendere le diverse modalità del suo apparire storico pare necessario istituire un qualche rapporto tra la forma d’organizzazione politica che di volta in volta si è data la classe e la sua particolare “composizione” che le diverse maniere del produrre capitalistico, anch’esse di volta in volta storicamente determinate, pongono in essere.
La premessa è che si deve riconoscere che la storia del modo capitalistico di produzione, pur nell’invarianza dei suoi connotati strutturali di fondo (che sono la compravendita della forza lavoro e l’estorsione di plusvalore), non resta immutabile ma è segnata da una successione di modificazioni che ne variano, in particolare, l’organizzazione del lavoro.
Si parla al proposito di veri e propri “mutamenti di forma” dell’intero ordine produttivo e se ne individuano, pur all’interno dell’identità del modo capitalista, almeno queste diverse configurazioni: la rivoluzione della fabbrica a vapore alla fine del XVIII secolo, la novità della produzione meccanizzata”di serie” a mezzo del XIX secolo, l’avvento della produzione Tayloristica “in linea” alla svolta del XX secolo, il trapasso alla produzione/consumazione di massa che s’impone alla metà del XX secolo (rispetto alla fase precedente la trasformazione non è di poco conto, come poi si vedrà) ed infine l’affermazione di quella produzione “flessibile” (o snella o comunque la si voglia chiamare) che segna il nostro trapasso di secolo.
Ad ogni trasformazione della maniera capitalistica del produrre ha di volta in volta corrisposto una modificazione del carattere della “composizione di classe”: dall’operaio generico delle fabbriche di primo ottocento all’operaio “di mestiere”di metà secolo scorso; dall’operaio “alla catena” del primo novecento all’operaio/consumatore-massa di metà secolo nostro, ed infine a quell’operaio “debole” (o comunque lo si voglia chiamare) col quale stiamo entrando nel terzo millennio di cronologia cristiana.
Conseguentemente fino ad ora sono state quattro le “forme partito” che si sono presentate sulla scena storica, ossia tante quante sono state le trasformazioni strategiche della “composizione di classe” indotte dalle modificazioni della “maniera del produrre” che si sono succedute dalla rivoluzione industriale. E se ne attende naturalmente una quinta, adeguata al livello dell’accumulazione “flessibile” e del lavoratore “debole”, ma essa è ancora di là da venire o almeno è ancora difficile da distinguere nella confusione del nostro tempo.”
Questa relazione tra capacità egemonica, composizione di classe e carattere del partito di classe va vista non in modo automatico né può essere scambiata per una interpretazione sociologica della politica. Come sempre è utile andare a recuperare nel bagaglio del movimento operaio storico elaborazioni fatte in altri momenti non come riferimento sacrale ma come capacità di cogliere le tendenze di fondo, sapendo che le forme concrete non possono che essere date dal contesto storico che agisce nel tempo preso in considerazione. In questo senso è estremamente utile riandare ad un articolo di Lenin del 1916 “L’imperialismo e la scissione del Socialismo”, in cui Lenin mette in relazione la vittoria dell’imperialismo nel coinvolgere il movimento operaio nella prima guerra mondiale con l’emergere nella classe dell’aristocrazia operaia subalterna alla borghesia, prodotta dalla riorganizzazione produttiva e dalla conseguente modifica della composizione di classe, con la scissione del movimento socialista che non ha solo riguardato la linea politica ma anche la forma della stessa organizzazione di partito.
Se adottassimo un approccio meccanicistico sarebbe facile fare un parallelo diretto, tante sono le somiglianze, con la subalternità della sinistra di oggi all’imperialismo della UE, la scomposizione e separazione della classe dovuta ai processi di ristrutturazione e la necessità di una organizzazione antagonista e rivoluzionaria oltre la nostra sinistra. Purtroppo le cose non sono così semplici perché le condizioni sono molto diverse, ma il metodo di analisi proposto da Lenin in quello scritto è ancora valido adeguandolo al contesto storico che caratterizza la nostra epoca. Bisogna, dunque, partire dalla modificazione del contesto complessivo che si avvia con la fine dell’URSS e con una trasformazione completa del contesto strutturale internazionale ancor prima che quella realizzatasi sul piano politico e dei rapporti di forza internazionali.
a) Un metodo da applicare ancora
Il primo elemento da prendere in considerazione è che nel dopoguerra, con un partito comunista uscito vittorioso dalla guerra di liberazione, anche come conferma dell’assetto organizzativo e politico prodottosi nella lotta antifascista, il problema che si pone Togliatti, e con lui la quasi totalità del partito comunista, è proprio il cambiamento del ruolo e dell’assetto del partito stesso. È il “partito nuovo” che deve cambiare se stesso in base alle mutate condizioni complessive. La fine del fascismo e la battaglia politica sui caratteri della democrazia italiana, il ruolo della classe operaia nella lotta antifascista ed il radicamento che il partito aveva, era stato conquistato con la vecchia forma organizzata; la nascita delle democrazie di transizione nell’Est Europa e la divisione del mondo in blocchi sono le condizioni generali che hanno portato alla trasformazione del PC, clandestino prima e poi combattente armato nella Resistenza, a cambiare radicalmente i propri caratteri mantenendo però il carattere di classe che ha poi segnato il conflitto politico nel nostro paese per i successivi decenni.
La vittoria sul Fascismo non portò a confermare il modello politico che pure aveva vinto, ma si produsse invece una radicale trasformazione del partito che, abbandonata la dimensione limitata, prima per scelte settarie e poi per la clandestinità imposta dal fascismo, modificava se stesso per poter accedere alla dimensione del partito di massa. Gli sviluppi successivi hanno indubbiamente confermato che quelle scelte erano adeguate al nuovo contesto nazionale ed internazionale, anche se la discussione di merito sulle opzioni possibili all’epoca non va certo data per scontata. Come non si può rimuovere dalla riflessione l’evoluzione riformista avuta dal PCI soprattutto a partire dagli anni ’70 e concretizzatasi con la strategia del compromesso storico, di cui oggi nel PD vediamo gli esiti finali.
Quello che però a noi oggi interessa capire ed evidenziare è il metodo di analisi della fase complessiva relativa al dopoguerra, la capacità di cogliere le trasformazioni sociali, in primo luogo il ruolo centrale della classe operaia di fabbrica riferito a quell’assetto produttivo, ed, infine, la capacità di dotarsi delle forme di organizzazione adeguate a raccogliere la spinta del conflitto di classe di quel periodo.
Oggi siamo da tempo dentro una modifica altrettanto radicale del contesto in cui agiamo, dove alla crisi del movimento di classe, oltre che comunista, corrisponde una profonda crisi dell’assetto capitalistico che fa riemergere le sue contraddizioni strutturali, lucidamente interpretate dalle categorie del pensiero marxista. Non si può pensare di affrontare una fase di cambiamento come questa senza porsi i problemi relativi alla forma organizzata dei partiti e delle organizzazioni di classe e comuniste.
Quello che non si può negare è la capacità che il movimento comunista ha avuto nello strutturare i suoi partiti in base alle condizioni che si manifestavano nei diversi singoli paesi, ribadendo in questo modo che l’organizzazione rimane sempre uno strumento, da modificare quando necessario e contro ogni feticismo organizzativistico.
Siamo in Italia, in Europa, cioè in uno dei cuori della trasformazione avviata dal capitale per far fronte di nuovo alle proprie contraddizioni, trasformazioni che riguardano in primo luogo le condizioni dei popoli e delle classi subalterne di questo continente; eppure su come si deve organizzare il movimento di classe e con esso i comunisti siamo all’afonia totale, si naviga più che nella confusione nella ignavia di chi intende svolgere un ruolo antagonista. Le organizzazioni presenti, inclusi i partiti, vivono una condizione che non è di massa, in quanto sono caduti quasi tutti i rapporti con le classi subalterne, ma non è neanche di militanti poiché il concetto di militanza è stato svuotato dall’accettazione della cultura egemone, che al massimo ci concede il “volontariato”, e da una pratica interna alle organizzazioni schiacciata sulla contingenza, piuttosto che su quello della qualità e della formazione, e sul protagonismo individuale.
b) Le nuove condizioni
Ricostruire perciò un confronto tra le condizioni attuali e quelle della fase precedente, relativa al partito di massa, mettere a fuoco le differenze e le differenti necessità politiche alle quali deve fare fronte un’organizzazione comunista, è un lavoro utile a definire per approssimazione lo strumento organizzativo di cui dotarci oggi.
1) Oltre la Nazione Un elemento di evidente differenza tra la nascita del partito comunista di massa e la situazione attuale è il “teatro” della lotta di classe. Il PCI fin dal 1944 si pone come forza nazionale, cioè reclama per la classe operaia un ruolo nazionale e di ricostruzione dal tracollo prodotto dal Fascismo, ma anche di ricomposizione dei settori sociali diversi dalla classe operaia, dai contadini fino agli intellettuali, dalle donne ai giovani, tutti segnati dalla vicenda bellica: ricomposizione intesa come “Blocco Storico” che riprende la lezione del Gramsci della “questione nazionale” e di quella meridionale. L’ambito materiale dentro il quale svolgere la lotta di classe ed una funzione emancipatrice generale era la Nazione. Era anche la presa d’atto della divisione del mondo in sfere di influenza tra USA e URSS e del fatto che la rivoluzione doveva ripiegare su una democrazia progressiva. In realtà questa è stata la condizione obiettiva in cui si è fatto politica fino agli anni ’90, e quando, nei momenti di acutizzazione del conflitto politico e di classe, si è cercato di rompere quell’equilibrio la risposta del potere è stata di tipo golpistico, terroristico e violento.
Diventa inevitabile comprendere come le diverse condizioni storiche possano determinare diversi modi di agire ed organizzarsi dei comunisti. Non partiamo da zero, nel senso che in Italia la fine del PCI non ha corrisposto alla diaspora e scomparsa dei comunisti, anzi è cresciuta un’esperienza come quella della Rifondazione Comunista che ha continuato sulla strada tracciata dal PCI, ma anche delle organizzazioni politiche degli anni ’70, riproponendo un partito di massa che, per senso comune dei militanti, era l’unica strada da intraprendere visto anche l’entusiasmo con cui è iniziata negli anni ’90 quell’esperienza, per la gran parte di quei militanti che non volevano accettare la liquidazione di una storia importante.
Certamente la conclusione, di fatto, di quel tipo di realtà può essere messa nel conto di dirigenti “deviati” quali Cossutta e Bertinotti, ma questa sarebbe poco più di una scusa che riconsegnerebbe la Storia in mano agli individui e non ai processi generali. Dobbiamo dunque andare più a fondo e indubbiamente balza agli occhi il venir meno della dimensione nazionale, che era stata la culla nella quale era cresciuto il movimento di classe e comunista: è bene ricordare ambedue i fattori. Un venir meno prodotto dal balzo in avanti delle forze produttive che richiedevano altri involucri statuali per poter produrre profitti e competere in modo più cospicuo; per noi ciò ha significato la costituzione sempre più concreta dell’Unione Europea. Forze produttive che però hanno trascinato con sé tutti gli aspetti della vita dei popoli coinvolti, dalla comunicazione alla formazione culturale, dagli apparati produttivi alle istituzioni politiche, insomma un salto storico del quale si è sottovalutato il rilievo fino al sopraggiungere della crisi finanziaria del 2007.
In negativo è scontato indicare le responsabilità, la miopia di quei gruppi dirigenti in tutt’altre faccende affaccendati, ad esempio quelle elettorali, ma allo stato attuale il problema principale è quello di capire come adeguare, di nuovo, il movimento di classe e comunista alla nuova dimensione storica che ha superato la precedente dimensione nazionale. Naturalmente questo processo di superamento dei confini nazionali coinvolge tutte le aree economiche e monetarie che, in diversi modi, si sono predisposte a questo passaggio dimensionale della produzione e della circolazione di capitale, vedi il ruolo del NAFTA per gli USA. Ma riconcepire una prospettiva per i comunisti del nostro paese significa accettare in primis la sfida della qualità teorica e politica, la sola cosa che può metterli in condizione di comprendere le dinamiche della realtà e di attrezzarsi adeguatamente, anche concependo ipotesi alternative e di rottura a quelle della Unione Europea, ideologicamente presentata come unico esito possibile per i popoli del continente.
2) Fine della democrazia borghese? Un altro dato di fondo che ha caratterizzato la nascita e l’affermazione del partito di massa è stata la lotta per la democrazia. Attorno a questo nodo del conflitto di classe nel nostro paese ci sono stati momenti costitutivi di quel periodo storico, la battaglia vinta contro la legge truffa nel 1953, il governo Tambroni caduto dopo il tentativo nel ’60 di rilegittimare i fascisti accettando il loro appoggio all’esecutivo, la ventennale lotta nei posti di lavoro per i diritti sindacali in cui centrale è stato lo scontro con la FIAT Vallettiana, altri momenti ancora di conflitto politico che sono stati fondamentali per allargare gli spazi democratici in un paese in cui la classe dirigente portava ancora i caratteri della cultura reazionaria sopravvissuta al fascismo.
Va chiarito però un carattere centrale di quel periodo. La battaglia sulla democrazia, l’allargamento dei suoi spazi non erano finalizzati solo all’affermazione di principi generali ma erano vissuti, dal movimento di classe nel nostro paese, come una “tappa” della lotta per la trasformazione sociale in Italia. Era ormai chiaro che non si poteva fare “come in Russia”, ma si poteva ipotizzare una transizione democratica e pacifica verso un sistema sociale più equilibrato e non ancora socialista.
D’altra parte in quegli anni i paesi dell’est europeo non avevano immediatamente adottato il modello sovietico, esisteva infatti la proprietà privata seppure controllata, c’erano altri partiti oltre quelli comunisti, ed era chiaro che in quelle condizioni continuava la lotta di classe, cioè era chiaro che la società era ancora suddivisa in classi. Esplicativo dell’orientamento del PCI dell’epoca sono gli articoli di Eugenio Reale e di Eugenio Varga pubblicati sui numeri di «Rinascita» di Maggio e Giugno 1947 dove questa lettura dei paesi dell’est Europa viene spiegata in modo dettagliato.
Era questo lo sfondo in cui si sviluppava nel nostro paese, ed in altri in Europa, la battaglia per la democrazia intesa in modo “progressivo”, un contesto in cui si poteva anche ipotizzare una riunificazione dei partiti di classe ovvero del PCI e del PSI.
È chiara anche la differenza tra quella democrazia come terreno del conflitto per la trasformazione e quella di cui si è parlato dopo. Infatti già dall’inizio degli anni ’70 questa concezione progressiva viene meno da parte del PCI il quale, a causa del forte scontro politico, accetta in pieno la concezione della democrazia formale ovvero borghese. La difesa della Costituzione Italiana diventa perciò di tipo “religioso” come accettazione di tavole inviolabili ed immodificabili; avendo abbandonato ogni ipotesi di transizione si fa diventare la democrazia borghese il terreno politico più avanzato non in termini di classe ma in termini di valori generali, socialmente indistinti. Si assume lo Stato borghese così com’è, come baluardo da difendere tout court.
Non vogliamo qui dare giudizi di merito su quelle modifiche politiche, ma rilevare come la questione democratica si sia trasformata e come il partito di massa abbia adeguato le proprie concezioni e relazioni alle condizioni specifiche di quei tempi, arrivando cioè ad una sostanziale modifica della propria finalità strategica.
Questo passaggio non ha avuto solo effetti sulla sua linea politica ma ha inciso profondamente sul modo d’essere del partito di massa e delle sue relazioni interne. Venendo meno il “Fine”, ovvero la “Rivoluzione” intesa anche nelle sue forme democratiche così come le aveva concepite il PCI (sono di quel periodo le dichiarazioni di Berlinguer sull’utilità dell’ “ombrello” della NATO e sulla fine della spinta propulsiva dell’URSS) al primo posto è balzata la politica vista come tattica, esclusivamente relativa agli scenari politico/elettorali del momento. Ciò ha causato una mutazione della percezione della politica da parte dei quadri del partito, rimuovendo l’aspetto strategico e facendoli acconciare sulla sola dimensione pratica o, per meglio dire, pragmatica.
Tutto ciò ha avuto un effetto sulla “teoria”, ovvero sulla capacità di interpretare il mondo nelle sue dinamiche fondamentali, ed ha avuto un sottoprodotto dapprima inavvertito ma poi manifesto sui ruoli individuali, sempre più prevalenti nei gruppi dirigenti: chi non ricorda il supponente protagonismo di Occhetto? Questa maturazione perversa si è poi palesata appieno con la rottura degli involucri organizzativi delle organizzazioni della sinistra, non solo del PCI, ed è stata un presupposto della corruzione politica ed economica che ha poi portato alla devastazione attuale.
Oggi la situazione è ulteriormente modificata, la democrazia è diventata, come il lavoro, una variabile dipendente e dunque disponibile alle modifiche necessarie al livello di sviluppo delle attuali società capitalistiche. La crisi, la costruzione del Polo Imperialista Europeo, la trasformazione delle classi dirigenti a classi dominanti, portano evidentemente alla riduzione della democrazia borghese fino alla sua scomparsa di fatto, a causa delle condizioni generali imposte dal livello sempre più intenso della competizione globale che l’assetto capitalistico richiede.
Oggi è evidente che parlare di come i comunisti debbano organizzarsi e di quale funzione debbano avere non può prescindere da questa evoluzione politica e da come il contesto democratico del nostro paese stia sempre più degradando; il partito di massa così come è stato “imbalsamato” negli ultimi decenni mostra in questa fase il suo superamento, se non altro perché i partiti della sinistra italiana sono stati espulsi, non avendo alcun eletto, dal contesto istituzionale.
3) Dal bipolarismo al multipolarismo. Il cambiamento “ambientale” dell’agire dei comunisti non ha riguardato solo la dimensione nazionale ma coinvolge in pieno anche il dato internazionale che sempre ha determinato nell’ultimo secolo anche le dinamiche più specificamente nazionali. È quasi superfluo starle a ricordare in questo dibattito tanto sono evidenti: sostanzialmente si è passati dal bipolarismo prodotto dalla competizione, anch’essa globale, tra URSS ed USA ad un mondo multipolare dove le aree imperialiste si trovano a collaborare/competere con paesi che imperialisti non sono, in una dinamica che non ha mostrato ancora i suoi effetti ultimi. È una situazione storicamente inedita in cui lo strapotere dei paesi dominanti non è così completo, pur in assenza di una compiuta alternativa sociale al capitalismo. Questo mutamento richiede una qualità nella capacità di analisi dell’organizzazione ben diversa dalla fase precedente.
Sono venuti meno alcuni parametri fondamentali che hanno formato generazioni di giovani, militanti, semplici iscritti ai partiti. Uno è certamente la questione dell’imperialismo; dal 1945 l’unico imperialismo noto è stato quello degli USA, contrariamente a quanto avvenuto nelle fasi storiche precedenti alla seconda guerra mondiale, quando non esisteva l’imperialismo ma “gli imperialismi”, una differenza non da poco per chi ha percepito nella propria esperienza pratica solo quello USA.
Con la fine dell’URSS e con il ruotare della storia all’indietro, verso l’inizio del ‘900, si è continuato a pensare come prima ad un solo imperialismo ignorando il ruolo che sempre più assumevano l’Unione Europea e l’Euro come protagonisti della competizione globale, cosa questa che oggi invece emerge chiaramente dentro la crisi finanziaria mondiale. Non è stato solo un errore di carattere teorico ma ha anche fatto emergere l’incapacità di lettura sulle dinamiche della società e dei settori di classe del nostro paese, che nel frattempo accumulavano modifiche materiali, culturali e politiche sempre più forti. Se ci fosse stata questa capacità, sarebbe stato chiaro che queste modifiche imponevano di riflettere, rivedere e riconcepire le relazioni tra la soggettività politica organizzata e la realtà della classe in via di modificazione.
Ma il passaggio ad uno scenario mondiale multipolare ha posto un altro ostacolo alla capacità politica delle forze comuniste; mentre si continuava giustamente a concepire la necessità della trasformazione sociale, della rivoluzione, il modello da seguire, il come concretamente si poteva organizzare una società alternativa, è venuto meno con la fine dell’URSS e ciò ha richiesto anche qui un salto di qualità politica e teorica. La critica all’URSS non risale certo alla fine di quell’assetto statuale, ma essa era presente, ed a ragione, già dagli anni ’60 con la posizione del Partito Comunista Cinese e si è poi sviluppata con il crescere dei movimenti rivoluzionari internazionali fino agli anni ’70 e, dunque, anche nel nostro paese. Ma se quel modello non era certo il migliore da seguire, oggi nella nostra condizione politica possiamo toccare con mano il ruolo antimperialista che oggettivamente svolgeva e non certo sul versante “reazionario” della Storia.
Oggi a oltre venti anni di distanza possiamo dire che la Storia si è rimessa in qualche modo in movimento mostrando, prima di tutto, che il capitalismo mantiene tutte le proprie contraddizioni con i tragici effetti sociali, economici e bellici che possiamo osservare ma soprattutto che la fine del cosiddetto socialismo reale non ha significato la fine di tutte le esperienze rivoluzionarie che sono nate nel corso del secolo scorso.
Sapere che il capitalismo non è la fine della Storia è certamente un elemento importante, ma per noi il problema è anche come una struttura comunista si organizza per interpretare e collocare nella propria azione questa nuova realtà internazionale. Realtà che incide concretamente nella dimensione nazionale ma che non offre più, come prima avveniva, un modello sociale alternativo “certo”. Tutto questo ovviamente è rilevante per le caratteristiche dell’“intellettuale collettivo” da costruire in un contesto in cui un modello alternativo di società non è immediatamente proponibile ai settori sociali di un paese interno all’Unione Europea.
4) Attraversando il deserto culturale. Intendiamo parlare di cultura intesa come quel bagaglio, quel sapere collettivo che nasce dalle esperienze storiche concrete dei popoli e delle classi e che è fatto di riferimenti, di valori, di rapporti e comportamenti che producono una conseguente coscienza ed identità di se stessi.
Il passaggio dal partito clandestino del periodo fascista a quello di massa avviene in un drammatico periodo storico segnato dalla guerra e dalla lotta di liberazione, in cui le mistificazioni ideologiche non avevano più senso, la verità emergeva dalla durezza dello scontro e ognuno era costretto a prendersi le proprie responsabilità schierandosi da una o dall’altra parte. Una simile scelta implicava inevitabilmente la necessità di capire bene la realtà, le sue evoluzioni ed i propri interessi, per questo esistevano allora i pensieri forti che “fornivano” riferimenti e valori. Alla fine della guerra e della lotta di liberazione le classi subalterne del nostro paese uscivano in una condizione politica ribaltata da quella vissuta nel fascismo, in cui la passività e la sudditanza erano i valori del regime. A questa imponente impresa aveva contribuito il partito clandestino, di quadri, e la lotta di liberazione ma proprio da questo risultato nasceva l’ipotesi del partito di massa anche perché la cultura popolare che si era generata da quel passaggio storico permetteva la mutazione alla dimensione di massa.
Oggi qual è la condizione che vive su questa dimensione una forza comunista? Conosciamo bene lo stato di arretratezza della coscienza, non di classe ma perfino di quella civile; venti anni di devastanti campagne ideologiche hanno costruito artatamente valori e riferimenti culturali che solo la crisi attuale sta smontando lentamente. Ma più determinante è stata la scomparsa di ogni riferimento realmente alternativo ed antagonista; per quanto riguarda la sinistra in Italia va detto che è stata promossa una sorta di pentitismo di massa, cioè è stata diffusa la convinzione che tutto quello che era stato fatto nel ’900 era comunque sbagliato. Va aggiunto anche che questa visione delle cose in realtà è penetrata a fondo nel vasto popolo della sinistra, che non è stato portato a ragionare sugli errori di merito, tanti e seri, ma su un’idea di fallimento che spingeva a pensare secondo schemi ideologici che l’avversario di classe “gentilmente” ci forniva.
L’affermazione del partito del leader, che ha sostituito l’intellettuale collettivo e le pratiche democratiche nelle organizzazioni, l’accettazione del berlusconismo come male assoluto, l’assunzione politicamente paralizzante della logica del meno peggio, la perdita del valore dell’indipendenza della classe e comunque il profondo senso di impotenza e subordinazione alle dinamiche istituzionali sono le forme in cui si è manifestata l’accettazione dello stato delle cose esistente. È in questa condizione, caratterizzata dalle macerie culturali della classe, che l’idea del partito di massa entra in crisi ma è comunque in tale situazione che va riconcepito il ruolo dell’organizzazione comunista e di una conseguente egemonia sui settori sociali.
c) La forma dell’Organizzazione Politica.
Abbiamo visto come nello sviluppo delle varie fasi storiche ad ogni cambiamento prodotto dallo sviluppo capitalista sia corrisposta una modifica dell’organizzazione di classe. Questa dinamica per noi è valida ancora oggi e rispetto alle analisi che abbiamo fatto, sia sul piano della oggettività che delle condizioni soggettive, riteniamo riacquisti peso un’ipotesi di organizzazione di quadri militanti. Il partito di massa, così come lo abbiamo conosciuto, è arrivato al suo epilogo grazie alle caratteristiche dei suoi gruppi dirigenti, caratteristiche non individuali ma prodotto di un profondo processo strutturale che è approdato alla nascita del PD e sul quale non ci dilunghiamo.
A partire dalla mutazione genetica nel PCI, dal suo scioglimento e con la nascita del PRC/PdCI, il partito comunista di massa ha ritenuto esaustiva la sua funzione nella società italiana basandosi su uno schema semplice, ripetuto ossessivamente e mai messo in discussione:
– il rapporto di massa delegato al rapporto con la Cgil, sempre più con la Cgil come apparato e sempre meno con i lavoratori;
– partecipazione alle elezioni a qualsiasi costo, intendendo con esse l’unica ragione d’esistenza in vita sul piano politico;
– attività politica limitata alla propaganda e mobilitazione limitata alle manifestazioni centrali, feste, campagne elettorali.
Occorre ammettere che questo schema si è rivelato nel tempo inadeguato ed inefficace, disastroso su tutti e tre i punti. Non solo. Da questo modello di funzione politica è praticamente scomparso il tema dell’organizzazione cioè di come, dove, quando il partito organizza concretamente e – con quali strumenti propri – i settori sociali di riferimento.
Il modello dei tre fronti (strategico/ideologico, politico, sociale/sindacale sul quale torneremo successivamente) ipotizzato dalla Rete dei Comunisti, ha cercato di rispondere non solo alla crisi dei partiti comunisti tradizionali ma anche di mettere a disposizione un modello da discutere, verificare, sperimentare, un’ipotesi che è stata rimossa o rigettata sistematicamente dalla discussione nei e dei partiti comunisti esistenti in Italia dopo lo scioglimento del Pci.
In altre parole il partito di massa in questa fase storica è troppo “debole” e con troppe contraddizioni interne per affrontare le difficoltà di un passaggio complesso; in questo senso va ridato ruolo alla qualità dell’analisi e delle relazioni interne all’organizzazione, alla capacità di interpretare e costruire il conflitto di classe, alla formazione dei quadri ma anche di orientamento di ambiti sociali di “avanguardia”, tutto ciò ovviamente nei limiti delle possibilità date. Quello che deve emergere è un modo sostanzialmente diverso di come si è vissuto in questi anni e di come ancora si vive la militanza, dove la formazione politica si sostituisce all’attivismo periodico nelle scadenze elettorali e dove la necessità di costruire sistematicamente il conflitto e l’organizzazione di classe diviene un elemento centrale dell’azione dei comunisti nella società. Quello che proponiamo non è certo un’idea già definita di organizzazione, ma è di ragionare sui presupposti che possano produrre un’ ipotesi d’organizzazione comunista in sintonia con i tempi e con la sua collocazione in un’Unione Europea imperialista.
1) l’Organizzazione militante di quadri. La scelta del “partito dei quadri” dunque non è volontaria né dettata da settarismo, peraltro molto “impegnativo” e poco gratificante, ma è data dalla situazione; ciò non significa che quest’ipotesi sia esaustiva, si tratta di un passaggio obbligato per ridare credibilità di massa alla possibilità di cambiamento. Ritorna in ballo l’importanza della soggettività ed in questo senso ripartire dal “CHE FARE?” significa trovare un valido riferimento teorico per ricostruire un’ipotesi sapendo che quest’elaborazione e verifica vanno fatte nelle condizioni odierne. Vale comunque la pena di ribadire che parlare di partito di quadri non significa porre un limite quantitativo e dunque avere necessariamente un approccio minoritario, bensì significa mettere al centro la qualità della militanza, la maturità dei singoli compagni che devono essere coscienti della complessità del compito che si sono scelti, oltre che darsi un’organizzazione in grado di sostenere l’impegno collettivo ed individuale richiesto.
Capacità di sintesi e rapporto di massa, organizzazione e spontaneità sono questioni estremamente moderne riportate in auge dalla riorganizzazione capitalista e dal nuovo livello di sviluppo delle forze produttive, che stanno determinando a livello mondiale una nuova situazione di movimento e dunque di apertura di spazi per le alternative. Partito o organizzazione di quadri, perché deve affrontare situazione in evoluzione con i caratteri detti. Ricostruire dunque un intellettuale collettivo significa misurarsi con i problemi dell’egemonia e della teoria oggi, e questo non può essere fatto da un corpo militante che è tale in occasione degli “eventi” politici o delle scadenze elettorali.
L’inadeguatezza di un tale agire è palese ed è inutile spiegarla; il problema che abbiamo è come predisporsi per il suo superamento. La sinistra anticapitalista, sia in Italia che più in generale in Europa, deve fare i conti con un protagonismo movimentista affermatosi in modo particolare sopra la forma partito dopo il crollo del blocco sovietico. In un quadro simile, con un livello particolare ed una coscienza di classe ai minimi termini, riproporre oggi la struttura del partito di massa può essere un grave errore strategico. Il problema dell’organizzazione politica non è quantitativo ma qualitativo; in tal senso riprendere oggi l’insegnamento di Gramsci significa affrontare nello specifico le “quistioni” della formazione e dell’autoformazione, della preparazione dei quadri, con un’etica ed una precisa disciplina rivoluzionaria.
Se le dinamiche storiche che abbiamo cercato di estrapolare sono minimamente azzeccate, e cioè la disgregazione della classe nella produzione flessibile, la complessità sociale dei centri imperialisti, le caratteristiche inedite dei sommovimenti politici legati alla nuova condizione sociale e di classe (da noi la realtà del M5S o dei populismi di destra in Europa) ne consegue, anche qui, la necessità di un approccio qualitativo che non può essere sostituito da nessun protagonismo politico/elettorale visto lo spessore delle questioni che si pongono di fronte ad una seria ricostruzione di una realtà comunista, partito od organizzazione che sia.
2) Militanza e coscienza di classe. Questo salto qualitativo dell’agire di un’organizzazione comunista non può non misurarsi con il contesto in cui deve maturare una moderna coscienza di classe, in relazione diretta con l’impegno militante individuale che sta alla base di una tale organizzazione; su questo aspetto è ineludibile un approfondimento analitico e teorico. Nelle fasi precedenti, infatti, il rapporto tra partito e soggetto sociale, la classe operaia propriamente detta, era un rapporto diretto e funzionale, ovvero la lotta politica per le classi subalterne si associava ad una possibilità di emancipazione anche a livello individuale; chi faceva militanza, partendo da una condizione sociale di classe e subalterna, faceva di quest’impegno il suo punto di forza e d’identità personale per “progredire” anche sul piano culturale.
Tutto ciò oggi può essere solo parzialmente vero se riferito alle modalità classiche del movimento operaio, ad esempio per i lavoratori immigrati che vivono una condizione di sfruttamento e di degrado sociale. Si pone, perciò, il problema dei settori sociali proletarizzati e penalizzati da questo sviluppo, spesso composti da lavoro intellettuale piuttosto che manuale, che devono anch’essi trovare gli elementi d’identità e di emancipazione che li spingano ad impegnarsi fino a modificare la propria visione del mondo, cioè quella ora fornita dal sistema dominante. Questo elemento va ben evidenziato perché mentre sembra teoricamente corretto parlare di partito di militanti, sappiamo bene che la società non produce automaticamente soggetti disponibili a questa relazione, almeno questo è quello che ci dice la nostra esperienza diretta, e questa difficoltà si manifesta mentre i militanti della nostra variegata sinistra rischiano di ripiegare e individualizzarsi ancora di più sotto il peso di nuove sconfitte e con il passare del tempo.
3) La nostra critica alla “rifondazione comunista”.
La nostra impostazione e i nostri ragionamenti sulla questione del partito non possono non fare i conti con la storia concreta nel nostro paese della Rifondazione Comunista, al di là delle sue forme e delle evoluzioni diversificate che ha preso nell’arco degli ultimi 25 anni. Indubbiamente essa è stata tra le esperienze più significative dell’Europa occidentale perché, chi all’epoca decise di rompere con il PDS, poté gestire un capitale politico ed umano che il PCI e quella che era stata la sinistra extraparlamentare, ritrovatisi alla fine assieme nel PRC, avevano lasciato dopo la scissione di Occhetto dal comunismo. Nonostante che molti compagni/e della RdC siano passati dentro l’esperienza di quel partito, questa si è trovata fin dall’inizio fuori da quell’ambito a causa della divaricazione esistente tra l’analisi dei processi complessivi, che all’epoca cominciavano a segnare elementi di novità e la dinamica che prendeva corpo dal Movimento per la Rifondazione Comunista, al Partito della Rifondazione fino all’assunzione di Bertinotti alla segreteria politica. Va tenuto conto che quella scelta di estraneità fu all’epoca cosa difficilissima vista la capacità attrattiva di un’esperienza che alla sua nascita disponeva già di un potenziale politico e quantitativo molto consistente, tanto da raccogliere decine di migliaia di iscritti e da raggiungere successivamente circa il 10% dell’elettorato.
Nonostante le critiche fatte all’epoca sulla politica di quel partito, che ha avuto sempre come riferimento contraddittorio le varie mutazioni del PCI, dal PDS al PD, ed i governi di centrosinistra a guida, soprattutto, di Prodi non erano per noi queste il cuore della questione. Certamente la scelta di approvare il pacchetto Treu sulla precarietà, le giravolte sulle varie riforme delle pensioni fino ai molti voti a favore degli interventi militari, hanno segnato la divaricazione e spesso anche la contrapposizione di piazza; come avvenne ad esempio in occasione del 9 Giugno del 2007 nelle manifestazioni contro Bush dove la sinistra, allora di governo, venne letteralmente isolata da una manifestazione di decine di migliaia di persone che protestavano in alternativa al presidio della sinistra.
I punti di critica e diversificazione effettivi sono stati, invece, sempre di tipo strategico in quanto elementi evidenziati nelle nostre analisi anche se in realtà esse non hanno mai avuto cittadinanza politica in una sinistra “radicale” che oggi paga il fio della sua inconsistenza analitica e teorica. I punti su cui abbiamo battuto per anni sono questioni che oggi emergono dalla realtà dei fatti, ma che nascevano da un tentativo di non abbandonare la cassetta degli attrezzi marxisti nella visione del mondo. Vale la pena di ricordare alcuni di questi punti.
– Certamente la questione dell’imperialismo, ovvero degli imperialismi. L’innamoramento strumentale sulla teoria dell’Impero prodotta dal pensiero di Tony Negri, grandemente sponsorizzato dal segretario Bertinotti, è stato certamente il punto dirimente della nostra divergenza con il pensiero maggioritario che viaggiava all’epoca tra i comunisti. Questa divergenza non è stata puramente teorica in quanto ha assunto nel tempo una valenza politica attorno alla natura della Unione Europea che dagli anni ’90 si è sempre più rafforzata creando prima la moneta unica e poi, di crisi in crisi, configurandosi sempre più come una nuova dimensione statuale in formazione.
Oggi la divaricazione è totale e la vicenda greca della scorsa estate ha portato alla luce le due tendenze che si sono manifestate tra i comunisti ed il movimento di classe. Pensare di democratizzare l’UE è un discrimine direttamente politico, evidente e che produce schieramento. L’errore anche in questo caso sarebbe di non continuare ad elaborare le analisi autonome sulla natura del soggetto imperialista subordinandole alle manifestazioni contingenti e contraddittorie che si producono nel corso della competizione internazionale e delle tattiche che gli imperialismi adottano.
– Un altro punto di divaricazione conseguente è stata la valutazione sulla condizione della classe reale che si veniva configurando nel paese e nel nostro continente. Il processo di costruzione del Polo Imperialista Europeo è stato un fatto strutturale, anche se è il prodotto di una strategia politica delle classi dominanti europee; un fatto che si è collocato dentro la mondializzazione effettiva del Modo di Produzione Capitalista, che ha prodotto una profonda ristrutturazione produttiva, finanziaria, commerciale ed infine sociale, del mondo del lavoro ed ideologica. Tutto ciò ha inciso su quella che abbiamo definito la composizione di classe, che oggi assume forme storicamente inedite e produce la necessità di analizzare a fondo la condizione sociale in cui agiamo e che viene sistematicamente rivoluzionata dalle contraddizioni del capitalismo.
Non solo non abbiamo la composizione di classe di fabbrica e operaia degli anni ‘70, ma quest’ultima è coinvolta nei processi economici che si sono sviluppati negli ultimi decenni. Abbiamo visto nei decenni passati la formazione di un’aristocrazia salariata, simile per funzione a quella operaia analizzata a suo tempo da Lenin, fatta di lavoro dipendente ed autonomo, orientata verso il consumo ed il sostegno al mercato, che politicamente è stata la base sociale del centro sinistra, ed in parte anche dalla sinistra. Formazione sociale che si è fatta subalterna, grazie alla propria condizione di relativo privilegio verso il resto del mondo, allo sviluppo generale attuale, incluso quello della tendenza alla guerra. Oggi questa condizione, che ha segnato la situazione almeno fino all’inizio della crisi nel 2007, è in via di superamento perché la crisi in atto sta riproducendo i processi di diseguaglianza e di proletarizzazione classici dello sviluppo capitalista, anche del lavoro intellettuale, che nel contesto attuale penalizzano i settori sociali ed i popoli del sud Europa come la vicenda greca, ma anche quella spagnola, portoghese ed italiana, stanno plasticamente dimostrando.
È esattamente in questo contesto che abbiamo mosso la critica al partito comunista di massa, non perché lo ritenevamo sbagliato in base ad astratti principi politici, ma perché ci sembrava che si stessero creando le condizioni storiche e materiali per il suo superamento. Né i gruppi dirigenti comunisti percepivano questi cambiamenti in quanto i riferimenti assunti erano quelli della politica contingente, cosa che significava sostanzialmente pensare alle elezioni come ambito prioritario della politica e della stessa sopravvivenza di partito. Errore di calcolo, questo, che oggi appare in modo lapalissiano in quanto il partito comunista di massa è di fatto scomparso, al di là di ogni scelta, con la rescissione di tutti i legami sociali in nome della politica mentre il partito di quadri, l’unica forma che potrebbe tenere nella bufera storica in cui siamo immersi, è fuori da ogni concezione essendo stato semplicemente rimosso dalla cultura politica dei comunisti.
Ma la concezione del partito di massa, trascinata in un contesto storico diverso, ha prodotto anche un altro danno che ha approfondito le difficoltà dei comunisti. Ci riferiamo alla questione sindacale; se la scelta strategica, infatti, è stata quella di salvaguardare il carattere di massa e dunque elettorale, sul piano sindacale le relazioni ed i progetti non potevano che privilegiare i rapporti con la CGIL. Da tempo era a tutti evidente la degenerazione di quel sindacato, CISL e UIL l’avevano preceduta, con le politiche concertative e poi complici che hanno avuto l’unico obiettivo di contenere il conflitto di classe. Dire queste cose oggi è una ovvietà in quanto è la CGIL stessa che si premura di eliminare tutti quei soggetti che sono “fuori linea” e sospetti di una pur parziale dissidenza. Questa strategia disastrosa è stata politicamente giustificata con la necessità di dare battaglia dentro il sindacato storico di classe, quando erano già evidenti i processi di degenerazione, ma in realtà ciò rifletteva la debolezza teorica e pratica della rifondazione in atto, incapace di rapportarsi ed organizzare direttamente i settori di classe con propri progetti indipendenti. Tutto sommato, quello che andava salvaguardato era il bacino elettorale rappresentato dal sindacato che una scissione della CGIL non avrebbe garantito di mantenere.
Giustamente non possiamo dimenticare la questione dei movimenti, ovvero del “movimento dei movimenti” così come venne definito. Questa ha un versante tattico legato a quel momento politico che è stato quello che prevalse all’epoca; non a caso il PRC di Bertinotti, oggi fan di Comunione e Liberazione, raggiunse il massimo del risultato elettorale. Ma c’è anche un versante strategico sul quale vale la pena di ragionare; non si può certo nascondere la dimensione di massa raggiunta che nei primi anni 2000 portò ad ipotizzare una rinascita della sinistra “antagonista”. A quel movimento partecipammo anche noi in varie forme, oltre quella diretta della RdC, in quanto ravvisavamo una opportunità con la quale misurarsi. Detto in termini diretti, se la sinistra comunista si era imbarcata e spaccata nella vicenda governativa di Prodi, riprodottasi fatalmente poi nel 2006, tutto quello che era stato il corpo sociale in particolare legato al PCI, che andava dalla CGIL/FIOM all’ARCI alla Lega delle Cooperative all’associazionismo pacifista e cattolico insomma tutta la sedimentazione culturale e sociale prodottasi dal dopoguerra, trovò una sua autonomia di movimento in una situazione di crisi politica della sinistra e di incipiente pericolo berlusconiano. Una possibilità, creatasi anche grazie al movimento di Seattle, che venne consumata negli anni successivi nel tatticismo, nelle scadenzismo elettorale e nel carrierismo individuale a noi tutti ben noto. Dunque dopo la consunzione politica dei partiti c’è stata la consunzione materiale di quel blocco sociale che sosteneva la sinistra nel nostro paese. Se quella sinistra diffusa, che poi è stata la base di tante mobilitazioni fatte anche contro le proprie rappresentanze istituzionali, oggi vive anch’essa una condizione di disgregazione e dispersione le responsabilità non possono che essere ricercate in una rifondazione che non ha saputo e voluto essere direzione politica realmente antagonista così come invece si affermava.
In sintesi. Quello che stiamo proponendo non è certo un’ipotesi di partito, che non può che nascere nel conflitto di classe se i comunisti riescono a trovare le forme ed il modo per riproporsi come “avanguardia”, come si usava dire in altri tempi. È piuttosto il tentativo di riaprire la discussione su un piano che è stato completamente rimosso o che è stato delegato agli intellettuali i quali hanno fatto molti danni, ovviamente perché lasciati a se stessi e senza un termine medio di rapporto con la realtà di classe del paese. Proporre un seminario e non un convegno in cui si sostengono tesi definite significa aprire un confronto senza velleità o riduzioni organizzativistiche ma con la necessaria determinazione. La fase che si apre, le contraddizioni che si esprimeranno e le loro forme saranno del tutto inedite e, questa volta, non c’è nemmeno a disposizione quel capitale politico ed umano che negli anni ’90, pur su linee politiche poi rivelatesi sbagliate, ha permesso un protagonismo politico significativo e movimenti di massa nel nostro paese.
Nessuna sintesi organizzativa immediata ma la necessità di un confronto e di un approfondimento teorico che sia anche di formazione per le giovani generazioni; siamo disponibili ad istituire, anche formalmente, una sede stabile e periodica in cui il confronto tra comunisti sia libero dalle contingenze politiche, ma funga da bussola per il loro agire politico e nel rapporto con la classe reale del nostro paese.
LA FORZA. OVVERO I COMUNISTI E LA CLASSE
La questione della “forza” si pone non solo come caratteristica diretta dell’organizzazione politica ma in quanto capace di organizzare e, dunque, di rappresentare una classe, un blocco sociale. Non esiste nessuna seria “organizzazione comunista” se non è radicata nella classe e nel conflitto. Non si forma nessun quadro comunista se non si fanno i conti in prima persona con la realtà delle “masse” concretamente esistenti. Il rapporto di massa è l’unico terreno di verifica delle capacità individuali e collettive di “costruire organizzazione”. Ogni ipotesi strategica o di linea politica, se non riceve il conforto della verifica di massa, resta una pura ipotesi. Ogni argomento che non “fa presa” su un interlocutore di massa reale o è sbagliato o è “detto” in modo incomprensibile.
Alla disgregazione materiale indotta dalla riorganizzazione produttiva e sociale si risponde con un forte ruolo della soggettività nei processi di ricomposizione del conflitto di classe; pensare di farlo partendo solo dalla “politica”, magari intesa nella sua dimensione più autonoma e astratta, significa continuare a seguire una via senza uscita. Far crescere il rapporto di massa organizzato, fornire ai quadri politici un metodo di lavoro e di verifica delle proprie ipotesi, è invece un compito cui nessuno si può sottrarre. Noi per primi, ovviamente. È partendo da questi elementi che vanno intrapresi i processi di ricostruzione da contestualizzare al quadro complessivo che abbiamo cercato di tracciare.
Se la questione posta nel capitolo precedente sul partito di quadri è fondamentale, altrettanto importante è la “funzione di massa” che questo deve saper svolgere , in quanto, seppure è evidente la difficoltà dei comunisti di riprodurre nella società attuale l’egemonia dei decenni passati, sia per responsabilità soggettive che per condizioni oggettive, vanno comunque individuati e ricostruiti gli snodi del rapporto con la più ampia parte della società così come è oggi, diversa da quella che è stata nei precedenti periodi del conflitto di classe.
Lavorare per ridare una rappresentanza politica alle classi subalterne, distrutta dai processi di riorganizzazione capitalistica, supportare ed organizzare il conflitto sociale e sindacale nelle molteplici e disgregate forme che oggi manifesta, ridare un ruolo ai giovani in una società che li vuole senza futuro, questi ed altri sono i terreni di ricostruzione che devono affrontare le organizzazioni comuniste; terreni propedeutici anche a produrre una diversa visione del mondo e alle possibilità di superamento della profonda crisi attuale.
“Funzione di massa” intesa non come semplice orientamento politico da fornire a chi oggi è immerso nelle contraddizioni, orientamento reso impossibile dagli “apparati ideologici dello Stato”, dalla scuola ai mass media, ma come intervento diretto di organizzazione del conflitto di classe conle forme adeguate a tutti i suoi articolati livelli di espressione. La politica così come l’abbiamo intesa nei decenni passati non esiste più, il conflitto rivendicativo permane ma i rapporti di forza tra le classi sono troppo sfavorevoli ai lavoratori. Si riconferma pertanto l’indispensabilità della progettualità in funzione e per la costruzione diretta e non formale dell’organizzazione di classe, in sostanza per dare corpo a quell’accumulazione delle forze che è l’unica possibilità di modificare i rapporti sociali.
1) I “tre fronti” del conflitto di classe e la ricomposizione.
Se parliamo di partito e organizzazione politica il dato da cogliere è quello della sintesi degli elementi strategici, ma se parliamo di rapporto di massa prevale la complessità delle figure sociali esistenti e la necessità di individuare le attuali modalità organizzate del rapporto politico e sociale. Anche su questo piano ci sembra che ci siano state delle discontinuità che vogliamo proporre e discutere. Non ci sembra, infatti, adeguata una continuità automatica sul ruolo del partito e sulla sua azione rispetto a quella che era stata la fase precedente fino al 1991, protrattasi anche negli anni successivi. Fase che aveva visto nel partito di massa il punto più avanzato di sintesi dei progetti di trasformazione sociale. Sintesi che riguardava la stessa prospettiva della trasformazione, mantenuta come orizzonte anche dal PCI, la rappresentanza politica e parlamentare e la rappresentanza sindacale in cui la CGIL aveva un ruolo centrale. Questa funzione di sintesi dell’organizzazione politica di massa era valida sia per il PCI che per le diverse organizzazioni della sinistra rivoluzionaria, emerse dopo il ciclo di lotte del ‘68/’69, nonostante il durissimo scontro sulle linee politiche. Quella fase di profonda trasformazione della società italiana fu attraversata da un conflitto di classe generalizzato ma anche da una ricca elaborazione teorica e culturale che in quel contesto definì con chiarezza profili e strategie politiche.
Il punto di fondo che segna la differenza è che la sconfitta storica avuta ha portato allo scompaginamento di quei tre fronti che per tutto il ‘900 avevano trovato una sintesi politica ed una capacità di azione e trasformazione nel partito. Si tratta del piano teorico-strategico relativo ai comunisti, quello politico e istituzionale e quello sindacale-sociale; se vogliamo possiamo dire che lo scompaginamento prodotto è stato paragonabile ad una sconfitta militare che ha obbligato l’esercito in rotta ad una ritirata strategica e ad una riorganizzazione che non poteva presupporre di nuovo e in tempi rapidi battaglie campali.
Riproporre invece il partito di massa così come era stato precedentemente costruito; non fare i conti con gli effetti ideologici sulla classe degli eventi di quegli anni, oltre che con le caratteristiche delle modifiche strutturali; concepire il rapporto di massa dell’organizzazione politica come semplice “cinghia di trasmissione” o, peggio ancora, come rapporto elettoralmente strumentale, significava essere fuori dalla nuova realtà maturata in quegli anni di crisi e inconsapevoli degli effetti reali delle brutali dinamiche che avrebbero agito a livello internazionale. Non a caso non aver preso atto della profonda modifica del contesto ed aver pensato di poter procedere per “coazione a ripetere” ha portato alla sconfitta nelle battaglie campali che di volta in volta sono state tentate, da quelle elettorali al movimentismo sindacale e sociale fino alla disgregazione attuale.
In questo senso ci sentiamo di proporre all’attenzione e alla discussione, e anche alla critica, la convinzione cui siamo arrivati in quegli anni, ovvero che la sconfitta, che ancora permane, richiede un processo di ricomposizione della classe che non può essere direttamente “politico” così come è stato concepito fino alla crisi politica della sinistra italiana nel 2008. Ciò richiede, invece, nel nostro paese e, ci sembra, anche nel resto dell’Europa un’articolazione organizzata sulla base dei tre fronti del conflitto di classe sopra richiamato. In un tale processo di ricomposizione pensiamo che il “fronte” politico, che abbiamo definito anche come Rappresentanza Politica del blocco sociale, e quello sindacale-sociale debbano avere una loro specifica progettualità; in relazione ovviamente con un progetto di trasformazione rivoluzionaria della società. Progettualità che abbia anche una sua autonomia e capacità di organizzazione e rappresentazione che oggi non può essere, nel cuore dell’imperialismo europeo, direttamente rappresentata dall’identità comunista dati i rapporti di forza e la storia recente di questa parte del mondo. Il ruolo dei comunisti in questo assetto politico e sociale non può che essere quello di dimostrare la propria capacità di essere direzione sostanziale dei processi di ricomposizione ovvero di “accettare la sfida”; non ci sono risposte formali sul ruolo dei comunisti, o questi sono capaci di essere elemento progressivo per una prospettiva di classe oppure oggi non basta definirsi comunisti per aver riposta la fiducia delle “masse”.
L’eventualità che le crisi non generino eventi rivoluzionari non giustifica l’abbandono del piano alto della trasformazione radicale e delle potenzialità per la costruzione di una fase di transizione verso il socialismo. Al contrario oggi più che in passato si pone con maggiore forza la necessità di “volare alto” ma con i piedi saldamente piantati a terra, nella materialità delle cittadelle imperialiste in cui viviamo. Proprio la prassi gramsciana ci ha insegnato che i tre fronti in cui si articola il processo rivoluzionario non possono essere slegati dalle condizioni in cui si trovano a convivere ed entro le quali agiscono le forze che si battono per il superamento del capitalismo.
Va detto anche che questo quadro, che per noi ha valenza da diverso tempo, sta subendo delle evoluzioni in base all’incedere della crisi che, divenendo ancora più brutale ed eliminando i terreni di mediazione possibili, tende a politicizzare sempre più i conflitti e le contraddizioni obiettive. Questo è un passaggio che allo stato attuale, in base a nostre valutazioni, non modifica ancora l’idea dell’articolazione organizzata dei tre fronti ma certamente ci spinge ad indagare verso una possibile ricomposizione, che per ora è sul piano della politica ma è importante perché crea le condizioni per un processo di unificazione del conflitto e dunque della prospettiva.
In concreto la costruzione dell’Unione Europea sta producendo i terreni di unificazione potenziali visto che una sintesi effettiva è possibile solo con una soggettività, per noi comunista, che abbia coscienza dei processi complessivi. Tale processo, infatti, ha difficoltà a maturare spontaneamente, direttamente dal conflitto sia politico (vedi il malessere generale che spinge ampi settori sociali anche di classe verso la destra populista) che sociale/sindacale (che spesso tende a ripiegarsi nello specifico vertenziale che non può che portare all’impotenza o alla sconfitta).
2) Organizzazione e coscienza di classe.
Il termine Organizzazionein questi ultimi decenni è stato vissuto come questione organizzativa, nei migliori dei casi come strumento per fare politica nelle campagne elettorali. Si è perso il significato profondo di organizzazione di classe, che è un processo indipendente interno alla classe, è infatti la costruzione di quel tessuto connettivo che poi è in grado di agire nel conflitto e che ha determinato i processi storici. La riduzione, avvenuta anche tra i comunisti, del concetto di organizzazione a puro significato strumentale non può essere rimosso da una riflessione critica del rapporto tra comunisti e classe e per questo vogliamo tentare un passaggio teorico complesso che cerchiamo di rendere più sintetico possibile per non appesantire troppo il presente documento.
Il rapporto tra organizzazione e coscienza di classe è una relazione fondamentale per affrontare la questione della soggettività. La coscienza di classe, nell’attuale perdita generale dei riferimenti teorici, è vissuta nella migliore delle ipotesi come elemento valoriale, di concezione generale mentre in realtà per poter sopravvivere ed affermarsi deve radicarsi nel corpo della classe, come elemento concretamente esistente ed operante nel continuo conflitto con l’egemonia borghese. La coscienza non è solo un dato sovrastrutturale ed identitario, essa va compresa nel profondo legame che ha con le contraddizioni della società capitalista. Ci interessa mettere a fuoco la percezione soggettiva della classe, cioè di come le classi subalterne vivono le relazioni sociali in questa realtà, se questa condizione porta ad una presa di coscienza collettiva, oppure se, al contrario, ciò non avviene. Analizzare questo aspetto è un passaggio fondamentale per capire poi come l’organizzazione politica, il partito, debba svolgere concretamente la sua funzione.
Nell’affrontare l’aspetto della soggettività del proletariato dentro questo processo storico, bisogna definire innanzitutto, con una certa precisione, cosa si intende per coscienza collettiva ovvero per coscienza di classe. Una coscienza politica di classe presuppone che un individuo si riconosca non solo come tale ma anche come appartenente ad un raggruppamento sociale, che ha gli stessi interessi materiali, che svolga lo stesso ruolo sociale e che abbia un’idea generale e definita del mondo e del suo sviluppo. La manifestazione di una tale appartenenza non significa solo avere una visione del mondo specifica ma implica anche l’esistenza di una base unitaria la quale può, appunto, generare un orientamento unitario e dunque il nesso tra base e rappresentazione del mondo, e quindi coscienza, è ineludibile. Quando noi parliamo di indipendenza della classe, dobbiamo allora individuare qual è la base indipendente che produce una coscienza indipendente.
Dobbiamo comprendere se nella produzione socializzata, sempre più socializzata, il proletariato può trovare una sua base materiale indipendente; per questo c’è bisogno di individuare il percorso teorico da seguire. Il primo dato è che il Mercato, soprattutto nella fase di autonomizzazione del capitale finanziario, assume oggi un valore generale, oggettivo di riferimento; il secondo è che il proletariato è parte interna, integrata del sistema di produzione e riproduzione, e non ha spazi di esistenza indipendenti nella produzione capitalistica generale. Inoltre questa “parte interna” della produzione è una parte penalizzata dallo sviluppo capitalista e sottoposta a pressioni di ogni tipo. Possiamo dire che questo genera contraddizioni concrete, anche fortissime in alcuni momenti storici, però non fornisce quella base indipendente che possa essere il punto di partenza per una propria visione indipendente del mondo. Il proletariato è tutto interno al sistema di produzione capitalistico sia sul piano sociale che su quello tecnico. La “sussunzione”, cioè la subordinazione, del lavoro al capitale diviene da formale a reale dentro il processo storico. Per un approfondimento su questo punto rinviamo al nostro testo pubblicato nel 2011 titolato “Coscienza di classe e Organizzazione”.
L’operaio professionale della fine dell’800, che ha un ruolo determinante nella produzione e che “usa” le macchine, viene soppiantato dall’operaio di linea che è meno qualificato e che viene “usato” dalle macchine. Anche quello che ora viene definito lavoro autonomo, nelle sue varie forme, è sempre più subordinato sul piano produttivo e finanziario al capitale nella sua fase di “autonomizzazione”. Dunque non solo il proletariato non ha basi materiali indipendenti ma anche coloro che sembravano averne sono sempre più sottoposti alla pressa del capitale finanziario.
D’altra parte l’accelerazione dello sviluppo scientifico e tecnologico, quale tendenza irreversibile, presuppone una sempre più completa integrazione del lavoro in genere, sia esso operaio, qualificato o intellettuale, nella complessa divisione sociale della produzione. Questa condizione materiale porta alla conclusione che se è vero che le contraddizioni dello sviluppo capitalistico possono spingere la classe ad un conflitto sociale, non è affatto scontato che queste stesse contraddizioni generino direttamente una coscienza di classe, cioè una concezione generale alternativa.
Questa valutazione non nega affatto la funzione delle contraddizioni e del conflitto sociale spontaneo che ne scaturisce, anzi senza questo nessun processo di trasformazione sarebbe possibile né alcuna soggettività potrebbe mettere in moto tali processi. Inoltre più queste contraddizioni sono evidenti ed insopportabili e più un processo rivoluzionario può essere innestato. Quello che invece ci sembra sia chiaro è che dalle sole contraddizioni materiali non può uscire un’alternativa complessiva e, dunque, un progetto razionale conseguente. Ciò che intendiamo dire forse può essere più chiaro se facciamo rapidamente riferimento allo sviluppo storico della borghesia e della sua affermazione. La borghesia non nasce come un prodotto interno al modo di produzione schiavistico/medievale ma nasce come raccordo “esterno” tra le società medievali; la posizione del primo borghese, cioè del mercante, non era interna alla produzione, come quella del contadino sfruttato che produceva, ma ricopriva una funzione esterna di collegamento tra varie società chiuse su se stesse, cioè era una borghesia mercantile, di scambio, legata solo alla circolazione della merce.
Questa “rendita” di posizione ha permesso l’accumulazione storica del capitale che è passato attraverso varie fasi; dapprima ancora come esterno alle società ma con una funzione sociale e politica sempre più forte. Basti pensare al ruolo dei banchieri presso le monarchie nazionali tra il Cinquecento ed il Settecento. Successivamente il capitale, con lo sviluppo delle forze produttive e dunque dell’aumentata divisione sociale del lavoro, è penetrato all’interno di quelle società e le ha rivoluzionate fino a condurle al definitivo superamento del vecchio modo di produzione. La Borghesia come classe ha avuto il “vantaggio” storico di avere una sua base materiale indipendente sulla quale ha costruito non solo il potere reale ma anche una concezione del mondo. In conclusione, se la Borghesia ha sviluppato la propria indipendenza in base ad una condizione storica e materiale ben definita, per il proletariato questo non è affatto dato, una sua crescita indipendente deve seguire necessariamente percorsi diversi e più complessi in quanto la propria funzione produttiva non vede ambiti autonomi di esistenza.
Fin qui abbiamo sviluppato una riflessione teorica, certamente insufficiente, che per essere spiegata in modo più chiaro deve essere, per un momento, tradotta in termini politici. D’altra parte i processi complessivi dell’ultimo quarto del ‘900 sono stati così radicali e veloci che ci forniscono l’occasione di verificare sul piano politico e concreto alcune affermazioni teoriche, sia per quanto riguarda i processi interni al capitale sia per quelli che definiscono il rapporto tra contraddizioni e coscienza della classe.
Nel presente livello di sviluppo capitalista qual è la reazione delle classi subalterne sottoposte alle contraddizioni materiali che tale evoluzione produce? Nel dare una risposta a questa domanda va tenuto ben presente che parlare di classe non significa parlare solo del proletariato dei paesi sviluppati ma fare riferimento ad una classe ormai dislocata a livello internazionale; una classe che comprende anche quei popoli che, fino a ieri, erano considerati coloniali e del terzo mondo e dunque di fatto in gran parte esterni alla produzione capitalistica. Questa nuova condizione materiale, organica e internazionale, della classe esprime oggi contraddizioni molto più forti e violente di ieri; infatti paesi interi vengono devastati socialmente e militarmente, gli ex paesi socialisti hanno visto un arretramento generale ed anche il proletariato dei centri imperialisti vede peggiorare le proprie condizioni.
Oltre a ciò possiamo constatare come ormai decine di paesi siano oggetto degli interventi militari degli stati imperialisti. Con quale livello di coscienza reagisce questa classe internazionale? E ancora, perché di fronte ad un attacco sistematico al reddito diretto ed indiretto nei paesi sviluppati non si crea una reazione non diciamo rivoluzionaria ma almeno decisamente democratica e radicale a proposito dei diritti sociali? Ed infine, perché nei paesi ex socialisti dove si assiste a derive di carattere fascista e dove quasi dappertutto è ormai chiaro che il peggior socialismo è più umano del miglior capitalismo da loro attuabile, non si genera una qualche risposta politica di massa? Potremmo continuare a lungo con le domande e gli esempi ma il dato che emerge è che nella fase di sviluppo finanziario del capitalismo la classe reale, soprattutto nei paesi a capitalismo avanzato, non crea opposizione politica generale ma si esprime su conflitti specifici, rivendicativi e corporativi, che spesso vengono utilizzati dai movimenti della destra populista o, a livello internazionale, dall’imperialismo sotto forma di conflitti etnici o religiosi.
Questa arretratezza così profonda, improvvisa ed inaspettata va però spiegata in modo più convincente. Non siamo solo di fronte ad uno “sbandamento” dovuto ad una sconfitta, il crollo della coscienza di classe, soprattutto nell’occidente capitalistico, è legato alla disgregazione di tutta l’organizzazione sociale articolata e capillare che una lunga fase rivoluzionaria aveva sedimentato nel corpo del proletariato. La perdita di coscienza collettiva, nonostante l’aumento delle contraddizioni a tutti i livelli, è stata determinata dalla distruzione organizzativa nel tessuto del proletariato causato anche dal disarmo politico delle forze che avrebbero dovuto quantomeno garantire la resistenza alla reazione. Affermare con chiarezza questa impostazione significa riconoscere il nesso diretto tra coscienza ed organizzazione sociale e politica stabile nella classe, che è l’unica concreta base materiale unitaria che il proletariato non può trovare nello specifico della produzione capitalista; ma significa anche capire che un processo di ricostruzione non può che essere un lavoro di lunga lena in cui i comunisti ritrovano il loro spirito militante. In questo ragionamento si chiarisce anche l’affermazione di Lenin, spesso letta in modo ideologico o strumentale, che la coscienza viene dall’esterno; in realtà ha scritto nel “Che Fare?” – ed intendeva – che viene dall’esterno della sola dimensione economica e non dall’esterno della classe.
Nell’affrontare la questione delle classi dal punto di vista della coscienza, determinante ai fini della politica, la situazione è ancora più complessa, infatti nella nostra società può accadere, e accade, che ad una condizione proletaria corrisponda una percezione di se stessa del tutto opposta. Questo è possibile perché chi appartiene alle classi dominanti è libero quanto vuole, mentre chi appartiene alle classi subordinate è libero quanto può, cioè quanto gli permette la società anche sul piano ideologico, ovviamente non in modo meccanicistico. Infatti il controllo dei mezzi di informazione e di formazione non è altro che una forma di lotta di classe “dall’alto” finalizzata a perpetuare la “falsa” coscienza delle classi subalterne.
La coscienza di classe è perciò innanzitutto la rottura di questa “gabbia d’acciaio” che abbandona la dimensione individuale per ricollocarsi dentro una prospettiva collettiva in cui l’organizzazione politica della classe in lotta e la pratica della solidarietà sono la condizione fondante. Questo è un principio importante in quanto se nella realtà materiale e “naturale” l’unico livello di coscienza dato è quello corporativo, per acquisire la coscienza collettiva non basta un enunciato politico giusto, una visione etica della realtà o un’iniziativa di lotta o una serie di iniziative, ma è necessaria una organizzazione stabile della classe, interna alla classe reale che esiste in un dato paese, che sappia far crescere, con la pratica e la solidarietà, la coscienza. Questo dato assume ancora più rilievo se si analizza l’aumentata complessità e frammentazione della classe nelle attuali società avanzate dove il vecchio blocco sociale, operai e contadini, è stato sostituito da una molteplicità di figure sociali e lavorative che pure non perdono la loro caratteristica di fondo dipendente e subalterna.
Ad una maggiore differenziazione sociale deve corrispondere una maggiore capacità di astrazione, per trovare i nessi unitari nella frammentazione sociale, ed una maggiore, più forte capacità di organizzazionesoggettiva per fornire la base materiale indipendente per la crescita della coscienza di classe. Non possiamo dare per scontato nessun “orizzonte” comunista e nessuna evoluzione “naturale” se non si dà il giusto peso al ruolo dell’organizzazione, e dunque del partito, nella ricostruzione di una coscienza politica della classe “qui ed ora”; così come oggi materialmente si manifesta in relazione al livello di sviluppo generale, alle “nuove” contraddizioni ed alla dimensione nazionale e sovranazionale.
3) Classe, Blocco sociale e la necessità dell’Inchiesta.
Il confronto che stiamo proponendo, ovviamente, non ha solo un obiettivo teorico; se infatti parliamo di “funzione di massa”, di organizzazione della rappresentanza politica ma anche di quella sindacale/sociale, dobbiamo anche individuare i settori di classe e quelli più genericamente sociali a cui è possibile fare riferimento per tali progetti. Non si tratta di fare l’elenco ma di analizzare le condizioni generali di questi settori e poi cominciare a capire come operare verso l’organizzazione di questi ambiti partendo, per quanto ci riguarda, dall’approccio definito nella parte precedente nel rapporto tra organizzazione e coscienza.
Nel porci questi obiettivi dobbiamo partire da alcune condizioni che oggi condizionano l’insieme dei nostri “interlocutori”, il primo dei quali è indubbiamente la complessità dei centri imperialisti in cui viviamo ed in cui i processi di riorganizzazione sono a tutti i livelli incessanti. Questa complessità non è un fatto nuovo ma procede da decenni, dati processi produttivi e sociali sempre più complessi. Dall’alleanza operai-contadini, così come è stata concepita fino agli anni ’60, si è giunti alla internazionalizzazione della produzione ed alla terziarizzazione dell’apparato produttivo. Questa complessità delle società capitaliste entra dentro le relazioni sociali e di lavoro e le rende sempre più frammentate, precarie e subalterne e dunque il problema si pone proprio a partire dai posti di lavoro. L’altra condizione di cui tenere conto è che tale frammentazione porta alla subalternità che non ha solo un aspetto materiale, di ricatto, ma anche ideologico in quanto l’assetto di potere attuale usa in modo scientifico gli strumenti di informazione e formazione a propria disposizione per condizionare non solo gli atti ma anche il pensiero dei propri potenziali antagonisti.
In questo senso non è sufficiente fare “l’elenco” di massima dei settori di riferimento ma è necessario un lavoro di indagine e di analisi per cogliere condizioni concrete, contraddizioni e visioni del mondo, per capire poi come procedere nell’organizzazione concreta dei settori e del blocco sociale. Comunque è necessario definire gli ambiti a cui ci rivolgiamo e su questi fare un confronto su come sia possibile avvicinarli a ipotesi politiche ed organizzative alternative all’ideologia dominante.
La cornice dentro cui svolgere questa funzione, intesa soprattutto come costruzione di movimento politico che mira a rappresentare una parte della società, è la lotta contro l’Unione Europea nei termini in cui la stiamo conducendo assieme ad altre strutture e militanti con la Piattaforma Sociale Eurostop; essa ha ora la forma del fronte politico-sociale che probabilmente è la più realistica per condurre in questa fase una battaglia dove il discrimine della rottura dell’Unione Europea produce a sua volta una rottura, salutare, in una sinistra abituata a viaggiare nelle ambiguità.
Ma sono fondanti per una simile prospettiva i processi di organizzazione dei settori sociali che vengono penalizzati dallo sviluppo attuale impresso dalla UE. Rimane al centro il mondo del lavoro nelle sue molteplici sfaccettature, dal lavoro stabile a quello precarizzato in mille modi. Le fabbriche del nostro paese nelle loro diverse dimensioni, sebbene non abbiano la funzione politica dei decenni passati, sono un riferimento importante in quanto l’Italia è ancora il secondo paese manifatturiero in Europa. Come sempre più peso assume la forza lavoro nella logistica, nella circolazione e nella commercializzazione delle merci in quanto è questo il settore su cui il capitale nei paesi imperialisti può realizzare i profitti. Come pure la comunicazione ha i suoi “operai fordisti” nei call center messi in produzione spesso in condizioni di schiavismo. Non possiamo nemmeno dimenticare l’esercito industriale di riserva che riguarda i giovani, il sud ed infine gli immigrati i quali svolgono un ruolo produttivo e ideologico che è oggi un vero e proprio campo di battaglia strategico tra due contrastanti interessi di classe e tra due diverse concezioni delle relazioni sociali.
In questo accentuato sfruttamento del lavoro troviamo appieno non solo il lavoro manuale ma anche quello intellettuale, anch’esso oggi sussunto alle necessità di profitto; le qualifiche superiori vengono anch’esse rese subalterne e senza una vera professionalità che viene assunta invece dal sistema produttivo nel suo complesso. La ricerca scientifica ad esempio viene parcellizzata e ridotta agli interessi privati, gestiti dalle grandi società, spesso multinazionali, penalizzando professionalità che invece ci dicono tutti i giorni essere fondamentali per il sistema Italia. In questo tritacarne lavorativo rientra in pieno la questione dei giovani e delle loro prospettive sempre più scarse; non è un caso che venga sottaciuto dai mezzi di comunicazione di massa che l’emigrazione, soprattutto giovanile, nel nostro paese ha raggiunto ormai i cinque milioni di persone.
La sempre maggiore importanza che il fattore “conoscenza” assume a partire dagli anni ’80 porta a un’espansione globale senza precedenti che attraversa cultura, geografia e classi, estendendo il dominio sociale oltre la sfera della produzione. Di fronte a simili sconvolgimenti, tutte le teorie economiche, da quelle classiche, alle neoclassiche e alle keynesiane non si adattano alle dinamiche dello sviluppo nella produzione delle conoscenze.
Ragionando da una prospettiva marxiana, il lavoro è sempre lavoro astratto, determinante del valore della merce, ma sempre indistinto e indifferenziato. Da questo punto di vista la conoscenza è classificabile come lavoro complesso o, nelle parole di Marx, come lavoro semplice potenziato che si include al processo di produzione con un elevato grado di produttività e dunque di competitività.
È vero, c’è il rischio che perfino nella sinistra di classe si cominci a parlare di post-capitalismo, sostanzialmente rinunciando al ruolo di forza rivoluzionaria credendo che la società della conoscenza e della comunicazione deviante – allo stesso modo di ciò che alcuni sostenevano con la società del Welfare State – sia di per sé stessa già una forma di superamento del capitalismo e della logica del profitto. Dobbiamo pertanto ribadire che la terza rivoluzione industriale si mantiene e anzi è interna e necessaria al modo di produzione capitalistico; la società neoliberista della conoscenza è, in poche parole, una società peculiarmente capitalistica che si caratterizza per aver sottomesso l’attività spirituale dell’uomo alla relazione mercantile. La produzione di conoscenza risulta così essere nient’altro che produzione di merce; la conoscenza diventa valore-lavoro al pari dell’applicazione di energia umana fisica. Nei tempi della fallace teorizzazione della “società liquida”, particolarmente importante diventa studiare la reale composizione e articolazione della classe e della massa che deve porsi il ruolo storico di prendere il potere. La domanda è con quali classi e frazioni di classi intendiamo costruire il blocco sociale antagonista. L’epoca della seconda rivoluzione industriale è finita e bisogna rivedere la concezione di produzione; detto ciò, la fase post-fordista non elimina certamente il conflitto capitale-lavoro, ma anzi lo riconfigura in una forma inedita che, pur non modificandone la natura, impone alla forze anticapitaliste internazionali di ripensare le modalità e le forme di intervento nella nuova classe.
Da tempo come Rete dei Comunisti stiamo sviluppando anche un’analisi delle aree metropolitane, che sono destinate sempre più a svolgere una funzione economica importante sia come riserva di caccia delle privatizzazioni e dei tagli sociali a sostegno delle politiche europee di bilancio, sia come “magazzino di forza lavoro” messa a disposizione del capitale privato nazionale e multinazionale. Le aree metropolitane del paese sono sempre più i punti dove quantità e qualità delle contraddizioni, dal lavoro alla questioni dei servizi sociali fino a quelle ambientali, si sommano e spingono verso il conflitto sociale. Questa condizione strutturale ora si sta manifestando anche sul piano politico istituzionale e non è certo un caso che le due aree metropolitane maggiori nel paese e con le maggiori contraddizioni, Roma e Napoli, si stiano orientando per le prossime elezioni comunali a dare rappresentanza a forze, quali De Magistris e M5S, che sono fuori e contro il PD, forza politica che, abbandonata ormai la “veste” democratica, si sta rapidamente evolvendo verso una funzione sempre più reazionaria. Potremmo continuare delineando in modo più specifico i caratteri dei diversi settori sociali che potenzialmente possono esprimere interessi ed ideologie antagoniste, ma questo lavoro sarebbe comunque insufficiente in quanto è necessario indagare statisticamente sulla condizione oggettiva della classe nel suo complesso e dei suoi potenziali alleati ma anche sulla percezionesoggettiva che questa ha di se stessa, della propria condizione collettiva o dei propri interessi specifici, individuali o corporativi.
Questo lavoro non può che essere un lavoro collettivo di inchiesta di classe, che non è un fatto sociologico ma, nella misura in cui si indaga anche sui cambiamenti d’identità ed ideologia, permette di avere una visione più esatta del contesto in cui si deve operare. Per questo la Rete dei Comunisti è oggi disponibile ed intende partecipare alla costruzione di un movimento politico per l’inchiesta che serva da orientamento nel lavoro per tutte quelle forze che vogliono resistere al disarmo e rilanciare il conflitto politico e sociale in modo organizzato nei termini fin qui detti.
Maggio 2016
Rete dei Comunisti
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa