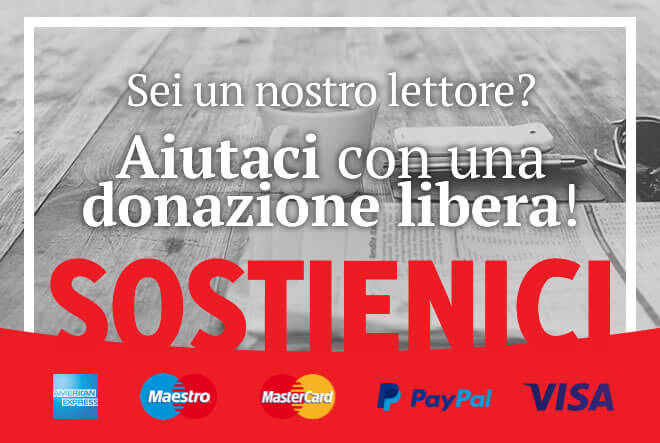Qualche giorno fa ho rivisto “Il portiere di notte”, di Liliana Cavani. Pellicola del 1974 con Dirk Bogarde, Charlotte Rampling, Philippe Leroy, Gabriele Ferzetti, Isa Miranda, Nora Ricci.
Alla fine della proiezione, l’unico pensiero che mi veniva in mente era: che film, santoddio! E di seguito una domanda retorica: come può la cinematografia italiana essere giunta alla mediocrità odierna – anche di autori celebrati di cui è fin troppo facile intuire i nomi sulla cresta dell’onda – quando aveva dato vita a lavori di tale fattura?
La Cavani imbastisce, sulle cadenze tipiche del melodramma di ascendenza viscontiana, una trama assolutamente disturbante, malata, linguisticamente essenziale e drammaturgicamente scarnificata, pur nella miriade di riferimenti simbolici, culturali, religiosi, dispiegati sotto traccia.
Un attacco feroce al moralismo benpensante di stampo reazionario e di certa sinistra grigia e burocratica ai tempi. Oggi liberal ed ottusamente ideologica nel suo mistico furore normalizzante.
Quella sinistra per cui l’Olocausto è poco più di un santino da sventolare per giustificare un genocidio in diretta, sotto i nostri occhi, e che soprattutto non può essere certo confuso con l’erotismo soft e crepuscolare della Cavani.
Quella sinistra un po’ bacchettona – tutta “diritti civili”, pseudo femminismo, asterischi e schwa – per cui il sesso sembra essere declinato e percepito solo nei termini consumistici di un postmoderno plusgodimento da discount.
Non è un caso che questo film, nell’italia del clerico-fascismo e dell’ormai indistinguibile ex catto-comunismo, venga programmato – a differenza del Francesco d’Assisi con Lou Castel o del Francesco con Mickey Rourke – una volta ogni dieci anni.
Come non è un caso che all’epoca la più feroce stroncatura al film la scrisse un sacerdote della nuova sinistra: quel maestro della critica e intellettuale di prestigio che risponde al nome di Goffredo Fofi, allora vicino alla già declinante e confusionaria Lotta Continua.
Il portiere di notte è dunque una pellicola che prende le mosse dalla tragedia della Shoah e dei campi di sterminio, lasciandola poi sullo sfondo e facendone pretesto per una feroce analisi psicologica e sociale delle relazioni umane, all’interno dei contesti e dei codici di classe e di potere.
Su questo primo approccio analitico, la regia viene poi a costruire un’architettura claustrofobica di immagini chiuse in un delirante “scenario a due” dove la dialettica servo-padrone di origine hegeliana – ripresa dal filosofo russo-francese Alexandre Kojève e, nei termini della psicoanalisi strutturalista, da Jacques Lacan (da quest’ultima lettura sembra restare maggiormente affascinata la Cavani) – si tinge delle cupe e violente sfumature della cosiddetta perversione sessuale sadomasochistica.
Il segno filmico non esita mai però in gretti pregiudizi borghesi, anzi asseconda la “follia” dei due protagonisti, ribaltando continuamente il gioco dei ruoli vittima-carnefice nella dimensione, insieme giocosa e tragica, della sessualità.
Un erotismo tanto vitale quanto patologico ma necessario alla sopravvivenza dell’ex ufficiale nazista Maximilian (Bogarde) e della sua giovanissima vittima ebrea Lucia (Rampling), al tempo del trionfo del Terzo Reich e dei campi di sterminio.
Ricordiamo che la vicenda cui assistiamo si svolge invece nell’Austria del 1957, a qualche anno quindi dalla caduta del nazionalsocialismo.
Quelle di Maximilian e Lucia sono due psicologie maledette che decidono di chiudersi ed isolarsi dal resto del mondo, riproducendo un loro psicotico lager d’amore e di reciproca sopraffazione e degradazione morale, fino al vicendevole annientamento.
Una dimensione puerile e ludica del sesso e dell’amore stesso – dietro cui si cela inevitabilmente la tragedia della possessione esclusiva e mortifera – in cui sospendere la naturale evoluzione della Storia e dell’esistenza personale, che non può che condurre all’autodistruzione nel regno di Thanatos. Col sopraggiungere della morte, forse agognata, per mano degli ex camerati in divisa da SS di Maximilian.
Branco di lupi affamati di desiderio che come Atteone hanno strappato con violenza il godimento della carne o anche solo dello sguardo dal corpo virginale della impubere Diana/Lucia all’interno del campo.
Quegli stessi nazisti che stanno ora provando a reintegrarsi, attraverso un paradossale processo di cancellazione della memoria – e quindi della colpa e del suo sentimento – nel rinnovato alveare umano e cittadino postbellico, al quale la borghesia viennese, con i suoi rituali, la sua ipocrisia, le sue reali devianze, i suoi sottaciuti orrori e peccati, fa da contrappunto sociale, rappresentando il tessuto epiteliale più consono alla rigenerazione di una mostruosità nata d’altronde dalle sue stesse viscere. Hitler vedeva infatti i natali a Braunau am Inn, in Austria.
Maximilian e Lucia viceversa, ormai liberi nel reciproco specchiarsi e riconoscersi attraverso il desiderio dell’altro, riescono finalmente a cancellare, nel lirico annientamento di sé stessi e attraverso il sadico e masochistico piacere del dolore, ogni senso di colpa.
La colpa essenzialmente ebraica di Lucia dell’essersi fatta vittima per naturale istinto di sopravvivenza.
La colpa di Maximilian per essere stato il suo implacabile aguzzino al di sopra della Legge ed essersi così sostituito al volto di dio.
In un impeto di sovversione iconoclastica delle consuetudini e finanche dei costumi che regolano il carnevale viennese dell’esistenza quotidiana, i due amanti ormai redenti e purificati dal lavacro del delirio carnale – l’uno in divisa da SS l’altra con la succinta camiciola della vittima che fu – si incamminano mollemente su un ponte della capitale austriaca. Andando incontro ad una morte tragica e grottesca. Teatrale nella sua assurdità kafkiana.
Sparati ed uccisi alle spalle dagli ex camerati. Ipostasi di una nuova società borghese nella quale gli antichi vizi del conformismo e dell’intolleranza verso il diverso e l’altro da sé tornano a fare capolino tra le pieghe di una supposta tranquillità.
Una tranquillità mitteleuropea che dondola tra valzer, opera e teatro, sotto la cui cenere – oggi possiamo dirlo con certezza – si agita il fuoco ordinario dell’eterno nazismo occidentale. La sostanza del quale non muta nel fluire fenomenico, tecnocratico e neoliberale delle sovrastrutture politiche, statuali e culturali.
Si lasciano assassinare dunque Max e Lucia. Nel brusio cittadino di un’alba scolorita sentiamo solo gli spari. La Cavani azzera l’azione storica per condensare il tempo in un atto quasi impersonale.
Benché lo spettatore sappia che ad uccidere è stato un braccio su cui è impressa la stimmate della svastica, quel vuoto soggettivo riempito dal rumore dello sparo allude ad un omicidio collettivo.
Lucia e Max vengono in effetti suicidati dalla spietata indifferenza di una società vendicativa di cui sentono intimamente l’estraneità e che li pone ai margini del proprio incessante progredire storicistico.
Figure arcaiche tolte alla sanguinaria mitologia biblica, Maximilian e Lucia rappresentano l’incarnazione contemporanea dell‘endiadi Erode/Salomè: indissolubilmente legati dal desiderio reciproco di annientamento.
Uno struggimento sensuale in virtù del quale Maximilian, come Erode Antipa, ha decapitato un detenuto del campo perché importunava Lucia, facendole dono della testa.
Il loro è un banchetto carnale misticheggiante che tende all’espiazione. Un melodramma macchiato di sangue, che profuma di sperma e puzzo di merda. Anoressico e bulimico ad un tempo.
Un banchetto crudele e artaudiano nel cuore di una mitteleuropa luterana e infestata di puritanesimo, che prova a risorgere con i suoi fasti borghesi dalle macerie di quel nazifascismo che aveva tenuto a battesimo nel suo ventre. E i cui spettri prova a riassorbire giocando a rimpiattino con la memoria.
Una memoria che Max e Lucia, angeli luciferini della storia, non vogliono invece cancellare, assumendone il fardello che li sprofonda nell’abisso dei sensi e della psiche, e per questo finendo col rappresentare un pericolo per tutti. Nazisti, complici e gente comune adagiata nell’ignavia.
Pellicola di agghiacciante bellezza, questa della Cavani, che recupera la lezione del Dostoevskij di Memorie del sottosuolo; ma anche, e necessariamente direi, del Sade di Justine o le disavventure della virtù.
A questo punto però un’imprescindibile nota critica la meritano gli interpreti. Se per i coprotagonisti la regia della Cavani non affonda il bisturi dell’analisi, sbozzando per lo più caratteri di maniera (evidente in Philippe Leroy) straordinario è il lavoro che fa con Rampling e Bogarde.
La Rampling imprime al suo personaggio quello che verrà a definirsi, con gli anni, come il segno distintivo di una vera e propria autorialità recitativa, capace di far filtrare le emozioni attraverso uno sguardo ipnotico e una fisicità che si modella invariabilmente come creta sulle necessità del personaggio da affrontare.
Dirk Bogarde, dal suo canto, è decisamente mostruoso nel fare emergere un prisma contraddittorio di stati d’animo e di coscienza che fluttuano dalla miseria al coraggio, dalla tenerezza alla cattiveria, dal cinismo alla follia. Maximilian è al contempo subdolo, vile, perverso, innamorato, crudele, tenero, viscido, coraggioso, vittima e carnefice.
Un’interpretazione magistrale di due tra i più importanti attori che hanno fatto la storia del cinema del ‘900 e oltre. Basti pensare alla Rampling di 45 anni e Hannah, due pellicole di pochi anni fa.
Un film quindi da rivedere e stipare nella memoria, esso sì, questo Portiere di notte. Specie in un’epoca in cui la Shoah è divenuta una categoria dello spirito occidentale, vuota di retorica vittimaria.
E soprattutto a giustificazione di qualunque massacro.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa