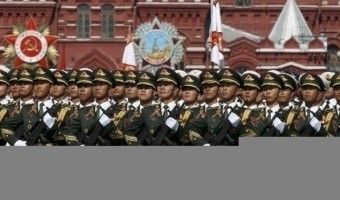Negli stessi giorni ha preso nuovo slancio lo scontro tra il Dalai Lama e il governo cinese sulla procedura di identificazione del reincarnato alla morte dell’attuale leader spirituale. Quest’ultimo aveva infatti dichiarato che «intorno ai 90 anni» consulterà gli studiosi buddisti per valutare se l’istituzione del Dalai Lama dovrà continuare. Se così sarà stabilito, allora bisognerà seguire la tradizione gelupa secondo la quale la reincarnazione può avvenire dopo la morte oppure il Dalai Lama ancora vivo può scegliere il proprio successore. Quale che sarà la soluzione indicata, è però chiaro che «nessun riconoscimento o assenso dovrebbe essere dato a un candidato scelto per fini politici da chiunque altro, inclusa la Repubblica popolare di Cina». Immediata la risposta cinese che ha accusato Tientzin Gyatso di «distorcere e negare la storia» perché «non c’è mai stato un Dalai Lama che abbia identificato il proprio successore».
Il pragmatismo di Pechino non si ferma davanti a niente ed è innegabile che in Tibet il rapporto tra politica e questione religiosa non è aggirabile. Ma il fatto che il problema della religione e della politica delle identità siano ancora oggi nella regione autonoma come la trama con l’ordito, imporrebbe a Pechino una riflessione profonda sui risultati della propria politica nei confronti delle cosiddette «minoranze». Quest’ultima, fondata oggi essenzialmente sullo sviluppo, la crescita e l’assimilazione economica in nome della «modernità», sta sempre più esasperando, invece di attenuare, i conflitti, in una spirale perversa conflitto-repressione-conflitto destinata ad accentuarsi. La strategia scelta da Pechino, aspettare la morte del Dalai Lama per mettere al suo posto un reincarnato di sua scelta, non esprime certo egemonia politica e culturale e appare piuttosto l’opposto del rispetto della tradizione che pretende di difendere. Col risultato che, in una situazione di tensione e crisi come quella tibetana l’antagonismo secolare modernità-società religiosa s’esaspera e il processo di espansione e sviluppo viene visto come «sinizzazione han».
Non dissimile è la situazione delle minoranze che vivono lungo i confini del paese, quelle regioni che l’impero multietnico cinese gestiva con un rapporto flessibile di vassallaggio e che lo stato multinazionale della Rpc fatica oggi ad «armonizzare». In questo senso il riaccendersi e l’esasperarsi delle diverse questioni etniche e culturali, pur profondamente diverse tra loro, appare più un effetto che una causa. Affiora nei reportage di Michelangelo Cocco dal Xinjiang, lo hanno dimostrato nel maggio scorso le sollevazioni dei pastori della Mongolia interna (ai quali si erano unite le proteste degli studenti universitari) dopo che uno di loro era morto , travolto da un autocarro carico di carbone che aveva cercato di bloccare per impedire la devastazione dei suoi pascoli. L’industria mineraria da un decennio ha messo le ali allo sviluppo della provincia (che oggi è il primo produttore di carbone e terre rare del paese), ma ha arricchito solo le sue elites, distrutto l’ambiente ed emarginato le comunità originarie.
La risposta che il governo centrale dà alle rivolte è sempre la stessa, in Tibet come in Xinjiang come in Mongolia: reprimere ma anche fissare obiettivi di aumento del Pil e dei redditi entro un orizzonte che va dal 2015 al 2020. Una ricetta che non funziona perché lo sviluppo economico cinese resta, come riconosce lo stesso capo del governo Wen Jiabao, «insostenibile e squilibrato».
E il problema ormai non riguarda più solo le minoranze etniche ai confini ma anche il più vasto corpo della società cinese, come dicono le proteste e gli scontri che avvengono in tutto il paese. Particolare rilievo ha assunto negli ultimi tempi quello che per i cinesi è un forte nodo materiale ma anche simbolico: la terra e lo sfruttamento dei suoi diritti, a cui si accompagna il dramma degli espropri illegali. Gli ultimi fatti in ordine di tempo hanno avuto per protagonisti gli abitanti del villaggio di Wukan, parte della città di Lufeng, al confine con Hong Kong nel Guangdong, che, dopo aver stretto d’assedio la sede del partito, si sono scontrati furiosamente per due giorni con la polizia per impedire l’esproprio di 40 ettari di terre appartenenti al villaggio e ceduti dal governo locale a una società immobiliare. La protesta di Wukan ha avuto la solidarietà di tutti i villaggi intorno, colpiti dallo stesso problema, che oggi costituisce la miccia di più rapida accensione delle proteste. Convergono nel nodo la questione dell’urbanizzazione titanica del paese (entro il 2025 è prevista la migrazione di altre 350 milioni di persone dalle campagne alle città) e il perverso intreccio soldi-potere tra governi locali e speculatori immobiliari. I primi traggono dalla valorizzazione dei terreni gli introiti più forti (ma anche più illeciti), i secondi speculano spudoratamente (nell’ultima lista dei miliardari cinesi sono la categoria più ricca e più presente). I tentativi del governo centrale di disinnescare la bomba imponendo maggiori regole agli espropri si scontra con gli interessi dei governi locali in un conflitto centro-periferia che dilaga anche su altri fronti e che ormai costituisce per Pechino uno delle questioni politiche più urgenti da affrontare. Insieme alla sostenibilità del proprio modello politico davanti alle contraddizioni crescenti e all’attivismo di una società differenziata dagli interessi sempre più divergenti.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa