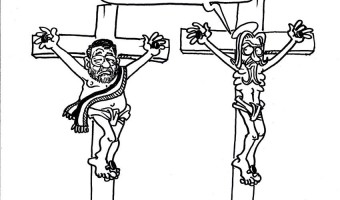Il primo e più evidente, in piena campagna elettorale, è il rapporto tra le banche e “la politica”; in questo caso il Pd. Ma è persino il meno problematico, perché basta poco per recidere radicalmente determinati legami a livello operativo, pur mantenendo una relazione privilegiata sufficiente a favorire alcune scelte creditizie. Sarebbe divertente (o molto poco), per esempio, buttare un occhio dentro Banca Mediolanum, la creatura di Ennio Doris e Silvio Berlusconi, la “banca disegnata intorno a te” che non possiede neppure uno sportello (agisce mediante la rete degli uffici postali), ma è quotata in borsa. È comprensibile che giornalisti e politici vecchi e nuovi (ultimo Mario Monti, con una faccia di teflon degna di miglior causa, questa mattina) calchino l’enfasi soprattutto sull’aspetto “politico”; ma è in fondo il meno drammatico.
C’è poi un livello istituzionale, perché la sortita di Vittorio Grilli – ministro dell’economia in questo governo e vice di Tremonti nel precedente – sul fatto (ovvio) che è Bankitalia a dover effettuare i controlli sulle singole banche rischiava di innescare una spirale pericolosa. La nota congiunta tra Tesoro e via Nazionale ha tamponato la falla, ma le tensioni restano sottotraccia. La sorveglianza della Banca d’Italia ha buon gioco nel ricordare che è stata la propria azione ad evidenziare incongruenze pesanti nella gestione patrimoniale della banca senese, sostenendo – in specifico sulle operazioni incriminate. “Alexandria”, “Santorini” e “Nota Italia” – di essere stata “ingannata” dagli uomini di Rocca Salimbeni, che avrebbero quindi nascosto documenti che era invece obbligatorio mostrare agli ispettori. Circostanza che trasforma in “penali” alcune responsabilità dei vertici della gestione Mussari. Se dovesse davvero saltare l’intesa istituzionale tra Tesoro e Banca centrale si aprirebbero scenari paurosi nel governo del sistema bancario d questo paese.
Ma il problema più grave è “genetico”: il virus dei prodotti derivati contagia tutto il sistema bancario globale (o soprattutto la sua componente principale, euro-statunitense) e risulta a questo punto ridicola la tesi che dipingeva le banche italiane come “meno esposte” della media europea. Può anche essere che sia “meno”, ma quel poco è comunque troppo. E illumina un meccanismo continuamente sul filo dell’esplosione.
I derivati finanziari nella “pancia” delle banche italiane: 218 miliardi
Gli strumenti finanziari “derivati”, nonostante abbiano avuto un ruolo centrale nell’esplosione della crisi del 2007-2009, hanno conosciuto un’espansione ulteriore dopo il momento più acuto del credit crunch successivo al fallimento di Lehmann Brothers. Come ricstruisce oggi Livini su Repubblica, nel 2009 le banche italiane avevano in cassaforte 159 miliardi di carta straccia “derivata”; oggi sono 218. Difficile trovare una logica se non usando la metafora della droga: per tamponare il dolore delle perdite subite, o addirittura per “proteggersi” da nuove perdite, tutte le banche (e quelle italiane risultano acora tra le più “prudenti”) si sono ingozzate di altri derivati. Per abbellire i conti, come nel caso MontePaschi, che ha concluso una complicatissima operazione con la giapponese Nomura al solo scopo di far scomparire circa 500 milioni di perdite dai bilanci attribuendoli, per l’appunto, ai nipponici. I quali, naturalmente, non hanno certo fatto questo favore a titolo gratuito.
Senza dilungarsi troppo, cos’è un “prodotto finanziario derivato”? In sintesi, si chiama così ogni contratto o titolo il cui prezzo sia basato sul valore di mercato di uno o più beni (quali, ad esempio, azioni, indici finanziari, valute, tassi d’interesse). In linea di principio, dunque, il prezzo varia col variare del valore del “sottostante” al titolo stesso. In teoria, perché la stessa definizione di “derivato” consente la creazione di altri prodotti che hanno a loro volta come “sottostante” dei prodotti derivati; e così via all’infinito. Di fatto, dunque, i “derivati” equivalgono all’emissione di moneta, fatta però da enti privati (banche, istituti, fondi, “società veicolo” di dubbia consistenza e incerto indirizzo, ecc). Moneta che vale qualcosa finché viene scambiata e accettata, ma che – per molte e buonissime ragioni – può ad un certo punto esser rifiutata, restituita pretendendo un controvalore più concreto, ecc. A quel punto, quasi sempre diventa carta straccia.
Che questa roba possa esser considerata addirittura una “protezione” dalle perdite – caso tipico: i credit default swap, certificati di assicurazione dal rischio fallimento di una terza parte – è un controsenso che però possiede vita reale finché esiste “fiducia” tra gli operatori che si scambiano questa roba.
Vi sembra folle? Lo è. Ma di questa sostanza è fatta buona parte della finanza globale.
Il botto MontePaschi rappresenta un’interruzione seria nel circuito della “fiducia” reciproca, apre domande inquietanti sulla solidità di tutti gli istituti bancari, non solo italiani. Tutti fanno le stesse operazioni, e ognuno degli attori principali lo sa. Ma finché la circolazione non si interrompe si può continuare a praticare l’identico sport. Per questo, dunque, il caso di Rocca Salimbeni (la sede centrale senese della banca “incriminata”) rischia di diventare – nel suo piccolo – una Lehmann Brothers italiana, con effetti quasi-continentali. In fondo, per dimensioni, è pur sempre la terza banca di questo paese.
Alcuni articoli illustrativi sulla stampa di oggi:
La moral suasion di Via Nazionale che «dimissionò» Mussari e Vigni
di Alessandro Plateroti
Il ruolo istituzionale, e la presenza di inchieste in corso, impone ai vertici della vigilanza il massimo riserbo: se chiamati, è in Parlamento che riferiranno del proprio operato nel caso-Mps.
Chi è bene informato, tuttavia, riferisce che lungi dall’essere rimasta passiva, la Banca d’Italia non solo aveva rilevato per prima già dalle ispezioni del 2011 che alcuni conti non tornavano nel bilancio della banca senese, ma anche che era stata la stessa Via Nazionale ad accorgersi anche prima della magistratura di alcuni aspetti poco chiari sulla condotta del management dopo l’acquisizione dell’AntonVeneta.
Non solo. Dietro le dimissioni del direttore generale Antonio Vigni nel gennaio del 2012, e poi pochi mesi dopo del presidente Giuseppe Mussari, ci fu proprio la «moral suasion» di Via Nazionale, che chiese esplicitamente alla Fondazione senese, azionista di maggioranza della banca, di operare una «discontinuità immediata del management»: in pratica, di costringere alle dimissioni i due dirigenti che avevano pensato, condotto ed effettuato sia l’acquisizione di AntonVeneta sia l’acquisto di pericolosi derivati strutturati che avrebbero potuto mettere a rischio la stabilità dell’istituto senese. Una procedura, questa, che poco tempo prima era già stata adottata da Bankitalia nei confronti del top management della Banca Popolare di Milano, che a giudizio dell’authority non aveva operato secondo il principio della sana e prudente gestione del credito.
Questa, in estrema sintesi, la ricostruzione dei fatti che hanno preceduto sia le dimissioni di Vigni e Mussari, sia le inchieste della magistratura senese e di Milano sul comportamento della banca dopo l’acquisto di AntonVeneta. Banca d’Italia, insomma, non solo non è rimasta affatto passiva davanti alle ombre che circondavano l’operato dei manager di Siena, ma ha usato tutti i poteri a propria disposizione per fare chiarezza sui sospetti e sui bilanci. Sospetti che, tra l’altro, erano già emersi all’inizio del 2011 quando gli ispettori dell’Eba (l’autorità bancaria europea) si recarono in Italia per effettuare gli stress test sulla solidità delle banche. Dalle ispezioni a Siena, infatti, gli uomini dell’Eba non uscirono affatto convinti sulla capacità della banca di stare sul mercato: l’authority europea rilevò in particolare una pericolosa mancanza di liquidità e una palese debolezza patrimoniale, investendo del caso la Banca d’Italia. A Siena fu ordinato subito di rafforzare il capitale e soprattutto di chiedere all’allora ministro del Tesoro Giulio Tremonti un finanziamento di due miliardi di euro attraverso i Tremonti-Bond. Ed è proprio a questo punto che scatta la nuova ispezione di Bankitalia a Siena.
Gli uomini di Visco vanno a Rocca Salimbeni, aprono cassetti e computer, esaminano file e documenti, interrogano dirigenti e funzionari e arrivano a una clamorosa conclusione: i problemi vanno ben oltre l’erosione di liquidità. In particolare, Banca d’Italia rileva non solo che i due miliardi in Tremonti bond non bastano, ma anche che la banca si trovava in una posizione critica quanto a sostenibilità patrimoniale, e che alcune operazioni erano state effettuate dal management in modo poco chiaro anche sotto il profilo penale. Di qui la decisione, nella seconda metà del 2011, di chiedere alla Fondazione Mps la «discontinuità del management». È bene precisare anche un’altra cosa: né dalle ispezioni dell’Eba né da quelle della Banca d’Italia erano emerse le pericolose posizioni in titoli derivati strutturati prese da Mussari e Vigni. La banca, insomma, si sarebbe guardate bene dal comunicarle agli ispettori. Ma pur non sapendo dei derivati, a cominciare da quelli di Nomura, Visco ha ritenuto di avere abbastanza elementi per muovere l’attacco ai vertici di Mps: a fine anno viene chiesta la rimozione di Vigni, poi in aprile quella di Mussari.
Trascorrono pochi mesi e scatta il blitz dei magistrati: il 9 maggio (e poi nuovamente il 12 luglio del 2012), i pm di Siena mandano 150 finanzieri nella sede della banca e nelle abitazioni di Mussari e Vigni per acquisire documenti. Il caso-Montepaschi, da finanziario, diventa penale. Intanto, però, le ispezioni vanno avanti. E con queste, emerge la necessità di chiedere anche al Governo Monti un aiuto finanziario di 1,5 miliardi di euro. Davanti a questa situazione, anche a Siena sale la tensione. E grazie all’aiuto del nuovo management, formato da Fabrizio Viola e da Alessandro Profumo, si arriva a una nuova svolta: le carte segrete sui derivati di Nomura e altri strumenti finanziari emergono dalle casseforti, la situazione patrimoniale e di liquidità torna nuovamente a rischio e la banca, d’intesa con Via Nazionale, chiede di portare a 1,9 miliardi (400 in più della prima valutazione) il contributo pubblico nei cosiddetti Monti bond.
Come concludere? Che l’operazione AntonVeneta e i 9,5 miliardi di euro sborsati dal Monte sono alla radice della crisi della banca. Un’operazione, è bene ricordarlo, che per quanto onerosa non destava nel 2008 particolari problemi alla vigilanza: allora, il Monte era una delle banche meglio patrimonializzate d’Italia. I problemi, come abbiamo appreso ora, sono cominciati dopo.
da Il Sole 24 Ore
*****
Quando Mps speculava sull’Italia
Morya Longo
«I BoT italiani non sono come i titoli greci: deve essere chiaro, altrimenti facciamo il gioco della speculazione». Quando nel 2011 l’allora presidente dell’Abi Giuseppe Mussari pronunciava queste parole, e giustamente incitava gli italiani a «non fare il gioco» degli speculatori internazionali, forse pensava ai suoi trascorsi senesi. Perché la speculazione sull’Italia la faceva da tempo anche il Monte dei Paschi. A favore dell’Italia, certo. Come tutte le banche italiane, ben inteso. Ma pur sempre di speculazione si trattava. È questo infatti il succo della terza operazione finanziaria made in Siena, dopo Alexandria e Santorini, “chiacchierata” di questi giorni: Nota Italia. Una speculazione che, come le altre (si veda il Sole 24 Ore di ieri), alla fine ha lasciato solo ferite a Rocca Salimbeni. Ecco la sua storia.
Nota stonata
Nota Italia è una complessa operazione finanziaria, realizzata nel 2006 da Mps con JP Morgan, che puntava a procurare guadagni alla banca senese vendendo – in maniera sintetica – credit default swap (Cds) trentennali sull’Italia. I Cds sono strumenti derivati che servono per assicurarsi contro il rischio di fallimento di qualunque azienda o Stato, in questo caso della Repubblica italiana. Vendere Cds, dunque, significa vendere una polizza che produrrebbe un risarcimento a chi la compra nel caso in cui l’Italia dovesse fallire. A quei tempi, ovviamente, nessuno pensava affatto che la Penisola potesse andare gambe all’aria: infatti i Cds decennali quotavano nel 2006 tra i 19 e i 26 punti base.
Significa che per assicurare un milione di euro di BTp, bastava pagare 1.900-2.600 euro. Pochissimo. Il “premio” assicurativo incassato da chi vendeva a quei tempi Cds sull’Italia era dunque bassissimo. Ma Mps (in realtà tante banche italiane hanno fatto operazioni simili) si accontentava: perché a quei tempi tutti gli strumenti finanziari rendevano poco e una manciata di punti base era tutto grasso che colava. Probabilmente per questo motivo la banca senese decide di fare l’operazione.
C’era solo un piccolo problema. Realizzarla in maniera lineare, vendendo Cds a JP Morgan, era impossibile: anche a quei tempi, infatti, nessuna banca d’affari internazionale avrebbe mai comprato un Cds direttamente da una banca italiana. Perché nella pur remota ipotesi che l’Italia fosse fallita, anche le banche italiane sarebbero fallite, per cui la loro capacità di rimborsare la polizza sarebbe stata teoricamente nulla. Nasce per questo Nota Italia: una complessa struttura finanziaria, che permette di realizzare sinteticamente ciò che nella realtà non era possibile.
Nota Italia è un titolo strutturato emesso da una società-veicolo irlandese, Corsair Finance costruita da JP Morgan, e comprato da Mps. L’intera operazione aveva dei titoli iper-sicuri sottostanti (con rating Tripla A), in modo da garantire a JP Morgan che anche in caso del default combinato di Italia e Mps, il risarcimento derivante dalla polizza sarebbe arrivato comunque. La struttura era dunque complessa, ma l’obiettivo era semplice: fare in modo che JP Morgan comprasse sinteticamente i Cds sull’Italia (cioè le polizze sul default della Repubblica) e che Mps incassasse i “premi” assicurativi.
La musica cambia
Il problema è che Mps, proprio a causa della struttura complessa, incassava ben poco da questa operazione. Avrebbe guadagnato di più comprando un banale BTp. Ma il vero problema è un altro: che quando inizia la crisi finanziaria, e il Cds dell’Italia s’impenna (fino a toccare 566 punti base a novembre 2011), Mps inizia a perdere soldi. La fine di questa operazione è nota, ed è scritta nel comunicato stampa di Mps di due giorni fa: «La banca comunica di aver recentemente ristrutturato tale investimento mediante l’eliminazione della sua componente derivativa legata al rischio sovrano Italia e che, a seguito della chiusura del derivato, la rimanente parte dell’investimento iniziale rimane correttamente classificata tra i Loans and Receivables».
Tutto finito, dunque. Restano i dolori. E tanti interrogativi. Perché creare tutto questo castello di operazioni finanziarie, che ovviamente lasciava un po’ di utili a JP Morgan? Nel suo track record Mps non si è fatta mancare nulla delle più aggressive strutture finanziarie: dai Cdo al quadrato alle credit linked note, dai collar ai Cds. Alcune speculazioni sono andate bene, altre (come Santorini o Alexandria) male. Malissimo. Ma anche se si fossero concluse con lauti guadagni, facendo tutti felici, resterebbe una domanda: ma cosa c’entra questo con l’erogazione del credito? Con l’attività che una banca attenta al territorio dovrebbe svolgere?
COME FUNZIONANO «ALEXANDRIA» E «SANTORINI»
Le origini del problema
Le perdite di Mps derivano da due derivati, chiamati Santorini e Alexandria. Nel 2009 entrambe le operazioni iniziano a creare ingenti perdite. Così Mps compra BTp trentennali da Deutsche Bank e Nomura per “spostare” le minusvalenze su contratti pronti/termine creati sugli stessi BTp.
Il passo falso
Il vero errore di Mps arriva nel 2009-10. Su gran parte del portafoglio di titoli di Stato, il gruppo stipula derivati di tasso. Mps trasforma così quasi tutti i suoi BTp a tasso fisso in titoli a tasso variabile. È un “bagno di sangue”: Mps ha in mano titoli di Stato italiani ma non incassa le cedole.
I contratti
Con la creazione di pronti/termine sui BTp trentennali, Mps sposta contabilmente la perdita su titoli più “consoni” con l’attività di una banca. Ma soprattutto con questa mossa riesce a non mostrare la perdita in conto economico, perchè ascrivibile a contratti di pronti/termine.
30 anni
La durata dei BTp in portafoglio
Mps aveva in portafoglio BTp “lunghi” su cui aveva costruito pronti/termine
da Il Sole 24 Ore
*****
Il Monte e quel labirinto dello spalma-perdite
di Morya Longo e Fabio Pavesi
Lo scandalo derivati scuote Mps. La banca senese è stata travolta in queste ore in Borsa per l’emergere delle perdite sulle operazioni finanziarie Alexandria e Santorini, perdite che sono state “nascoste” nei bilanci con altre operazioni finanziarie. Ecco nel dettaglio come funzionava il labirino dello spalma-perdite.
Quando il Monte dei Paschi decise di acquistarli da Dresdner Bank, nel dicembre del 2005, i bond «Alexandria» avevano tutte le credenziali per sembrare degli ottimi investimenti. Avevano un rating ultra-sicuro di «Tripla A». Erano garantiti da mutui e da obbligazioni aziendali. Pagavano buoni interessi. Peccato che questi bond «Alexandria» fossero dei complessi e rischiosi Cdo (acronimo di collateralized debt obligations): obbligazioni “salsiccia”, create da Dresdner impacchettando al loro interno un po’ di tutto.
Titoli «tossici» che pochi anni dopo sono stati travolti, come tutti i Cdo del mondo, dalla crisi finanziaria. Inizia così l’Odissea dei derivati della banca senese: per coprire le perdite di questo investimento sbagliato, l’istituto ha infatti realizzato altre operazioni finanziarie ad alta tensione. Finendo dalla proverbiale padella alla brace. E reiterando un errore già commesso con altre operazioni finanziarie. Ecco come la finanza può far male anche nella banca più antica del mondo.
Chiodo scaccia chiodo
La vicenda inizia il 15 dicembre del 2005, quando la società veicolo Alexandria Capital emette le obbligazioni per 400 milioni di euro. Mps le acquista per intero. Nel 2009, dopo il crack di Lehman Brothers, questi titoli «tossici» perdono più del 50% del valore: dei 400 milioni investiti, Mps ne perde 220. Così l’istituto senese decide di realizzare un’operazione con Nomura per “tamponare” i danni. Anche quelli d’immagine. Il suo obiettivo è duplice. Da un lato Mps vuole spostare i 220 milioni di perdite dai poco presentabili Cdo Alexandria a un portafoglio di investimenti più adeguati con l’attività di una banca: cioè BTp trentennali. Dall’altro Mps intende spalmare quei 220 milioni di perdite in un’arco di tempo più lungo: 30 anni, appunto.
È così che nasce un’operazione “a latere” di Alexandria, realizzata con Nomura. Funziona così. Mps vende alla banca giapponese i bond Alexandria e in cambio compra 3 miliardi di BTp trentennali «in asset swap» (cioè trasformati da tasso fisso a variabile). Dato che Mps non ha i soldi per fare l’operazione, se li fa prestare dalla stessa Nomura attraverso un pronti contro termine realizzato sugli stessi BTp. Morale: la perdita di Alexandria sparisce e Mps la “spalma” su un arco trentennale di un portafoglio di BTp. Ironia della sorte: dal 2009 i Cdo hanno realizzato grandi rialzi (Nomura probabilmente ci ha fatto un affare comprando Alexandria), mentre Mps si è spostata sui BTp trentennali poco prima della crisi dell’Italia. Insomma: Mps è passata da un bagno di sangue a un altro. Da un cavallo sconfitto a un cavallo perdente. Oggi gli advisor PwC e Eidos Partners sono al lavoro anche per capire a quanto ammontino le perdite effettive di questa operazione.
I dolori di Santorini
Il problema è che Alexandria non è un banale incidente di percorso. Mps ha infatti realizzato altre operazioni speculative negli anni passati, tutte diverse ma spesso con la medesima finalità: cercare di coprire perdite finanziarie con operazioni finanziarie sempre più complesse e speculative. Il caso di Santorini è uno di questi. La vicenda inizia nel 2002, quando Mps realizza un’operazione di «equity collar» con Deutsche Bank sulle azioni Intesa Sanpaolo: con questa operazione Mps intende coprirsi dal rischio Intesa, perché il gruppo possedeva circa il 3% delle azioni della banca milanese.
Il problema nasce qualche anno dopo, quando anche l’«equity collar» inizia ad evidenziare forti perdite. Esattamente come è accaduto al Cdo Alexandria. Così Mps, per coprire questo buco, imbastisce l’operazione Santorini: con Deutsche Bank realizza un «Trs» (cioè una scommessa sull’andamento dei tassi europei e americani). La sua finalità sembra proprio essere quella di guadagnare altrove, per compensare le perdite dell’«equity collar». Insomma: di scacciare con la finanza i dolori della finanza. Piccolo effetto “collaterale”: Santorini prima di essere liquidato era in perdita per 87 milioni nel 2008 e per 61 milioni nel 2009.
Scommesse rischiose
Il problema è che tutte queste operazioni hanno lasciato le ferite nei bilanci. È questo il lascito assai ingombrante del duo Mussari-Vigni, l’ex presidente e direttore generale della banca senese. Non bisogna dimenticare l’operazione AntonVeneta, pagata 10 miliardi nel 2008 e che ha lasciato tracce incancellabili nei conti. La banca di Siena ha cumulato, solo tra il 2011 e i primi 9 mesi del 2012, 6,2 miliardi di perdite. Una cifra che vale oltre la metà del patrimonio netto della banca. E così Mps è l’unico istituto, tra i big italiani, che si ritrova a chiedere aiuto allo Stato. Servivano 3,4 miliardi, oggi saliti a 3,9 miliardi per la probabile pulizia definitiva dai bilanci dalle operazioni azzardate sui derivati. Con un costo salato, dato che si pagheranno tassi di interesse ben sopra quelli di mercato.
Ma più si guarda Mps più ci si accorge di essere in presenza di una banca che della finanza fa il suo mestiere. La banca si è riempita di titoli di Stato italiani, tra l’altro a lunga scadenza e quindi diventati rischiosi in questi anni di crisi, per 26 miliardi: un valore che è due volte e mezza il capitale della banca. Nei momenti cupi della crisi quel portafoglio aveva perdite potenziali per 3 miliardi di euro. Ora la situazione si è ribaltata (per fortuna della banca e dei suoi azionisti), ma rimangono scelte col senno del poi azzardate per la stabilità dell’istituto. Basti pensare che tuttora la banca di Siena ha un portafoglio tra titoli e derivati di 37 miliardi. Enorme. Vale da solo più di un quarto dell’attività di crediti alla clientela, cioè il core business.
Sembra proprio che Mps cercasse di guadagnare aumentando i volumi sulle attività più speculative, quelle finanziarie. Operazioni che potevano andare bene ma anche molto male, come Alexandria, Santorini (e altri derivati) insegnano. Il paradosso tuttavia è che quello di spingersi sulla finanza sembra anche il frutto della “poco fortunata” gestione del credito: Mps è infatti, tra i big italiani, la banca con il più alto livello di sofferenze. I crediti a rischio netti sono ben 17 miliardi, il 12% dell’intero monte prestiti della banca. Come se fosse stato concesso credito negli anni d’oro con una certa “allegria”. E allora, forse, quel giocare con la finanza serviva a compensare i guai che venivano dal credito. La partita si è persa su ambedue i fronti.
da Il Sole 24 Ore
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa