Alla fine della scorsa settimana i Ministeri dell’Economia e del Lavoro hanno emanato il decreto che aggiorna ogni due anni, sulla base dell’andamento dell’indice della speranza di vita, la soglia dell’età pensionabile. Quest’ultimo parametro è particolarmente rilevante perché stabilisce a quale età scatta la pensione di vecchiaia (cioè l’età anagrafica che permette al lavoratore di andare in pensione, indipendentemente dagli anni lavorati). Il verdetto è che per il periodo 2021-2022 non vi sarà alcun aumento dell’età pensionabile, dal momento che nel biennio 2017-18 non si è registrata alcuna crescita della vita media attesa nella popolazione italiana. I lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia, ad oggi fissata a 67 anni, non dovranno attendere oltre quella soglia, almeno fino al 2022. La maniera in cui la notizia è stata annunciata dai media, una buona e rassicurante novella, riflette rigorosamente quel perverso meccanismo automatico sancito dalla Legge Tremonti-Sacconi del 2010, per cui una maggiore speranza di vita deve necessariamente tradursi in un aumento dell’età pensionabile, pena la presunta insostenibilità finanziaria (sempre dimostrata con numeri truffaldini e punti di vista parziali) del sistema previdenziale italiano. Un vicolo cieco da cui non si scappa, al punto da far sembrare augurabile la non certo positiva notizia del mancato aumento della speranza di vita. Per non andare in pensione sempre più tardi possiamo solo sperare che non si allunghi la vita media: una vera aberrazione concettuale!
Vediamo di andare al fondo di questo perverso meccanismo, reso automatico a partire dal 2010. Per farlo, entriamo meglio nel merito del funzionamento di un sistema pensionistico di tipo contributivo, quello ad oggi vigente in Italia.
Il sistema pensionistico contributivo determina la pensione sulla base dell’entità dei contributi versati (il cosiddetto ‘montante contributivo’), e poi rivalutati in base al migliore o peggiore andamento dell’economia nel corso degli anni, che poi vengono trasformati, al momento del pensionamento, in rendita pensionistica mensile sulla base del numero di anni di vita mediamente attesi a partire da quel momento. Specifici coefficienti detti “di trasformazione”, puntualmente rivisti sulla base della variabile ‘speranza di vita’, vengono usati per spalmare il montante contributivo accumulato sugli anni che teoricamente resterebbero, in media, da vivere. In questo modo, più l’età di pensionamento è anticipata più si riduce la pensione attesa, poiché aumenta il numero di anni su cui distribuire il montante contributivo. In un simile sistema pertanto vige un meccanismo per cui un eventuale anticipo di pensionamento è automaticamente penalizzato da una pensione più bassa, mentre un accesso più tardivo è compensato da una pensione più alta. Ciò avviene sostanzialmente per due ragioni: un anno in più di lavoro fa aumentare il coefficiente di trasformazione perché, come spiegato, il montante rivalutato va distribuito su meno anni; inoltre, più banalmente, fa aumentare i contributi e, quindi, il montante stesso.
In linea teorica, in un simile sistema non vi sarebbe alcun motivo per immaginare limiti minimi di età di accesso alla pensione. Per assurdo, potrebbe essere concesso un accesso alla pensione anche a 50 anni (o meno) visto e considerato che la quantità di risorse da versare sarebbe esigua e commisurata agli anni di lavoro e contributi versati, tra l’altro, principalmente dagli stessi lavoratori. Ammesso e non concesso che possa essere considerato ragionevole avere dei parametri minimi di accesso di tipo anagrafico (raggiungimento di una soglia di età) o di anni di contribuzione (accumulazione di anni di lavoro), quello che appare del tutto ingiustificato e paradossale – puro frutto di una logica di austerità finanziaria orientata ad abbattere la spesa pubblica corrente e futura – è l’idea di un costante inevitabile innalzamento dell’età pensionabile in base alla crescita della vita media attesa.
Fino al 2010, il continuo aumento dell’età pensionabile era stabilito discrezionalmente dalle numerose riforme pensionistiche succedutesi sino a quel momento, dalla Riforma Amato (1992) fino alla Riforma Maroni (2004), con tutto il conseguente dibattito politico e la discussione pubblica che ne derivava. Dal 2010, come conseguenza della Legge Tremonti-Sacconi, la crescita dell’età pensionabile diventa invece un automatismo che il Parlamento si limita a ratificare. Un provvedimento condito dal paradosso per cui eventuali diminuzioni della vita media attesa (del tutto plausibili in un’epoca di crisi economica così profonda) non avrebbero invece alcun effetto sull’età pensionabile.
Il meccanismo punitivo verrà poi anticipato dalla Riforma Fornero del 2011-2012, che prevede che l’adeguamento avvenga tramite decreto direttoriale, senza neanche bisogno di una ratifica parlamentare, diventando così un mero artificio contabile. Non si pone così, neanche astrattamente, la possibilità che un anno in più di vita media conquistato possa trasformarsi in un anno (o anche solo sei mesi) in più di riposo. Si dà per scontato che la quota percentuale della vita lavorativa sugli anni vissuti non debba mai cambiare e che ogni progresso materiale debba tradursi in un aumento del tempo assoluto di lavoro svolto. Se ciò è già di per sé del tutto discutibile a parità di condizioni tecniche di produzione e produttività del lavoro, diventa un assioma perverso in condizioni di più o meno intenso progresso tecnico. La straordinaria crescita della produttività del lavoro che ha accompagnato lo sviluppo economico degli ultimi 60-70 anni – che permette di produrre nello stesso lasso di tempo una quantità infinitamente maggiore di beni e servizi – non ha coinciso, se non marginalmente, con una diminuzione del tempo dedicato al lavoro, sia come orario lavorativo medio nel corso della vita attiva, sia come percentuale di vita dedicata al lavoro a fronte di un allungamento della durata della vita.
La persistenza di orari di lavoro defatiganti – che in molti settori coprono di fatto intere giornate, superando le 10-12 ore con l’uso disinvolto di straordinari spesso nemmeno economicamente riconosciuti – e le riforme pensionistiche restrittive, che hanno portato sempre più in là l’età pensionabile di vecchiaia e di anzianità contributiva, hanno finito per svuotare il progresso tecnico degli ultimi decenni di ogni risvolto sociale effettivo sui tempi liberi dell’esistenza: su quella parte cruciale della vita di una persona da dedicare alla sfera affettiva, sociale, culturale, artistica, spirituale, ovvero quella parte di esistenza sottratta ai ritmi frenetici di un lavoro che spesso non rispetta nemmeno quella promessa di realizzazione professionale cui dovrebbe astrattamente ambire.
A ciò va poi aggiunto che un allungamento della vita media attesa non coincide necessariamente con più anni di vita in salute. Spesso infatti, anche grazie ai progressi nella cura e nella cronicizzazione di molte malattie, sono gli anni di vita in malattia o in condizioni di debolezza e scarsa efficienza fisica o psichica a prolungarsi. Insomma, l’aspettativa di vita potrebbe anche allungarsi, grazie al progresso tecnico, ma ciò non significa che ciò sia sempre un riflesso di una buona salute: una grave malattia, che oggi determina la morte di un individuo in breve tempo, un domani potrebbe rappresentare semplicemente un allungamento della condizione terminale. O, più banalmente, superata una certa età non si è più in grado di godere appieno della vita rimasta, soprattutto se aumentano gli anni in cui dobbiamo lavorare! Un elemento in più che dovrebbe mostrare le gravi conseguenze di un’impostazione scellerata che vorrebbe che nei prossimi decenni lavorassimo tutti fino a 70 o, chissà, 75 o 80 anni.
Del resto, al di là delle convinzioni ideologiche e dei falsi spauracchi sui conti in rosso dell’istituto previdenziale, il vero spirito che ha animato la graduale destrutturazione del sistema previdenziale pubblico e le sue riforme iper-restrittive è da molti anni sempre lo stesso: il risparmio di risorse. Nell’ottica dell’austerità, resa cogente dai trattati europei, occorre saccheggiare qua e là le risorse che andrebbero destinate a finalità sociali. Il risparmio pensionistico è diventato una vera e propria ossessione, trattandosi di un monte di risorse a cui attingere (alla faccia di pensionati e pensionandi) di enorme entità. Risorse che invece di essere dedicate al benessere di chi ha lavorato per una vita intera sono invece offerte come contributo alla famelica macchina dell’austerità, che ogni anno divora diritti sociali e tempi di vita con il solo ed unico fine di proseguire sulla strada della mastodontica redistribuzione del reddito dal basso verso l’alto.
In una prospettiva e in un’ottica redistributiva opposte, il ripensamento radicale del rapporto tra tempi di vita e tempi di lavoro, assieme ad un ripensamento della qualità, del senso e del riconoscimento economico e sociale del lavoro stesso, non possono che essere i fondamenti di una società più solidale, più giusta e più umana.
Una società in cui un aumento della speranza di vita non debba essere accolto con un brivido dai lavoratori alle soglie della pensione, ma soltanto come un’ottima notizia per tutti.
* Coniare Rivolta è un collettivo di economisti – https://coniarerivolta.org/
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa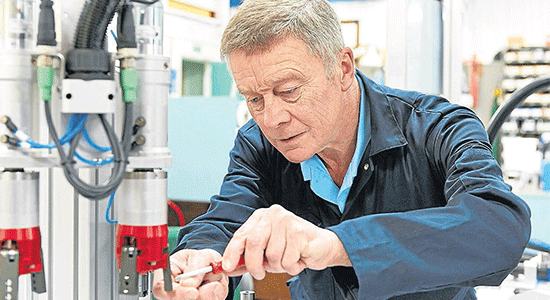





Carla
Chapeau! Forse la gente teme anche la scadenza del periodo di comporto, essendo magari 50enne invalida…perché né contributi né welfare…la salverebbero dalla fame! Perché vogliono gente malata al lavoro? Per poterla licenziare presto.