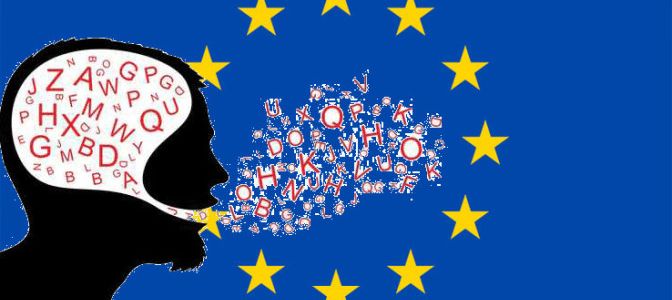Nel 1941 Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, confinati dal fascismo nell’isola di Ventotene, scrivono un documento per la promozione dell’unità europea che verrà poi pubblicato da Eugenio Colorni e viene oggi considerato uno dei testi fondanti dell’Unione Europea. A dire il vero, in ambito liberal-socialista spesso si è soliti dire che l’Europa abbia disatteso le idealità di questo scritto e un procedimento retorico di questo genere viene paradossalmente usato anche in uno dei tanti articoli polemici del “filosofo” rossobruno Diego Fusaro.
Tale manifesto di Ventotene era stato preceduto dal progetto di Richard Nikolaus di Coudenhove-Kalergi che dopo la prima guerra mondiale aveva coinvolto numerosi uomini politici (Adenauer e poi Churchill) letterati (Rilke, Valery e Mann) scienziati (Einstein, Freud, Keynes) nel progetto paneuropeo, di ispirazione tecnocratica, che voleva l’unificazione economica e politica dell’Europa sotto forma di Confederazione con tutta una serie di istituti (Corte federale europea, un esercito europeo, una unificazione doganale progressiva, una moneta unica) e con una impostazione rispettosa delle diverse culture presenti in Europa e delle minoranze nazionali.
Tuttavia la natura imperialista di tale costruzione è evidente laddove Kalergi parla di sfruttamento a livello unificato delle colonie (confermando in parte la previsione di Lenin secondo cui “In regime capitalistico gli Stati Uniti d’Europa equivalgono ad un accordo per la spartizione delle colonie”). Inoltre Kalergi, in altre sue opere, accennava ad un modello di uomo, ricco di spirito ma privo di carattere che costituisse il materiale ideale per sviluppare una società cosmopolita, a dimostrazione della ispirazione elitaria del suo progetto che voleva la contaminazione tra razze e culture non per potenziare le capacità degli individui ma per indirizzarle all’ossequio mediocre dell’ordine costruito da una minoranza di competenti (dunque una contaminazione a presupposto razzista).
Per quanto riguarda il Manifesto di Ventotene c’è da dire che nell’introduzione si avverte il lettore dicendo che “Le circostanze anormali in cui tutto questo materiale fu prodotto, l’evolversi degli avvenimenti la cui precisa valutazione non poteva essere data dal confino, han fatto si che oggi si possono notare varie lacune, ed alcune parti possono anche considerarsi superate. Sarebbe forse bene riscrivere tutto da capo in modo da presentare cose completamente aggiornate. Ciò implicherebbe però un lavoro di mesi. Ma la vita politica italiana è stata ridotta dal fascismo come un arido deserto, e chi può dare un qualsiasi contributo che l’aiuti a rifiorire non deve perdere un minuto di tempo, specialmente nell’attuale tragica situazione. Meglio perciò pubblicare questi scritti quali sono, affidando agli studi successivi il compito di correggere e di aggiornare, meglio anche correre il rischio di dire qualcosa di sbagliato ma indicare agli Italiani smarriti ed incerti, almeno nelle sue grandi linee, la via da seguire, anziché tacere per un eccessivo desiderio di adeguatezza alla realtà attuale”.
E tuttavia pure in questa premessa la natura elitaria del progetto si avverte nel passo “ … indicare agli Italiani smarriti ed incerti, almeno nelle sue grandi linee, la via da seguire …”. Inoltre questo elitarismo si avverte anche nella rinuncia a formare un partito federalista e nel dire che “Il compito dei federalisti nelle attuali circostanze della nostra vita politica italiana deve essere invece quello di indicare ai partiti progressisti, i quali attirano su di sé le simpatie popolari, ma sono ancora più ricchi di fervore che di idee e propositi precisi, quali debbano effettivamente essere questi propositi e come ci si debba concretamente preparare a risolvere i problemi politici attuali. Non si tratta più di formare un partito federalista., ma di aiutare i partiti progressisti italiani a diventare federalisti”.
Nella Prefazione di Eugenio Colorni si dice che “Fu così che si fece strada, nella mente di alcuni, l’idea centrale che la contraddizione essenziale, responsabile delle crisi, delle guerre, delle miserie e degli sfruttamenti che travagliano la nostra società, è l’esistenza di stati sovrani, geograficamente, economicamente, militarmente individuati, consideranti gli altri stati come concorrenti e potenziali nemici, viventi gli uni rispetto agli altri in una situazione di perpetuo bellum omnium contra omnes”.
Qui possiamo individuare l’illusione che la contraddizione sia essenzialmente culturale e politica. Non si va nella dimensione in cui questi processi politici si formano e si consolidano, quella dimensione dove processi di accumulazione capitalistica ridisegnano attorno a sé la società e i territori, ma ci si ferma all’apparenza e si propongono soluzioni che tengono conto solo dell’apparenza.
Nella Prefazione, Colorni critica l’opzione internazionalista dicendo che “benché le analogie di regime interno possano facilitare i rapporti di amicizia e di collaborazione fra stato e stato, non è affatto detto che portino automaticamente e neppure progressivamente alla unificazione, finché esistano interessi e sentimenti collettivi legati al mantenimento di una unità chiusa all’interno delle frontiere”, ma si illude che l’ipotesi federalista sia un modo alternativo di costruire un ordine internazionale, quando esso va incontro agli stessi problemi e forse a problemi ancora maggiori visto che si vuole applicare a paesi con regimi diversi e sistemi sociali diversi (i quali, a detta proprio di Colorni, non sarebbero sufficienti nemmeno se fossero identici).
Colorni asserisce che “Tutti i problemi, da quello delle libertà costituzionali a quello della lotta di classe, da quello della pianificazione a quello della presa del potere e dell’uso di esso, ricevono una nuova luce se vengono posti partendo dalla premessa che la prima mèta da raggiungere è quella di un ordinamento unitario nel campo internazionale”. Egli però non motiva questo modo di vedere né si chiede se, per l’instaurazione di tale ordinamento, non si debba passare per uno o più dei problemi che invece con questo ordinamento si vorrebbero risolvere.
Egli poi aggiunge “Un altro motivo ancora — e forse il più importante — era costituito dal fatto che l’ideale di una Federazione Europea, preludio di una Federazione Mondiale, mentre poteva apparire lontana utopia ancora qualche anno fa, si presenta oggi, alla fine di questa guerra, come una mèta raggiungibile e quasi a portata di mano”.. E questo abbiamo visto come fosse in realtà un pio desiderio.
Ancora Colorni afferma che “Il nostro Movimento non è e non vuol essere un partito politico. Così come si è venuto sempre più nettamente caratterizzando, esso vuole operare sui vari partiti politici e nell’interno di essi, non solo affinché l’istanza internazionalista venga accentuata, ma anche e principalmente affinché tutti i problemi della sua vita politica vengano impostati partendo da questo nuovo angolo visuale, a cui finora sono stati così poco avvezzi”. Ecco che quindi ricompare la minoranza illuminata che opera sui e nei partiti politici.
Nel Manifesto vero e proprio (analizziamo in questo contesto anche una prima versione del Manifesto del 1943, perché a nostro parere essa rivela l’ideologia sottesa dei suoi estensori meglio di quella successiva e definitiva del 1944) si dice “L’ideologia dell’indipendenza nazionale è stata un potente lievito di progresso; ha fatto superare i meschini campanilismi in un senso di più vasta solidarietà contro l’oppressione degli stranieri dominatori; ha eliminato molti degli inciampi che ostacolavano la circolazione degli uomini e delle merci; ha fatto estendere, dentro al territorio di ciascun nuovo Stato, alle popolazioni più arretrate, le istituzioni e gli ordinamenti delle popolazioni più civili. Essa portava però in sé i germi del nazionalismo imperialista, che la nostra generazione ha visto ingigantire, fino alla formazione degli Stati totalitari ed allo scatenarsi delle guerre mondiali”.
Qui possiamo vedere come gli autori attribuiscano la nascita degli imperialismi ai nazionalismi, mentre l’analisi materialistica ipotizza che l’accumulazione di capitale ad un determinato livello condiziona il perimetro all’interno del quale il nazionalismo attecchisce e si sviluppa.
Inoltre si reitera l’atteggiamento paternalista tra culture quando si dice “ha fatto estendere, dentro al territorio di ciascun nuovo Stato, alle popolazioni più arretrate, le istituzioni e gli ordinamenti delle popolazioni più civili” (forse per giustificare la soggezione nella quale era tenuto il Meridione d’Italia?).
Nella seconda e definitiva versione del Manifesto non a caso non si parla più di nazionalismo imperialista ma di imperialismo capitalista, quasi a voler sfumare un presupposto teorico sbagliato.
Si parla anche di “spazio vitale” (l’espressione fatta propria dal nazifascismo per giustificare l’innesco del conflitto mondiale), quasi fosse una sorta di desiderio irrazionale di espansione (e quindi derubricandolo ad espressione di mera volontà politica), quando si tratta dell’espressione ideologica che si collega all’esigenza imperialistica che è interna alle contraddizioni del capitale, per il quale anche l’ambito della nazione diventa angusto ed oppressivo. Perciò la libera circolazione delle merci, che essi vedono solo come “fattore progressivo”, è allo stesso tempo uno dei momenti della dinamica imperialista nel momento in cui ad essa (post hoc e propter hoc) segue quella dei capitali.
Gli autori hanno buon gioco ad evidenziare come anche nei periodi di pace il funzionamento degli ordinamenti che loro definiscono “liberi” (e cioè scuola, scienza e produzione) sia indirizzato totalmente alla guerra. Essi però, come in altre parti dell’elaborato, si fermano alla superficie delle cose. Non vedono che la proiezione bellica è proprio insita nella dinamica imperialistica (e quindi economica) che vede capitalismi in competizione tra loro che trascinano le nazioni con sé (e non nazioni che subordinano la produzione alla guerra).
La guerra è nella sua accezione moderna un momento della fisiologia (che è dialetticamente una patologia) capitalistica. E la produzione non è affatto un ordinamento libero. Anzi, le modalità con cui si produce sono modalità militari, in quanto la fabbrica sin dal suo inizio (sin da quando si costringeva in Inghilterra a lavorare nelle fabbriche) è una istituzione totale.
E’ sintomatico come gli estensori del Manifesto attribuiscano tutti i mali all’iperbole politica, invece di guardare alla struttura economica: “Le madri vengono considerate come fattrici di soldati, ed in conseguenza premiate con gli stessi criteri con i quali alle mostre si premiano le bestie prolifiche; i bambini vengono educati fin dalla più tenera età al mestiere delle armi e all’odio verso gli stranieri, le libertà individuali si riducono a nulla, dal momento che tutti sono militarizzati e continuamente chiamati a prestare servizio militare; le guerre a ripetizione costringono ad abbandonare la famiglia, l’impiego, gli averi, ed a sacrificare la vita stessa per obbiettivi di cui nessuno capisce veramente il valore; in poche giornate vengono distrutti i risultati di decenni di sforzi compiuti per aumentare il benessere collettivo”.
Le madri sono fattrici di lavoratori e devono essere prolifiche per riprodurre “l’esercito” industriale di riserva. I bambini sono dalla più tenera età posti sul mercato del lavoro. Le libertà individuali sono nulla appena varcato l’ingresso della fabbrica. La produzione costringe ad abbandonare la famiglia ed a sacrificare spesso la vita per obbiettivi di cui nessuno capisce il valore. La guerra è l’immagine un po’ più brutta della matrice che la genera e cioè il modo di produzione capitalistico. Ma il Manifesto di Ventotene questa paternità la nega e anzi retoricamente ci disegna l’opposizione tra una produzione pacifica e una politica belligerante.
Anche quando si riferisce alla Germania, il quadro che fa il Manifesto riproduce uno stereotipo dove le considerazioni, fatte anche all’interno degli ideologi liberali (si pensi a Keynes), circa le responsabilità dei vincitori della Prima Guerra Mondiale nel determinare il trionfo del nazismo in Germania sono del tutto sottaciute.
Nella prima parte (“Crisi della società moderna”) ci sono anche analisi che si ricollegano alla tradizione socialista e che cercano di ricollegare il totalitarismo nazifascista alla oppressione delle classi diseredate, ma la tendenza elitaria ricompare quando si dice, all’inizio della seconda parte “Nel breve intenso periodo di crisi generale, in cui gli stati nazionali giaceranno fracassati al suolo, in cui le masse popolari attenderanno ansiose la parola nuova e saranno materia fusa, ardente, suscettibile di essere colata in forme nuove, capace di accogliere la guida di uomini seriamente internazionalisti …”
Troviamo poi anche un principio ambiguo (perché utilizzabile in molti modi) quando si dice “Assurdo è risultato il principio del non intervento, secondo il quale ogni popolo dovrebbe essere lasciato libero di darsi il governo dispotico che meglio crede, quasi che la costituzione interna di ogni singolo stato non costituisse un interesse vitale per tutti gli altri paesi europei”.
Questo principio, ripreso dall’antifascismo, è stato poi uno dei fattori ideologici che ha permesso le guerre Usa contro l’Iraq, la Serbia e la Libia. Non a caso questo principio è stato fatto proprio dal fondamentalismo neoliberista dei Radicali Italiani, che sono stati sempre in prima fila nel sostegno ideologico e politico alle guerre condotte da Usa ed Europa dopo il crollo del socialismo reale.
Singolare poi è la teoria sostenuta in questo passo dove si dice “Insolubili sono diventati i molteplici problemi che avvelenano la vita internazionale del continente: tracciati dei confini a popolazione mista, difesa delle minoranze allogene, sbocco al mare dei paesi situati nell’interno, questione balcanica, questione irlandese, ecc:, che troverebbero nella Federazione Europea la più semplice soluzione, come l’hanno trovata in passato i corrispondenti problemi degli staterelli entrati a far parte delle più vaste unità nazionali, quando hanno perso la loro acredine, trasformandosi in problemi di rapporti fra le diverse provincie”.
Infatti si pensa che l’unificazione europea contribuirebbe a risolvere i problemi interni a vari Stati, mentre la questione catalana è la dimostrazione che la tendenza alla concentrazione dei fattori produttivi – resa possibile dalla libera circolazione degli stessi a livello europeo (senza meccanismi di compensazione) – lacera ancora di più il circuito di solidarietà interno ai singoli Stati, a meno che qualcuno non riesumi il patriottismo nazionalista, per cui il processo di unificazione si configura come una sorta di fuga in avanti.
Fa sorridere ed inquietare l’atteggiamento degli estensori verso la democrazia. Essi combinano la critica al totalitarismo nazionalistico ad un atteggiamento minoritario ed illuministico che non può che mostrarsi scettico verso le possibilità dei popoli di autodeterminarsi. Infatti dicono “I democratici non rifuggono per principio dalla violenza, ma la vogliono adoperare solo quando la maggioranza sia convinta della sua indispensabilità, cioè propriamente quando non è più altro che un pressoché superfluo puntino da mettere sugli i. Sono perciò dirigenti adatti solo nelle epoche di ordinaria amministrazione, in cui un popolo è nel suo complesso convinto della bontà delle istituzioni fondamentali, che debbono solo essere ritoccate in aspetti relativamente secondari. Nelle epoche rivoluzionarie, in cui le istituzioni non debbono già essere amministrate, ma create, la prassi democratica fallisce clamorosamente. La pietosa impotenza dei democratici nelle rivoluzioni russa, tedesca, spagnola, sono tre dei più recenti esempi. In tali situazioni, caduto il vecchio apparato statale, con le sue leggi e la sua amministrazione, pullulano immediatamente, con sembianza di vecchia legalità o sprezzandola, una quantità di assemblee e rappresentanze popolari in cui convergono e si agitano tutte le forze sociali progressiste. Il popolo ha sì alcuni bisogni fondamentali da soddisfare, ma non sa con precisione cosa volere e cosa fare. Mille campane suonano alle sue orecchie, con i suoi milioni di teste non riesce a raccapezzarsi, e si disgrega in una quantità di tendenze in lotta tra loro”.
Il popolo per questi signori è sempre confuso. I milioni di teste li ossessionano ed hanno dunque bisogno di ridurre la complessità democratica con l’accetta.
Infine in questo passo si intravede la tendenza (in altre parti meno accentuata) di assimilare l’Urss alla situazione spagnola e tedesca, quasi rimpiangendo che il socialismo rivoluzionario russo non abbia avuto miglior sorte. E la critica alla burocrazia sovietica fa intravedere un’altra matrice astrattamente internazionalista, oltre quella del liberalismo ispirato dalla concezioni massoniche (si pensi a Briand e allo stesso Kalergi).
Non finisce qui. Il Manifesto aggiunge “Nel momento in cui occorre la massima decisione ed audacia, i democratici si sentono smarriti non avendo dietro uno spontaneo consenso popolare, ma solo un torbido tumultuare di passioni; pensano che loro dovere sia di formare quel consenso, e si presentano come predicatori esortanti, laddove occorrono capi che guidino sapendo dove arrivare” e ancora “La metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria”.
Giunti a questo punto, gli estensori del Manifesto si preparano a criticare il concetto marxista di lotta di classe ed affermano: “Man mano che i democratici logorassero nelle loro logomachie la loro prima popolarità di assertori della libertà, mancando ogni seria rivoluzione politica e sociale, si andrebbero immancabilmente ricostituendo le istituzioni politiche pretotalitarie, e la lotta tornerebbe a svilupparsi secondo i vecchi schemi della contrapposizione delle classi. Il principio secondo il quale la lotta di classe è il termine a cui van ridotti tutti i problemi politici, ha costituito la direttiva fondamentale, specialmente degli operai delle fabbriche, ed ha giovato a dare consistenza alla loro politica, finché non erano in questione le istituzioni fondamentali della società. Ma si converte in uno strumento di isolamento del proletariato, quando si imponga di trasformare l’intera organizzazione della società. Gli operai educati classisticamente non sanno allora vedere che le loro particolari rivendicazioni di classe, o di categoria, senza curarsi del come connetterle con gli interessi degli altri ceti, oppure aspirano alla unilaterale dittatura della loro classe, per realizzare l’utopistica collettivizzazione di tutti gli strumenti materiali di produzione, indicata da una propaganda secolare come il rimedio sovrano a tutti i loro mali. Questa politica non riesce a far presa su nessun altro strato fuorché sugli operai, i quali così privano le altre forze progressive del loro sostegno, e le lasciano cadere in balia della reazione, che abilmente le organizza per spezzare le reni allo stesso movimento proletario”.
Dunque, per gli estensori del Manifesto, gli operai ispirati al principio della lotta di classe non farebbero una politica delle alleanze e quindi non riuscirebbero a raggiungere il potere. Questo assunto falso (l’alleanza tra operai e contadini nella rivoluzione russa come si dovrebbe considerare?) serve per introdurre un più sostanziale interclassismo funzionale alla ideologia elitaria degli autori. Anche questo passo non a caso viene in buona parte espunto nella versione definitiva, ma rimane il passo in cui si dice “Il fronte delle forze progressiste sarebbe facilmente frantumato nella rissa tra classi e categorie economiche”, in cui compare un astratto politicismo che derubrica la lotta di classe a rissa.
Essi aggiungono “Questo atteggiamento rende i comunisti, nelle crisi rivoluzionarie, più efficienti dei democratici; ma tenendo essi distinte quanto più possono le classi operaie dalle altre forze rivoluzionarie – col predicare che la loro «vera» rivoluzione è ancora da venire – costituiscono nei momento decisivi un elemento settario che indebolisce il tutto”.
Non sapendo quali siano queste altre forze rivoluzionarie, ci meravigliamo di come gli estensori del Manifesto credano in una rivoluzione di qua da venire e critichino quelli che prudentemente parlano di una rivoluzione di là da venire. L’anticomunismo del Manifesto si rende evidente quando si dice “Ma anche i comunisti, nonostante le loro deficienze, potrebbero avere il loro quarto d’ora, convogliare masse stanche, deluse, assumere il potere ed adoperarlo per realizzare, come in Russia, il dispotismo burocratico su tutta la vita economica, politica e spirituale del paese. Una situazione dove i comunisti contassero come forza politica dominante significherebbe non uno sviluppo in senso rivoluzionario, ma già il fallimento del rinnovamento europeo”.
Anche questo passo viene omesso nella versione definitiva (probabilmente si sceglie un atteggiamento più sfumato verso il partito comunista italiano per quanto Altiero Spinelli fosse stato espulso dal Pci nel 1937).
Tuttavia la crescente inclinazione di Spinelli verso il liberismo (complice la lettura di Luigi Einaudi, che già dal 1893 parlava di Stati Uniti d’Europa e che, con lo pseudonimo Junius, nel 1920 aveva scritto delle lettere sull’unificazione europea) è evidente quando si dice “Le gigantesche forze di progresso che scaturiscono dall’interesse individuale, non vanno spente nella morta gora della pratica routinière per trovarsi poi di fronte all’insolubile problema di resuscitare lo spirito d’iniziativa con le differenziazioni nei salari, e con gli altri provvedimenti del genere; quelle forze vanno invece esaltate ed estese offrendo loro una maggiore opportunità di sviluppo e di impiego, e contemporaneamente vanno consolidati e perfezionati gli argini che le convogliano verso gli obbiettivi di maggiore vantaggio per tutta la collettività”
Gli autori sognano un’alleanza tra la classe operaia e gli intellettuali, che eviti agli intellettuali una sorta di impotenza sociale e agli operai di appiattirsi sul classismo dottrinario, senza notare che la classe operaia aveva già nei suoi gruppi dirigenti intellettuali di alto livello e che, nel frattempo, Antonio Gramsci aveva già delineato un modello di intellettuale collettivo (proprio quel partito che gli elitari del Manifesto trattavano con ingiustificata supponenza).
Questa parodia di un bolscevismo in giacca e cravatta così conclude: “Durante la crisi rivoluzionaria spetta a questo partito organizzare e dirigere le forze progressiste, utilizzando tutti quegli organi popolari che si formano spontaneamente come crogioli ardenti in cui vanno a mischiarsi le forze rivoluzionarie, non per emettere plebisciti, ma in attesa di essere guidate. Esso attinge la visione e la sicurezza di quel che va fatto, non da una preventiva consacrazione da parte della ancora inesistente volontà popolare, ma nella sua coscienza di rappresentare le esigenze profonde della società moderna. Dà in tal modo le prime direttive del nuovo ordine, la prima disciplina sociale alle nuove masse. Attraverso questa dittatura del partito rivoluzionario si forma il nuovo stato ed attorno ad esso la nuova democrazia. Non è da temere che un tale regime rivoluzionario debba necessariamente sbocciare in un nuovo dispotismo. Vi sbocca se è venuto modellando un tipo di società servile. Ma se il partito rivoluzionario andrà creando con polso fermo fin dai primissimi passi le condizioni per una vita libera, in cui tutti i cittadini possano veramente partecipare alla vita dello stato, la sua evoluzione sarà, anche se attraverso eventuali secondarie crisi politiche, nel senso di una progressiva comprensione ed accettazione da parte di tutti del nuovo ordine, e perciò nel senso di una crescente possibilità di funzionamento di istituzioni politiche libere”.
Nella versione definitiva a “questo partito” si sostituisce “questo movimento”, aumentando nel lettore l’impressione di un pasticcio. Non si vuole fare il partito per velleità di entrismo, ma al tempo stesso si pretende di dirigere senza imporsi a propria volta una organizzazione. Il Manifesto di Ventotene, contrariamente a quello di Marx, invece di abbandonare la dissimulazione, intende perpetrarla rifiutando un contatto diretto con le masse e nascondendosi nelle istituzioni che pure considera compromesse dalla guerra.
Perché tale ingenua e presuntuosa visione delle cose potesse avere il suo infelice successo, si è dovuto aspettare che essa si piegasse alla Forche Caudine del nascente imperialismo europeo, quell’imperialismo che essa vedeva solo nei cosiddetti totalitarismi e che invece si fa presente anche nelle democrazie liberali sempre meno democratiche e sempre meno liberali.
*Rete dei Comunisti
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa