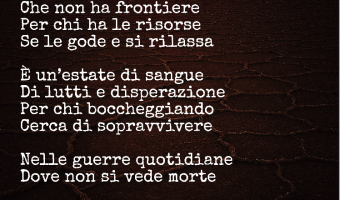Vogliamo ricordare i trenta anni trascorsi dai massacri di Sabra e Chatila ripubblicando un articolo di Stefano Chiarini che caparbiamente, per anni e riuscendo a coinvolgere persone e istituzioni sia in Libano e in Italia, ha fatto sì che la fossa comune, dove vennero seppelliti i palestinesi dopo le stragi del 1982, diventata una discarica, fosse invece ripulita e trasformata in sacrario. Oggi a Beirut si svolge la manifestazione per ricordare Sabra e Chatila, anche quest’anno è presente una folta delegazione italiana, un’altra eredità preziosa del lavoro di Stefano (il primo a sinistra nella fotografia).
******
Chatila non dimentica
di Stefano Chiarini
«Perché mai il nostro unico compito/ dovrebbe essere quello di scavare tombe?/ …quanto profondo è tutto questo sangue». I versi del poeta palestinese Mahmoud Darwish, scritti su un vecchio manifesto di una delle tante organizzazioni non governative (ong) che cercano di alleviare la tremenda miseria dei campi, ben rappresentano l’esasperazione degli oltre 300.000 profughi palestinesi in Libano che si preparano a ricordare, il prossimo 16 settembre, il ventesimo anniversario del massacro di Sabra e Chatila.
Mai la tensione nei campi profughi, e più in generale in Libano, è stata così alta negli ultimi anni. Le minacce di una nuova guerra Usa all’Iraq, alla Siria, al Libano, un crescendo di episodi di violenza nei campi del sud e nella Beqaa, ma soprattutto le discriminazioni di cui sono vittime e il silenzio del mondo sui loro morti e sullo strazio dei loro diritti ha portato i rifugiati ad una cupa esasperazione ormai pronta ad esplodere.
«Da quindici giorni – ci dice Amina, una ragazza di vent’anni di Chatila – i media internazionali parlano delle 3.000 povere vittime dell’11 settembre e della necessità che sia resa loro giustizia, ma chi ricorda i nostri 3.000 morti di Sabra e Chatila? Come mai, se c’è questo senso di giustizia, il responsabile di quell’eccidio, Ariel Sharon, è invitato alla Casa bianca e definito da Bush “uomo di pace”?».
I fratelli di Amina annuiscono in silenzio guardandola con ammirazione. Poi dopo una breve pausa, mentre da dietro una tenda che divide in due l’unica stanza della casa dai muri verdi di muffa compare una sorella più piccola con un vassoietto col tè, uno di loro continua: «Perché tutti considerano normale che gli ebrei, dopo 2.000 anni, siano voluti tornare in Palestina mentre quelli di noi che, dopo appena 50 anni, vogliono fare altrettanto e si rifiutano di marcire in questi campi vengono definiti terroristi o estremisti?» «C’è chi innalza palazzi e chi scava tombe», sentenzia amara un’anziana parente, seduta nelle semioscurità.
I profughi vivono in una sorta di permanente, surreale incertezza fra il passato in patria, «il paese del latte e del miele», e il futuro «del ritorno» a dispetto di tutte le contingenze. L’ospedale di Sabra, ridotto ad uno scheletro di cemento dove vivono in piccole celle centinaia di famiglie con soli quattro bagni ogni piano e un lavello per i piatti e i panni, immerso nell’oscurità di pallide lampadine, si chiama non a caso «Gaza»; l’altro nosocomio vicino all’ambasciata del Kuwait, «Akko».
Sui muri delle case, foto ingiallite dei villaggi di origine mentre nelle vecchie scatole di metallo per i biscotti viene conservato tutto ciò che un giorno potrebbe essere utile a rivendicare la proprietà di terreni, case, beni mobili e immobili. In alcuni casi fanno la loro comparsa anche vecchie e grosse chiavi arrugginite: di casa, del magazzino, dell’ufficio, del negozio. Come se una chiave o persino un contratto di proprietà avessero un qualche valore davanti alla canna di un fucile quando il mondo guarda altrove.
Questo ventesimo anniversario è per certi versi ancora più amaro e triste di quelli che l’hanno preceduto, non solo per i ricordi personali delle 3.000 vittime massacrate dai falangisti sotto la supervisione dell’esercito israeliano tra il pomeriggio del 16 e la mattina del 18 – anziani, donne e soprattutto bambini torturati, menomati, in alcuni casi tagliati a fettine e poi ricomposti sulle tavole a mo’ di dolci – ma anche per il fatto che tutto, a vent’anni di distanza, sembra di nuovo ripetersi.
Una veloce lettura degli eventi di quei terribili giorni del 1982 non lascia dubbi sulle responsabilità internazionali, proprio come oggi. I combattenti palestinesi si erano ritirati da Beirut alla fine di agosto in cambio dell’impegno sottoscritto dal governo israeliano con l’inviato Usa Philip Habib, di non entrare a Beirut ovest.
I soldati americani, francesi e italiani, arrivati il 21 agosto, avrebbero vigilato sul mantenimento degli impegni presi da Israele. Invece, ritiratisi i fedayin, gli Usa decisero un ritiro anticipato di 15 giorni, lasciando i campi alla mercé degli israeliani.
Sharon l’11 settembre dichiarò che a Sabra e Chatila «ci sono ancora 2.000 terroristi».
Martedì 14 venne ucciso Bechir Gemayel, il presidente falangista libanese alleato di Israele, mercoledì 15 l’esercito israeliano entrò a Beirut ovest e circondò i campi affidando ai falangisti la loro «ripulitura».
Giovedì 16 iniziò il massacro che sarebbe durato fino a sabato 18.
Lunedì 20 Reagan annunciò il ritorno delle forze multinazionali incaricate di «proteggere i palestinesi».
La strage era compiuta e la coscienza dell’Occidente salva.
*Stefano Chiarini, giornalista del manifesto ed esperto di Medio Oriente, è morto il 3 febbraio 2007. Questo articolo è stato pubblicato il 12 settembre 2002
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa