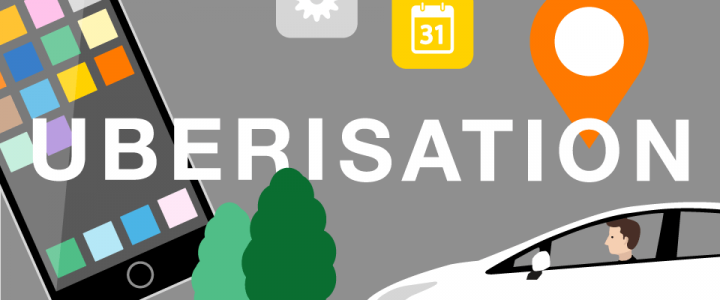Uberizzazione: Trasformazione di servizi e prestazioni lavorative continuativi, propri dell’economia tradizionale, in attività svolte soltanto su richiesta del consumatore o cliente, oppure adozione o imitazione del modello di attività economica caratteristico della multinazionale Uber.
Sono le definizioni che ad esempio il sito internet della Treccani, editrice del famoso vocabolario, propone rispetto ad un neologismo evidentemente ispirato ad uno dei più importanti protagonisti della cosiddetta sharing economy.
Parlare di uberizzazione oggi significa parlare di un fenomeno sociale di portata globale, tale da influenzare scelte di politica nazionale e sovranazionale relative al tema del lavoro.
Ad esempio, come non citare l’ex ministro Poletti, che nel corso di un convegno alla Luiss (eravamo a fine 2015) dichiarò: “Dovremmo immaginare contratti che non abbiano come unico riferimento l’ora-lavoro. L’ora di lavoro a fronte dei cambiamenti tecnologici è un attrezzo vecchio” .
Una bella dichiarazione di intenti, da parte di un ministro del lavoro.
L’idea di definire e quantificare la prestazione lavorativa in base al risultato, alla richiesta del consumatore/cliente, o – perchè no – del datore di lavoro, è stata introdotta partendo dal principio della “disintermediazione”: eliminando intermediari, si ottimizza la realizzazione del servizio.
Un po’ la ragione d’essere di Uber: rispondere alla necessità di spostarsi da un punto A ad un punto B. Fine. Tutto il resto non conta.
E le caratteristiche professionali del conducente? L’elemento di garanzia della qualità del servizio? Le garanzie, anche legali, di sicurezza? Tutto secondario. Tralasciando ovviamente – ormai orpello novecentesco! – le condizioni del lavoratore sotto tutti i punti di vista (salario, orari, stress).
Caratteristica tipica, in generale, della sharing economy: “socializzare” competenze, conoscenze, addirittura beni immobili (airbnb) garantendo da un lato la soddisfazione di una esigenza da parte del consumatore, dall’altro l’ottenimento di un compenso/reddito (assolutamente occasionale) da parte dell’improvvisato imprenditore/datore di lavoro (spesso di se stesso).
Chi scrive ha vissuto in prima persona l’esperienza di “albergatore occasionale” – il precariato e la disoccupazione sono cause pressoché perfette di diffusione degli strumenti della sharing economy – e la consapevolezza dell’estrema volatilità del rapporto cliente/venditore (e lavoratore) è assolutamente chiara.
La convinzione di essere finalmente artefici del proprio destino professionale, di essere tutti potenziali imprenditori sostanzialmente di sè stessi, è il volano di un sistema economico che in realtà ha come primo risultato quello di molecolizzare l’attività lavorativa, dinamicizzarla rendendola liquida e – cosa più importante – abbattere costi e massimizzare profitti (come sempre).
Eh si, perché se abbandoniamo la retorica del “tutti siamo imprenditori”, dell’ “ottimizzazione del rapporto tra domanda ed offerta” e dei vantaggi offerti dalla disintermediazione, quando parliamo di Uber – ad esempio – parliamo di una multinazionale valutata 48 miliardi di dollari nel 2017 che opera in 77 nazioni nel mondo. Non male, no?
Ormai il termine – ed il concetto – di “Uberizzazione” è diventato mediaticamente abbastanza diffuso, abbracciando fattispecie anche diverse tra loro, ma riconducibili tutte a questo nuovo paradigma di lavoro liquido, più rivolto all’ottenimento di un risultato che al classico rapporto tempo/lavoro che determina poi anche il salario.
Una recente inchiesta di un giornale online francese, Mediapart, approfondisce il concetto di Uberisation attraverso esempi pratici, tra i quali ad esempio inserisce anche Amazon e la sua gestione del lavoro e dei lavoratori. In questo caso il modello non è esattamente quello che viene in mente pensando ad Uber o ad Airbnb: nel caso della multinazionale di Jeff Bezos – ascoltando le testimonanze di molti lavoratori – il modello di riferimento appare quello classico della “catena di montaggio” in cui l’operaio ha il tempo contingentato e calcolato per ogni operazione, e guai a sgarrare. Insomma, nuove e vecchie usanze, tutte buone per fare profitto sulla pelle del lavoratore.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa