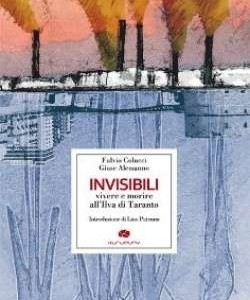Invisibili. Vivere e morire all’Ilva di Taranto
Circa vent’anni fa Emilio Riva ebbe in regalo dallo Stato l’ILVA di Taranto, e vi impose il suo ordine.
Si liberò del vecchio blocco operaio – forte, cosciente, compatto – sostituendolo con giovani desindacalizzati, e ci riuscì con una certa destrezza, barattando il prepensionamento dei vecchi con l’assunzione dei loro figli. Spezzò le ultime resistenze sindacali di quella che fu l’orgoglio della forza operaia del sud, rinchiudendo i riottosi nella palazzina LAF, in un casermone vuoto, a guardare i muri spogli.
Riva si inventò molto prima dell’era Marchionne “la fabbrica del futuro”, in realtà molto più simile alle ferriere del primo ‘900, se non fosse che rispetto ad allora la soggettività operaia è più debole. Cosa è successo in seguito dentro l’ILVA dei Riva ce lo raccontano Fulvio Colucci e Giuse Alemanno, con una cronaca redatta alla vigilia delle ultime vicende giudiziarie.
“…Mi ha confessato di essere in cura dallo psicologo perché i capi lo martellano. Mi ha detto: Sai, ho sfiorato il suicidio. I deboli sono sotto pressione. Sanno che possono essere presi di mira. Chi è più debole non reagisce nei confronti dei capi, finisce per fare sedici ore di lavoro. Dice che ha sentito una voce, che si è visto sull’orlo del burrone. Che ha avuto paura di perdere l’equilibrio sulla passerella”. “Non mi davano niente da fare per tutto il giorno quando ero in punizione….. ma mi nascondevo perché alla fine potevano chiedermi: perché non lavori ? E la colpa sarebbe ricaduta su di me. Volevano che li seguissi come un cane. Ma io non sono un cane.”
Non è un ricordo dei tempi della palazzina LAF, è la realtà di oggi. Nonostante la condanna per mobbing, Riva non ha cambiato metodi. Del resto perché dovrebbe ? Funzionano !!!
Gli operai descritti da Colucci trasudano rassegnazione, paura, rimozione del loro vissuto, diffidenza verso tutto ciò che è esterno, rancore verso la “città”, indifferente alla loro condizione, ai loro morti. Rancore in parte giustificabile, se si pensa che patron Riva s’è comprato mezza Taranto: istituzioni, clero … .L’altra mezza no … non quella che porta i figli avvelenati dall’ILVA ad oncologia pediatrica. Rancore, dicevo, giustificabile solo in parte, perché è come se gli operai intervistati si aspettino che la loro salvezza debba venire da fuori dei cancelli dell’ILVA, e non da una propria assunzione di responsabilità, dalla presa d’atto che se non sono loro i primi a prendere nelle mani il loro futuro difficilmente qualcuno lo farà al loro posto.
Se togli le eccezioni – di cui sto libro non parla – la maggioranza tace (“se si sa che parli all’esterno, il primo sbaglio che fai, paghi”). E questo non le fa onore, anche a fronte del disastro ambientale che il siderurgico riversa sulla città. Ad alzare la voce sono padri e mogli degli operai ammazzati. Una lotta per la giustizia condotta con poca solidarietà, scontrandosi contro un muro di gomma: “Dì ai ragazzi che la vita di mio figlio vale un anno di carcere con pena sospesa. Anzi, dì loro che in galera, dai e dai, ci finirò io”. Una lotta che nasce fuori dalla fabbrica da chi ha trovato il coraggio dopo aver perso ciò che amava di più. Non nasce dall’interno, non nasce prima che ci scappi il morto.
“Mai un giovane lavoratore si lamenterà perché l’azienda infrange le regole, anzi: A disposizione – raccontano – c’è tutto quello che la legge prevede dal punto di vista della sicurezza personale: dal casco, alla tuta, ai guanti”. Strana concezione della sicurezza: i dispositivi di protezione individuale – secondo le leggi e la scienza antinfortunistica – dovrebbero essere l’ultima precauzione da prendere, dopo aver agito sull’organizzazione del lavoro, sulla sicurezza intrinseca degli impianti, sulla salubrità degli ambienti.
Nulla di questo c’è all’ILVA: “I lavoratori dell’appalto sembrano gli ultimi degli ultimi, a volte vedo capisquadra che che approfittano di quelli delle ditte sottomettendoli. C’è chi lavorava con i jeans, chi ha indossato la tuta marrone. Con la polvere, di notte, è ancora più invisibile. Rischia di essere schiacciato da camion e auto…. Ora stanno lì: africani, indiani, turchi. Lavorano indossando quello che trovano: entrano nel forno, smantellano i refrattari, senza maschere. E’ venuta l’ASL, ha fatto i controlli. L’amianto è stato smantellato da un’azienda specializzata. Gli extracomunitari sono andati allo sbaraglio. Il forno è diventato una torre di babele ed è pericoloso, se non ci capiamo”.
“Io ogni giorno faccio cinque chilometri a piedi, con la polvere; certe volte mi esce il sangue dal naso perché la polvere nel naso si indurisce. … Arriviamo allo spogliatoio divorati dalla polvere, la polvere è come una estrema unzione.”
“Mi hanno impressionato i lavoratori sulle passerelle a 90 metri di altezza. Vai giù e nemmeno ti accorgi che sei morto. … Agli ingegneri segnaliamo tutto. I carriponte sono pericolosi, rischiano di cadere con un peso di 50 tonnellate. Se cadono è una strage.…Chi si trova sul fronte del fuoco, o ad altezze così è più chiuso, non ha voglia di parlare. Mi sono trovato vicino alla ghisa liquida quando prende fuoco, una bomba che fa tremare tutto in un raggio di chilometri. Lo scoppio è improvviso, lo senti davvero nelle viscere. Ti stordisce, ti afferra, ti svuota” .
Le conseguenze di questa situazione si vedono, o meglio si contano: 45 infortuni mortali dal 1993, l’ultimo – Claudio Marsella – due giorni fa .Gli autori ricordano Silvio Murri, Paolo Franco, Pasquale D’Ettorre, Antonio Alagni, Gjoni Arjan, in rappresentanza di una lunga serie di lutti.
Come dicevo, il libro non parla di chi fra gli operai ha alzato la testa, di quelli come Massimo Battista, che Insieme ad altri colleghi venne licenziato il 7 luglio del 2005 per aver promosso uno sciopero sulla mancanza di sicurezza. Nel 2007 il giudice ne dispose il reintegro, e da allora è stato confinato in una struttura lontana dallo stabilimento a “contare le barche che passano”. Massimo, assieme ad altri, ha fondato il “Comitato Cittadini e Lavoratori liberi e pensanti”, ha rotto il muro di silenzio per voltare pagina su un’altra storia. Potessi suggerire un titolo la chiamerei : “VISIBILI: vivere e lottare all’ILVA di Taranto”.
Il libro:: Fulvio Colucci e Giuse Alemanno, Invisibili. Vivere e morire all’Ilva di Taranto, Edizioni Kurumuny, 2011, 111 p.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa